
LUIGI ARMANDO OLIVERO

Disegno di Giuseppe Macrì da Rondò dle masche L'Alcyone Roma, 1971
Rondò dle masche L'Alcyone, Roma, 1971
Ij faunèt Il Delfino, Roma, 1955
Articoli di Giovanni Delfino riguardanti Luigi Olivero pubblicati su giornali e riviste
Le poesie di Luigi Armando Olivero (Seconda parte)
Le poesie di Luigi Armando Olivero (Terza parte)
Poesie di Luigi Olivero dedicate allo sport
COMMENTI E DIVAGAZIONI IN MARGINE ALLA POESIA DI OLIVERO
“VEN L’ORA…”
La poesia “Ven l’ora“ viene riportata in due volumi di poesie di Olivero tra i più conosciuti e diffusi: rispettivamente “Rondò dle masche” e “Romanzìe”. (1) Ma, mentre nella raccoltà “Rondò” la poesia ha per titolo quello appena richiamato “Ven l’ora” e una data di composizione riportata in calce [1961], in “Romanzìe” il titolo diventa “ Stàtua ‘d sënner” e non si fa riferimento ad alcuna data di composizione. (2)
In realtà la poesia e sempre quella e non presenta altre diversificazioni nel testo: semplicemente si può dire che essa non possiede un titolo suo proprio: nel primo caso “Ven l’ora” , il titolo improvvisato, è tratto dalle prime parole del primo verso, in “Romanzìe” invece il titolo riporta le prime parole dell’ultimo verso.
Il contenuto della poesia fa riferimento alla presa di coscienza da parte dell’Uomo del limite della natura umana: il poeta nella stesura del testo non parla in prima persona, ma utilizza una forma impersonale come se fosse tutta l’Umanità a parlare, a nome di tutti e di ciascuno. L’uomo nel momento in cui prende coscienza di sé stesso, cioè si “autoidentifica”, prende coscienza del suo “limite”. Occorre appena fare una annotazione: il prendere coscienza del “limite” porta così' la presa di coscienza della propria “grandezza”: grandezza e limite, nell’uomo, sono due facce della stessa medaglia. “Grandezza” e “limite” sono stati in passato punti di riferimento a cui ispirare i comportamenti tra i singoli individui e tra i popoli. Due filosofi greci, vissuti tra il secondo ed il primo secolo avanti Cristo, Panezio di Rodi e Posidonio di Apamea, rispettivamente maestro ed allievo, hanno elaborato il concetto di “Humanitas” da valere per il mondo greco-latino e per tutta l’umanità.. Non a caso i nostri due filosofi pur essendo greci di nascita avevano viaggiato molto in occidente e soggiornato a Roma. Il loro pensiero rappresenta pertanto un punto d’incontro, per quello che qui a noi interessa, tra la civiltà greca e quella romana, ma anche un punto di arrivo per quello che riguarda la fusione di quelle due civiltà a proposito dell’ “uomo”.
Ed è il concetto di “Humanitas” che a noi interessa: che cosa è dunque humanitas? Possiamo fornire questa definizione un po’ approssimativa ma sempre valida: “humanitas” consiste nel conformare, adeguare i propri comportamenti ed i propri atteggiamenti nei confronti di chi ci sta davanti in funzione della consapevolezza, della presa di coscienza, della “grandezza” e del “limite” nostro e della coscienza della “grandezza” e del “limite” di chi ci sta di fronte. Questo atteggiamento ha da valere per i rapporti tra i singoli, i popoli, le nazioni, le etnìe. Solo con l’avvento del Cristianesimo, circa un secolo e mezzo dopo, questo concetto verrà superato : il Cristianesimo dice che i rapporti tra gli uomini devono essere regolati dall’ “Amore” e ad esso improntati (Amore anche per i nemici): rispetto al mondo greco-latino si tratta di un salto di qualità. Ma “humanitas” rappresenta comunque a questo riguardo un punto di arrivo per il mondo classico greco-latino. Quando noi parliamo di Umanesimo, di “studi umanistici”, quando sentiamo dire: “quella persona ha fatto degli studi Umanistici”, noi pensiamo “avrà fatto intanto il Liceo Classico e poi magari studi di letteratura greco–latina o simili, ma la parola “Umanistico”, comunque applicata, deriva proprio da quel concetto di “humanitas” elaborato da Panezio di Rodi e Posidonio di Apamea, punto di arrivo, a cui tutto gira attorno nella civiltà greco-latina.
Abbiamo detto che per l’uomo coscienza di “grandezza” e di “limite” vanno in conseguenza della propria autoidentificazione. (vedere a questo riguardo il mio commento alla poesia crocifission en reusa più oltre il questa stessa pagina)
Molti filosofi hanno dissertato sulla validità della conoscenza dell’uomo che porta come conseguenza la presa di coscienza della propria esistenza. Fra tutti mi piace ricordare qui il buon Cartesio con il suo famoso detto: cogito, ergo sum [penso, dunque “esisto”]. Ma Cartesio nella fretta, diciamo così, di “agguantare almeno una certezza incrollabile” riguardo alla validità della conoscenza umana, con il legare assieme il “pensiero” e l’”esistenza” sembra aver dimenticato, o forse per lui era sottinteso, un passaggio importante in sequenza: “penso”: come prima conseguenza “mi autoidentifico” e poi … e poi .. e poi... e già … “esisto” !!
Ma nel prendere coscienza di se stesso e della sua esistenza l’Uomo si comporta un po’ come un Computer diremmo “di ultima generazione” in grado di fare autodiagnosi ed autocritica. Il computer è un prodotto dell’intelligenza umana, che ha inventato qualcosa di vagamente simile alla propria “natura”; oggi procede a grandi passi lo studio e l’elaborazione di una intelligenza artificiale, che dovrebbe sostituire l’uomo, ma è prevedibile qualche intoppo.
L’Uomo è un’ “entità” complessa, proprio come un Computer, costituita da vari componenti.
L’ “alimentatore” che fornisce e distribuisce energia a tutta l’ “apparecchiatura”; nel caso dell’uomo l’alimentatore lo chiameremo così: “il corpo fisico”, poi, a parte la “memoria”, c’è quella che in gergo si chiama la CPU, l’“unità di programmazione centrale” del computer, cioè la parte hardware in grado di far girare i programmi . I programmi, di provenienza esterna, costituiscono il software, e sono studiati ed ottimizzati a seconda dell’utilizzo che si vuole fare del computer e dei risultati che da esso si vogliono ottenere. Per l’Uomo la CPU, l’unità di programmazione centrale, è il cervello, che da una parte è sostenuto e “alimentato” dal corpo e dall’altra parte è in grado, (quando tutto funziona) di far girare il software .
Nella tecnica dei computer, parte del software è in grado, entro certi limiti, di controllare l’ hardware, fare autodiagnosi di malfunzionamento dell’alimentatore, dell’ unità di programmazione e provvedere eventualmente a delle autoregolazioni.
Ma per l’Uomo, a questo punto, al contrario del Computer (inventato dall’uomo quasi a sua immagine e somiglianza) nasce un problema grandissimo e, vedremo, insormontabile.
Il software che gira nel cervello umano, se tutto funziona, ha capacità tali che vanno al di là di quello che si può normalmente arguire o inventare per un software da computer, quantunque evoluto: il software associato al cervello umano, ha capacità di attingere all’Infinito; e non è solo il vago infinito spazio-tempo di cui parla Leopardi nella sua poesia, ma è l’Infinito inteso come Causa Efficiente senza la quale, l’uomo sa, si rende conto, che non riuscirebbe mai a spiegare la sua esistenza, e neppure quella dell’Universo che lo circonda, né spiegare come mai, ad esempio, l’Universo esista da circa 17 miliardi di anni – abbia avuto inizio con il Big-Bang – che non sappiamo bene cosa sia stato - ma sappiamo che prima del Big-Bang l’Universo non c’era. Che cosa c’era? Eh…eh..!! non lo sappiamo. Ma intanto l’Uomo riesce anche a definire, con calcoli e metodi scientifici e fisici, che l’Universo che noi conosciamo, come ha avuto inizio più o meno 17 miliardi di anni fa, avrà una fine, almeno così come noi lo conosciamo, tra circa 17 miliardi anni: saremmo quindi oggi grosso-modo in base a calcoli approssimativi dell’ entropìa totale dell’ Universo (la quantità di energia totale nell’ Universo ancora disponibile e da trasformare in calore) a circa metà del tempo di esistenza dell’ Universo così come noi lo conosciamo.
A questo punto della storia razzolando e razzolando, alla maniera ruspante, siamo finiti fuori tema rispetto all’assunto che era quello di commentare una poesia di Olivero? Va bene, allora facciamo pausa.
Parlando di queste cose, di fisica e di astrofisica, non posso fare a meno di ricordare una battuta di un mio vecchio professore: “ah – diceva - che cosa credete che pensi la gente a proposito di questa aula dove noi ci troviamo?” La gente che passa e legge “Aula di Fisica” pensa più o meno così “Ah… in quell’aula lì si fa la “Fisica”? – quindi lì dentro fanno “ballare i tavolini ” .
Ma oggi i tempi sono cambiati, la scuola è molto più seria, queste insinuazioni non si sentirebbero più e altrimenti suonerebbero fuori luogo-
L’Uomo dunque facendo girare nel suo cervello il software, che la Natura gli ha dato si potrebbe accorgere, fra l’altro, che la negazione di una causa efficiente non potrebbe condurlo alla spiegazione valida di nulla di ciò che sta vedendo e valutando, proprio come quel filosofo greco dell’antichità - Democrito il quale sosteneva che tutto ciò che è nell’Universo e lì per caso, da un incontro casuale di atomi che cadendo gli uni sugli altri e scontrandosi tra loro con una certa inclinazione ( il clinamen - diceva Democrito) hanno dato origine a tutto l’Universo. E’ chiaro che questa tesi (che magari a qualcuno potrebbe sembrare suggestiva), non porta da nessuna parte. Senza ammettere l’esistenza di una Causa Efficiente [che abbia inoltre in sé la sua ragion d’essere] non mi spiegherò mai in maniera soddisfacente perché l’Universo per intanto adesso esiste, ha avuto un giorno inizio e un giorno finirà
Ma questo software così complesso che gira nel cervello umano (supposto mediamente funzionante) oltre che a far prendere all’Uomo coscienza dell’Universo [Finito] in cui egli è proiettato, lo obbliga a prendere coscienza dell’esistenza di altri uomini, simili a sé, con le stesse caratteristiche di hardware e di software, le stesse aspettative di Infinito e con le stesse tensioni nel voler raggiungere risultati soddisfacenti per la propria esistenza e la propria felicità. Ma qui ci si accorge che i propri interessi vanno facilmente “in conflitto” con gli interessi del vicino, qui incomincia a sentirsi il peso di ciò che è “finito” che porta verso terra quella tensione di fondo verso l’Infinito.
Qui, nella vita di relazione incomincia la presa di coscienza del limite da parte dell’Uomo: non è il software che non funziona: il software che gira nel cervello umano, e che ha natura diversa da tutto il resto del computer si rende conto che il supporto è inadeguato, è fasullo (non come avviene per i computer di casa, computer dove hardware e software volendo, si sposano egregiamente e non creano problemi se la loro armonizzazione è preventivamente ben progettata).
Per l’Uomo (ecco il mistero) la parte fisica, il corpo ed il cervello non sono armonizzabili appieno con le potenzialità di ciò a cui il cervello è in grado di attingere. C’è un limite oltre al quale non si va.
E’ questo misterioso software, esso stesso, che ha natura qualitativamente, intrinsecamente, sostanzialmente diversa dall’ hardware che lo sostiene. Ed è questo hardware che risulta pertanto inadeguato e “non compatibile”. Ed è questo software che fa sì che l’ Uomo si renda conto che qualcosa non va. Ma l’Uomo non riesce a far fronte alle anomalie riscontrate: non è cioè in grado di soddisfare adeguatamente alle proprie aspettative materiali ma anche e sopratutto dello Spirito che potrebbe farlo volare più alto.
Ecco in che cosa consiste la coscienza del limite. E quali sono queste fonti di anomalia? Intanto il corpo, componente necessario, che funge da alimentatore, ma anche da zavorra, con la sua intima struttura complessa di nervi e di muscoli e di ossa - dice il poeta - che sì, se funzionano sono di valido aiuto al funzionamento del cervello e del Pensiero, ma spesso sono di peso, perché troppo soggetti a guasti e malfunzionamenti, ed un piccolo malfunzionamento del corpo può provocare grave pregiudizio al corretto funzionamento del cervello che presiede alla gestione di quel software mostruoso, inesauribile e assettato di Infinito. Il funzionamento corretto del cervello stesso, oltre che dal corpo che lo alimenta, può essere negativamente influenzato da guasti che riguardano il cervello stesso, e che aumentano in genere in maniera esponenziale con il passare del tempo e l’avanzare dell’età. Il trascorrere del tempo: ecco il vero tradimento per la natura della mente umana oltre alla limitazione intrinseca del corpo e del cervello.
Tutto ciò che stiamo raccontando sta dentro il testo della poesia di Olivero: la coscienza del limite scaturisce dal guardare dapprima dentro se stessi, poi confrontare quello che noi vediamo e speriamo per noi stessi con quello che gli altri uomini vedono e sperano per se stessi: contrasti di interessi ed aspettative, in fondo uguali per tutti, che tarpano le ali al raggiungimento dei propri obiettivi, le difficoltà di instaurare pertanto con gli altri uomini validi rapporti affettivi, di relazione e di collaborazione pur nel tendere agli stessi obbiettivi, essendo gli uomini incatenati tutti alla stessa catena. E’ il denominatore comune a cui fanno riferimento tutti gli uomini impedisce a tutti e a ciascuno una diversificazione vera. Il volare alto è impedito dal limiti materiali effettivi imposti all’uomo dalla Natura. Dice il poeta Tu vorresti vivere di altre vite, di altre esperienze, immedesimarti con la Natura che ti circonda, qui il poeta fa riferimento ad una visione Immanentistica più che Trascendente della natura dell’Universo e dell’Uomo. Precisiamo che i termini Immanente e Trascendente sono attributi che si applicano solo a Dio (Un Dio Trascendente significa che “non s’identifica con il mondo” – ad esempio il Dio dei Cristiani; Un Dio Immanente significa che “si identifica con il Mondo”, come buona parte degli Dei pagani. Una visione Immanentistica dell’Universo, come quella a cui fanno riferimento gli ultimi versi della poesia di Olivero, alimenta il desiderio di perdersi in una Natura in cui tutto é Dio e l’Uomo proiettandosi in questa Natura, proiettandosi in altre vite, condividerebbe qualcosa in più di quel Dio Immanente che intravede in sé stesso: ma a causa del suo limite questa speranza dell’ Uomo non si realizza,.
Ma c’è di più: a interrompere bruscamente questo sogno, questo desiderio di volare alto, interviene la Morte – questo estremo scolorar del sembiante - direbbe Leopardi - che pone fine a tutti i sogni di bellezza e alle aspettative dell’ Uomo: questo è il limite dei limiti per l’Uomo.
Che cosa possiamo concludere? Quali sono i limiti che impediscono all’uomo di volare alto secondo quelle che sarebbero le aspettative della sua Mente? Seguendo la poesia di Olivero azzardiamo la seguente elencazione:
il corpo umano, che funge da zavorra alle possibilità che la mente umana avrebbe di attingere all’Infinito in maniera più efficace e soddisfacente;
il tempo che non è congeniale alla natura della Mente umana: le coordinate spazio-temporali che caratterizzano l’esistenza dell’Uomo proiettato misteriosamente in questo Universo non si addicono all’aspirazione e al desiderio di immortalità e di eternità cui si ispira e a cui aspirerebbe il software della mente umana;
il rapporto con gli altri uomini, cui siamo legati a corda doppia (anzi a catena doppia - dice il poeta) che impedisce una differenziazione ed una scelta davvero personale ed originale di movimento e di espressione, e rappresenta comunque una limitazione al raggiungimento della felicità.
Ed da ultimo, come la ciliegina sulla torta avvelenata dell’esistenza, la Morte, inspiegabile ed assurda, che ancora una volta pareggia tutti gli uomini - la famosa livella di Totò - ma qui la Morte trasforma tutti gli uomini in una statua di cenere, tante statue di cenere, non più differenziabili tra di loro, neanche un poco, dove tu, morto, diventi una statua di cenere come gli altri morti. La morte rappresenterebbe qui la beffa estrema, l’estrema negazione all’aspirazione della Mente Umana ad andare oltre, a volare alto, l’estremo tradimento alle aspettative della Natura Umana, perpetrato con perfidia dal trascorrere del Tempo in cui l’Uomo misteriosamente è proiettato.
Da questo commento si evince che i veri UFO dell’Universo non sono gli omini piccoli, verdi, corti e mostruosi dell’immaginario collettivo e della fantascienza, né gli alieni, veri o presunti che riuscissero a sbarcare sulla Terra dai loro dischi volanti, o che se ne stessero tranquilli e in pace dall’altra parte dell’Universo, ma il vero alieno, il vero essere misterioso degno di essere studiato e analizzato e indagato è solo e sempre l’Uomo: il vero mistero, l’ unico mistero è l’uomo a sé stesso.
Domenico Appendino
(1) È presente, per la prima volta, nell'Armanach piemontèis de Ij Brandé del 1962. Quindi sul Bollettino della Famija piemontèisa di Roma, del febbraio 1962, su 'l caval 'd brôns del gennaio1966 ed, in ultimo, in Poesìa, Alba, Fondazione Ferrero, 2007.
(2) La data che risulta dalla prima pubblicazione sull'Armanach piemontèis de Ij Brandé del 1962, che pubblico qui di seguito, è 17 dicembre 1955.
Da Armanach piemontèis dij Brandé, Torino, 1962
Vien l'ora
Vien l'ora che uno è stufo d'esser uomo. / Sempre lo stesso volto e la medesima / noia che i nostri occhi filtran negli occhi / - riflessi dei nostri - degli altri uomini folli.
Vien l'ora che uno è stufo d'esser uomo. / Disperazione di non poter più credere / in nessuno al mondo, dopo aver tanto creduto. / E ti assale un desiderio che non è di morire: / ma di mutarti in un albero adorno di fiori, / o in una lùcciola, o in un falco / o magari in un masso confitto nell'azzurro... / Ma non più essere un uomo. Ma non udire più / parlare le tue parole e non vedere più / gestire i tuoi gesti da mani sorelle delle tue mani.
Nàusea di sapere che i sogni che ti ridono in cuore / li han già sognati, li sognano e li sogneranno / milioni di cuori che pulsano attorno al tuo / (che poi non è neanche tuo, ma di tutti i cuori / che martellano pugni rossi contro il tuo cuore / per prendergli e dargli un po' di gioia e di dolore...). / Umiliazione di saperti d'esser di tutti: / schiavo dell'umanità che è la tua schiava / e che ti comanda e tu la comandi e peni / la sua pena, tu, incatenato alla sua catena!
Vien l'ora che uno è stufo d'esser uomo. / No. Non vorresti morire, ma schiantare / le sbarre d'ossa della prigione del corpo, / lacerare i fili della rete arroventata delle vene, / rompere questo groviglio di nervi e di muscoli, / squarciare queste muraglie di carne... E perderti: / luce nella luce in cui nascono i mondi... Saziare / la tua sete d'immenso in altre forme di vita / che avverti in te, ma che non sai scolpire.
E un giorno...
E un giorno, piuttosto, vien l'ora della morte / a liberarti... (E sei ancora un morto. / Una statua di cenere come gli altri morti).
Traduzione di Luigi Armando Olivero da Rondò dle masche, L'Alcyone, Roma, 1971
Coment a la poesìa ’d Luigi Olivero
Crocifission an reusa

Disegno di Giuseppe Macrì da Ij faunèt Il Delfino Roma, 1955
Ël tìtol a ’rzulta, a prima vista, bastansa enigmàtich e parèj a resta a na letura pì o meno ’d surfassa e lesta dël test: mi i l’hai lesù costa poesìa desen-e ’d vire sensa capì ’l significà dël tìtol e gnanca còs ch’a vorèissa rapresenté ’nt la sucession dij vers ch’a la costituisso quasi coma s’a fussa ’n corse apress ëd vers ëd fantasìa, ëd «paròle an libertà». Peui, a na bela mira, partend da doi «antërsegn» ch’as treuvo drinta a la poesìa midema a son duvertasse d’orisont ch’a lasserìa arzighé n’antërpretassion sia rispet al tìtol che al contnù.
Partoma da l’arserca dël significà creus ëd la poesìa: l’antërsegn che a serv i lo trovoma ’nt l’ùltim vers e, an conseguensa, ëdcò an coj ch’a ven-o anans: Olivero, ant ël test ëd la poesìa a conta d’esperiense particolar, quasi fòra dal còrp ch’as arferisso a soa «esistensa», a so «esse viv», ma nen mach. Le còse che ’l poeta an conta, an fond, a l’han a che fé con soa identificassion daspërchiel passand a travers d’esperiense che a parlo ’d costa soa identificassion daspërchiel, a na rapresento la spia, ël testimòni. Ma përchè l’òm a veul identifichesse daspërchiel? Visadì: «Përchè mi, coma òm, i son bon a pijé consiensa dij fàit scond ij quaj mi i son sì, im faso diferent da j’àutri òmini ch’am son dantorn, da tuti j’àutri esse vivent, dzorpì che da le còse sensa vita e da l’univers ch’am circonda? Ant la midema manera përchè i l’hai consiensa che un di i son ëstàit concepì, un di i son ëvnuit al mond e ’n di i muirirai?»
Gnun àutr esse vivent al mond, pì o meno svlupà ch’a sia, a l’ha conossensa e a peul pijé consiensa ’d coste còse, visadì che la conossensa ch’a l’ha l’òm ëd l’univers, drinta e fòra ’d chiel, a peul nen paragonesse a cola ’d gnun àutr esse vivent. Coma dì për lòn ch’a rësguarda la «conossensa» e la «prèisa ’d consiensa ’d chiel midem» l’òm a l’é diferent da tuti j’àutri vivent ant na manera pien-a ’d sostansa, coma qualità e nen coma quantità, squasi che fra la conossensa dl’òm e cola dij «primati», le sumie, da le quaj la siensa an disa ch’a sia progredì, a sia vnuje fòra, a na bela mira, un «taj», n’«interussion» ant l’evolussion ëd la conossensa, un sàut ëd qualità sostansial ant la manera ’d confrontesse da ’n ponto ’d vista dë conòss-se ’nt ël creus e con l’univers ch’a lo circonda.
A l’é a coste còse ch’a pensa Olivero quand che sël finì dla poesìa a dis: «Përchè? Përchè? Përchè?» e a continua: «O miraco! , O natura!, O fontan-a ’d mistere! O mia gòi, mia paura! O Nosgnor... miserere...». A l’é pròpi col: «O Nosgnor...miserere...» che, scond mi, a sugeriss la ciav ëd letura con la qual a va ’ntërpretà tut ël test ëd la poesìa; col intré e seurte da chiel midem dont a na parla arlongh a tut ël test a sarà nen n’intré e seurte da l’«ànima» ëd l’òm [quasi ’nt l’antendiment cristian] coma dì consient, inmortal e ch’a peul esiste mach për chila ’dcò an mancansa dël còrp? Ma anans d’anandiesse a la viarà così lontan ancaminoma con ël dì lòn ch’a veul dì an filosofìa la paròla «ànima». Chila a l’é definìa bele mach coma «ël prinsipi ’d vita »: donca për tuti coj ch’a vivo piante, bestie, òmini fin-a che a son an vita a l’han con lor l’ànima, giusta «ël prinsipi ’d vita», quand ch’a meuiro a l’han pì nen an lor «ël prinsipi ’d vita». Fin-a a sì tut ciàir, adritura «lapalissian».
Ij cristian, e nen mach lor, a sosten-o che l’ànima dl’òm, al contrari ’d cola ’d tuti j’àutri esse vivent a l’é inmortal, ch’a sarìa coma dì ch’a l’ha «rason d’esse» an chila, ëdcò se a-i manca la vita dël còrp a la qual a l’é stàita gropà; a diso ij cristian a la fin ëd sò «Chërdo»: «I chërdo ant la vita eterna, amen». E tut sòn përchè lor a chërdo a le paròle ’d Gesù Crist, parèj coma ch’a son arportà ’nt j’Evangeli.
E coj ch’a son nen cristian? A peulo esse frapà dal dubi che l’ànima uman-a a sia inmortal? Quàich filosòf ëd l’antichità a j’ero convint ëd costa inmortalità dl’ànima uman-a: Platone, Socrate e an fond tuti ij filòsof «spiritualista». Ma ambelessì a venta fé në svari, la filosofìa, fin-a dai temp antich a viagia su doi binari paralel, che nen mach a s’ancontro nen, ma a van nen d’acòrdi fra ’d lor: da na banda ij «materialista» che an fond a chërdo mach an lòn ch’as ved, as toca, as sent, as papòta, lòn ch’a casca sota al domini dij sinch sens, da l’àutra jë «spiritualista» che , as capiss, a chërdo ’dcò lor a lòn ch’as ved, as toca, as sent, as palpegia, ma, scond coj-lì, a-i sarìa ’dcò quaicòs d’àutr, e a diso a la finitiva che l’inmortalità uman-a a sarìa da buté an relassion con le caraterìstiche particolar ëd la conossensa uman-a dont i l’oma parlà. As capiss che ’l servel a dventa , për lor-lì, lë strument d’elession ëd l’ànima ’nmortal, bele se cost ëstrument a peul esse tut o an part ratà e la midema còsa a peul d’esse për ël còrp sël qual a l’é traposà ’l servel uman: ... ah... varda-sì... ambelessì ’l còrp uman, andrinta al qual l’òm a l’é «crocifiss»a dventa ’l «crocifiss ëd l’ànima». An efet ant la poesìa d’Olivero l’ànima, tornà ’nt ël còrp dòp na serie ’d «vòj pindàrich» (ch’am ven-a përdonà l’usagi dl’agetiv) a fà di a Olivero, a lo òbliga a ciamesse ’l përchè: «torno a sente mia carn, torno a savèime un òm: un dij tanti povr’òm anciodà ’n s’na cros d’aria con brass e gambe... e un nòm d’ànima solitaria?». Col «anciodà s’na cros d’aria» a furnis la prima part dël tìtol «Crocifission» ... ma përché costa crocifission a dovrìa esse «an reusa»? ... Pensa e ’rpensa, dòp d’avèj lesù la poesìa 100, 200, 300 vire, a më smija nen arzigà sosten-e che Olivero a l’abia vorsù, ant ë serne ’l tìtol, fé arferiment a n’euvra ’d Leonardo da Vinci. J’euvre ’d Leonardo pì ’mportante o pì conussùe al mond a son «La gioconda», che as treuva a Paris, ël «Cenacolo», ch’a l’é a Milan e l’«Uomo di Vitruvio» ch’a l’é guernà a Venessia.
Pròpi l’«Uomo di Vitruvio»: ambelessì as trata d’un dissègn ëd color tèra rossa-baross che a rafigura n’òm butà ’ndrinta a ’n sercc e un quadrà con ij brass e le gambe duverte an doe posission che, vist ant na certa manera, a son un-a sl’àutra e as toco: Lë studi a l’avìa miraco ’l but ëd fé pijé consiensa dl’armonìa dl’anatomìa e dle forme dël còrp uman da part ëd Leonardo con ëd finagi gropà a sò travaj d’artista e a butava an evidensa costa armonìa con un dissègn ch’a sarìa disse ispirà ai criteri ’d blëssa e armonìa dovrà da l’architet Vitruvio ’nt la Roma veja. Con son a sarìa ’rvelasse l’enigma dël tìtol, «La crocifission reusa» a sarìa pròpi arferìa al color dël dissègn ëd Leonardo... nen pròpi reusa, ma va là... i voroma concede a Olivero ’l lusso d’esse na frisa daltònich fasend arferiment al color ëd l’«Uomo di Vitruvio»? Chi a l’avèissa nen present còs ch’a l’é l’«Uomo di Vitruvio» e coma ch’a l’é fàit a peul trovelo sla facia daré dla moneda da 1 Euro, batùa da la zëcca italian-a: ambelelì a l’é figurà an bass-rilev l’«Uomo di Vitruvio» ëd Leonardo... pròpi la «crocifission an reusa».
An tute le manere, dòp d’avèj s-ciairì che na tal «stimà precision», l’orìgin dël tìtol i dovoma ancora parlé dël contnù. Tutun, tenend cont ëd lòn ch’a l’é pen-a disse, a-i é pì pòch da gionté. As traterìa, vers dòp vers, ëd na descrission d’«efet speciaj» ëd l’ànima uman-a inmortala e përzonera dël còrp fìsich, crocifissa sël còrp fìsich. Costi «efet speciaj», parèj coma ch’a son dëscrit, a sarìo da buté an relassion con la capacità dl’ànima uman-a nen mach «d’identifichesse daspërchila», ma ’dcò ’d «dëstachesse», ëd seurte fòra da sò còrp, prové esperiense e sensassion particolar, foravìa [ant j’esperiense contà da Olivero] për peui artorné ’ndrinta al còrp e ’rsente ancora ’l pèis ë l’«esistensa». Ma tramentre l’ànima, anans d’artorné an contat con l’esse fìsich ëd la materia e dël còrp, a l’ha provà d’esperiense e ’d situassion che ’nt le condission normaj a peul nen verifichesse. Ëd particolar blëssa e bin marcà sota cost aspet a l’é col cissé ’d domande arferìe a : «Còs’è-la costa fòrsa che, sensa mòrt, am fa meuire e arnasse ant un nen an tante vite neuve? Còs’è-la mai cost’onda ch’a seurt e a torna ant mi lassandme ant un miragi ’d silensi trasparent»? ... e a-j përmet ëd sentse coma na masnà pen-a nà, drinta a na cun-a ’d vent pien-a ’d piume d’argent e sota n’arcansiel colorà? ... visadì ai pé dl’arcansiel.
Cost passagi a peul pa nen fé ven-e an ment la fàula dij Selt andoa che ’n masnà a ciama a soa mare, a l’aparission ëd l’arcansiel ant ël cel : «Pòrt-me là ’ndoa che l’arcansiel a toca la tèra ch’i lo veuj vëdde davzin, i veuj tochelo» e la mare a-j rëspond apopré parèj : «A l’é nen possìbil rivé an col pòst ëd blëssa ’ndoa che l’arcansiel as gionz a la tèra, përchè pròpi ’mbelelì ’ndoa che l’arcansiel as gionz a la tèra a-i é ’n paireul pien ëd monede d’òr e d’argent, ma belavans i trovoma ’nt col pòst ëdcò ij folèt, ij sarvan gram che a son guernor ëd col tesòr e a lasso nen che gnun a s’avzin-a»... Nopà ambelessì, ant la poesìa d’Olivero, cost anciarm ëd la «blëssa ch’as peul nen toché» a së s-ciapa: ël poeta a nen mach ai pé dl’arcansiel (sota n’arch colorà), ma a l’é coma s’a fussa dventà padron dël paireul con ël tesòr, ma lòn ch’i diso, a l’é fin-a ’ndrinta al paireul ëd la legenda (ambelessì la cun-a a l’é : na cun-a ’d vent) a contat con cola richëssa rapresentà da le piume d’argent (s’i voroma censuré – coma ch’a l’é giust – la paròla duvet ant ël sens ëd le 2 Lire d’argent e ch’a sarìa na forsadura nen acetàbil për tuti ij vocabolari dla lenga Piemontèisa...).
Dasend apress a le linìe trassà da costa descrission e da cost coment a më smija nen che l’antërpretassion global ëd la poesìa a peussa ’ndé tant lògn da le conclusion ch’a l’han portame fin-a a sì.
Domenico Appendino
Traduzione di Michele Bonavero pubblicata sulla rivista torinese Piemontèis ancheuj del marzo 2011.


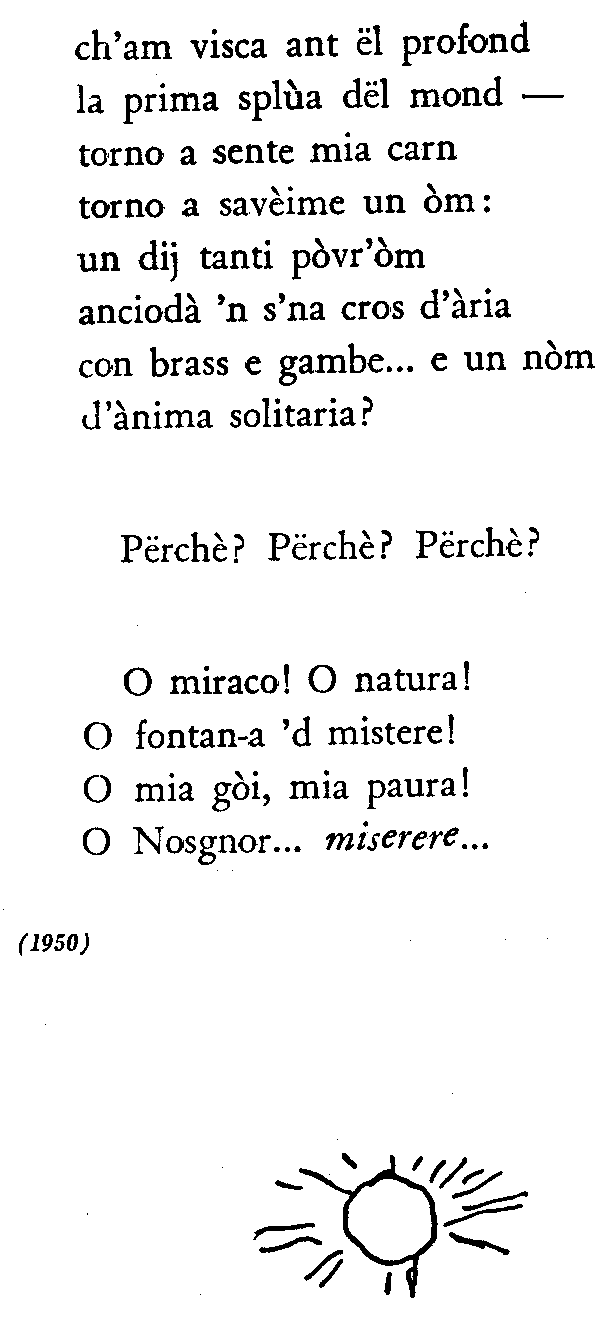
Commento estemporaneo alla poesia di Luigi Olivero
Crocifission an reusa
Il titolo della poesia risulta, a prima vista, alquanto enigmatico e tale rimane ad una lettura più o meno superficiale ed affrettata del testo: ho letto decine di volte questa poesia senza capire il significato del titolo e neppure che cosa essa volesse rappresentare nella successione dei versi che la costituiscono quasi fosse un semplice rincorrersi di versi di fantasia, di “parole in libertà”. Poi, ad un certo punto, partendo da due “indizi” che si trovano all’interno della poesia stessa si sono aperti orizzonti che permetterebbero di azzardare una interpretazione sia rispetto al significato del titolo sia rispetto all’essenza del contenuto.
Partiamo dalla ricerca del significato intrinseco della poesia : l’indizio che serve lo troviamo nell’ultimo verso, e di conseguenza, anche in quelli immediatamente precedenti: Olivero, nel testo della sua poesia racconta di sensazioni e di esperienze particolari, quasi extra-corporee che si riferiscono alla sua “esistenza”, al suo “essere vivo” ma non solo. Le cose che il poeta racconta, in fondo, hanno a che fare con l’auto-identificazione di sé attraverso esperienze che parlano di questa auto-identificazione, ne rappresentano la spia, il testimone. Ma perchè l’uomo si auto-identifica? Cioè, a dire: “ perché io, in quanto uomo, sono in grado di prendere coscienza dei fatti secondo cui io sono qui, mi diversifico da tutti gli altri uomini che mi circondano, da tutti gli altri esseri viventi, oltre che dalle cose inanimate e dall’universo che mi circonda ? Allo stesso modo perché ho coscienza che un giorno sono stato concepito, un giorno sono nato e un giorno morirò?” Nessun altro essere vivente al mondo più o meno evoluto che sia, ha conoscenza e può prendere coscienza di queste cose, vale a dire che la conoscenza che ha l’uomo dell’universo interno ed esterno a sé, non può essere paragonata a quella di nessun altro essere vivente. Cioè per quanto riguarda la “conoscenza” e “la presa di coscienza di se stesso” l’uomo si differenzia da tutti gli altri viventi in maniera sostanziale, qualitativa e non quantitativa, quasi che tra la conoscenza dell’uomo e quella dei “primati” le scimmie, da cui scientificamente risulta essersi evoluto, sia intervenuta ad un certo punto una “cesura”, una “discontinuità” nell’evoluzione della conoscenzaë, un salto di qualità sostanziale nel modo di rapportarsi da un punto di vista conoscitivo con se stesso e con l’universo che lo circonda.
È a queste cose che pensa Olivero quando sul finire della poesia dice , “Përchè’? Përchè? Përchè ? “ e continua “O miraco ! , O natura ! , O fontan-a ‘d mistere! O mia gòi, mia paura! O Nosgnor…miserere…” . Ed è proprio quel “ O Nosgnor… miserere..” che, secondo me, suggerisce la chiave di lettura con cui va interpretato tutto il testo della poesia : quell’entrare ed uscire da sé di cui parla durante tutto il testo non sarà forse un entrare ed uscire dell’ “anima” dell’uomo [quasi cristianamente intesa] cioè cosciente, immortale e che può sussistere per se sola anche in assenza del corpo? ma prima di avventurarci così lontano incominciamo col dire che cosa significa in filosofia la parola “anima”. Essa è definita semplicemente come il “principio di vita”: pertanto tutti i viventi: piante, animali, uomo finchè sono in vita hanno in sè l’anima, “ il principio di vita” appunto, quando muoiono non hanno più in sé il principio di vita: fino a qui tutto chiaro, addirittura “lapalissiano”. I cristiani, e non solo, sostengono che l’anima dell’uomo, al contrario di quella di tutti gli altri viventi è immortale, cioè ha “ragion d’essere” in sé stessa, anche in assenza della vita del corpo a cui è appartenuta: dicono i cristiani alla fine del loro “Credo”: “credo nella vita eterna Amen”. E tutto questo perché essi credono alle parole di Gesù Cristo, così come sono riportate nel Vangelo.
E quelli che non sono cristiani ? Possono essere assaliti dal dubbio che l’anima umana possa essere immortale?? Alcuni filosofi dell’antichità erano convinti di questa immortalità dell’anima umana: Platone , Socrate e in fondo tutti filosofi “spiritualisti”. Ma qui occorre fare una digressione: la filosofia, fin dall’antichità viaggia su due binari paralleli, che non solo non s’incontrano, ma sono tra loro inconciliabili: da una parte i “materialisti” che in fondo credono solo in ciò che si vede, si tocca, si sente, si palpa, ciò che cade sotto il dominio dei cinque sensi insomma, dall’altra gli “spiritualisti” i quali naturalmente credono anch’essi a ciò che si vede, si tocca, si sente, si palpa, ma, secondo costoro, ci sarebbe anche qualcos’altro, e dicono in fondo che la immortalità dell’anima sarebbe da mettere in relazione alle caratteristiche specifiche della conoscenza umana di cui abbiamo parlato: certo il cervello umano diventa per costoro lo strumento di elezione dell’anima immortale, anche se questo strumento può essere in tutto o in parte guasto ed in tutto od in parte guasto può essere anche il corpo su cui appoggia il cervello umano: ….ah…ecco… qui il corpo umano, dentro il quale l’uomo è “crocifisso” diventa il “crocifisso dell’anima” : difatti nella poesia di Olivero l’anima tornata nel corpo dopo una serie di “voli pindarici” ( mi si passi l’aggettivo) fa dire ad Olivero, lo obbliga a chiedersi il perché: “torno a sente mia carn , torno a savèime un òm: un dij tanti pòvr’òm anciodà ‘n s’na cros d’ària con brass e gambe… e un nòm d’ànima solitaria ? ” . Quello “inchiodato su una croce d’aria” fornisce la prima parte del titolo “ Crocifission” …ma perché questa crocifission dovrebbe essere “an reusa” … pensa e ripensa dopo aver letto la poesia 100, 200 300 volte , mi sembra non azzardato sostenere che Olivero abbiamo voluto, nella stesura del titolo, far riferimento ad un’opera di Leonardo da Vinci: di Leonardo le opere più importanti o comunque più universalmente note sono in successione “La Gioconda” , che si trova a Parigi, “Il Cenacolo” che si trova a Milano, L’ “Uomo di Vitruvio” che si trova a Venezia.
L’ “Uomo di Vitruvio” appunto: qui si tratta di un disegno di colore ocra-rossiccio che raffigura un uomo inscritto in un cerchio e un quadrato a braccia e gambe divaricate in due posizioni per certi aspetti sovrapposte e contigue: lo studio aveva forse lo scopo di far prendere coscienza dell’armonia dell’anatomia e delle forme del corpo umano da parte di Leonardo con scopi connessi con il suo lavoro di artista, e metteva in evidenza quest’armonia con un disegno che si sarebbe ispirato ai canoni di bellezza e di armonia previsti dall’architetto Vitruvio nell’antica Roma: ecco che sarebbe così svelato l’enigma del titolo: La “crocifission en reusa” sarebbe proprio riferita al colore del disegno di Leonardo …non proprio rosa-rosa, ma insomma … vogliamo a concedere ad Olivero il lusso di essere un po’ daltonico nel riferimento al colore dell’ “uomo di Vitruvio” ??….Chi non sapesse che cosa è l’ “uomo di Vitruvio di Leonardo” e come è fatto lo può trovare sul retro della moneta corrente da 1 Euro, emesso dalla zecca Italiana: lì è raffigurato in bassorilievo l’uomo di Vitruvio disegnato dai Leonardo… la “crocifissiun an reusa” appunto ….
Ad ogni modo dopo aver appurato con una certa “presunta accuratezza” l’origine del titolo, dobbiamo ancora parlare del contenuto. Ma in fondo tenendo conto di quello che abbiamo detto, poco rimane da aggiungere. Si tratterebbe, verso dopo verso, di una descrizione di vari “effetti speciali” dell’anima umana immortale prigioniera del corpo fisico, crocifissa sul corpo fisico. Questi effetti speciali, così come descritti, sarebbero da mettere in relazione alla capacità dell’anima umana non solo di “ autoidentificarsi” ma anche di “estraniarsi”, di uscire dal proprio corpo, provare sensazioni ed esperienze particolari, inusitate [nelle esperienze raccontate da Olivero] per poi ritornare nel corpo e risentire ancora il peso dell’ “esistenza” . Ma intanto l’ anima prima di ritornare in contatto con la fisicità della materia e del corpo fisico ha provato esperienze e situazioni che in condizioni normali non si possono avverare. Di particolare bellezza ed incisività sotto questo aspetto quell’incalzare di domande riferite a “Còs è-la costa fòrsa che, sensa mòrt, am fa meuire e arnasse an un nen an tante vite neuve? Cosa è mai quest’onda che esce da me e ritorna in me lasciandomi in un miraggio di silenzio trasparente” ?.... e gli permette di sentirsi come un bambino appena nato, dentro una culla di vento ricolma di piume d’argento e sotto un arcobaleno colorato?,…. cioè ai piedi dell’arcobaleno. Questo passaggio non può non far venire in mente la favola celtica di quel bambino che chiede alla mamma, al comparire dell’arcobaleno in cielo: “ portami là dove l’arcobaleno tocca la terra che lo voglio vedere da vicino, lo voglio toccare ” e la mamma gli risponde più o meno così “ è impossibile arrivare in quel luogo di bellezza là dove l’arcobaleno si congiunge con la terra, perché proprio lì dove l’arcobaleno si congiunge con la terra c’è da sempre una “pentolaccia” piena di monete d’oro e d’argento ma purtroppo ritroviamo in quel luogo anche degli “gnomi”, degli “elfi” cattivi che stanno a custodia di quel “tesoro” e non permettono che nessuno si avvicini”….. E qui invece, nella poesia di Olivero, questo incantesimo della “bellezza irraggiungibile” si spezza : il poeta è non solo ai piedi dell’arcobaleno ( sota n’arch colorà ) ma e come se fosse diventato padrone della “pentolaccia” che contiene il tesoro – ma che dico – è dentro la pentolaccia della leggenda ( qui la culla: na cun-a ‘d vent )…. a contatto con la ricchezza rappresentata dalle piume d’argento ( se vogliamo censurare – come giusto – la parola duvet nel senso di 2 Lire d’argento che costituirebbe una forzatura inaccettabile per tutti i vocabolari della lingua piemontese …). Seguendo le linee tracciate da questa descrizione e da questo commento non mi pare che l’interpretazione globale della poesia possa andare molto lontano dalle conclusioni interpretative sin qui condotte…..
Domenico Appendino
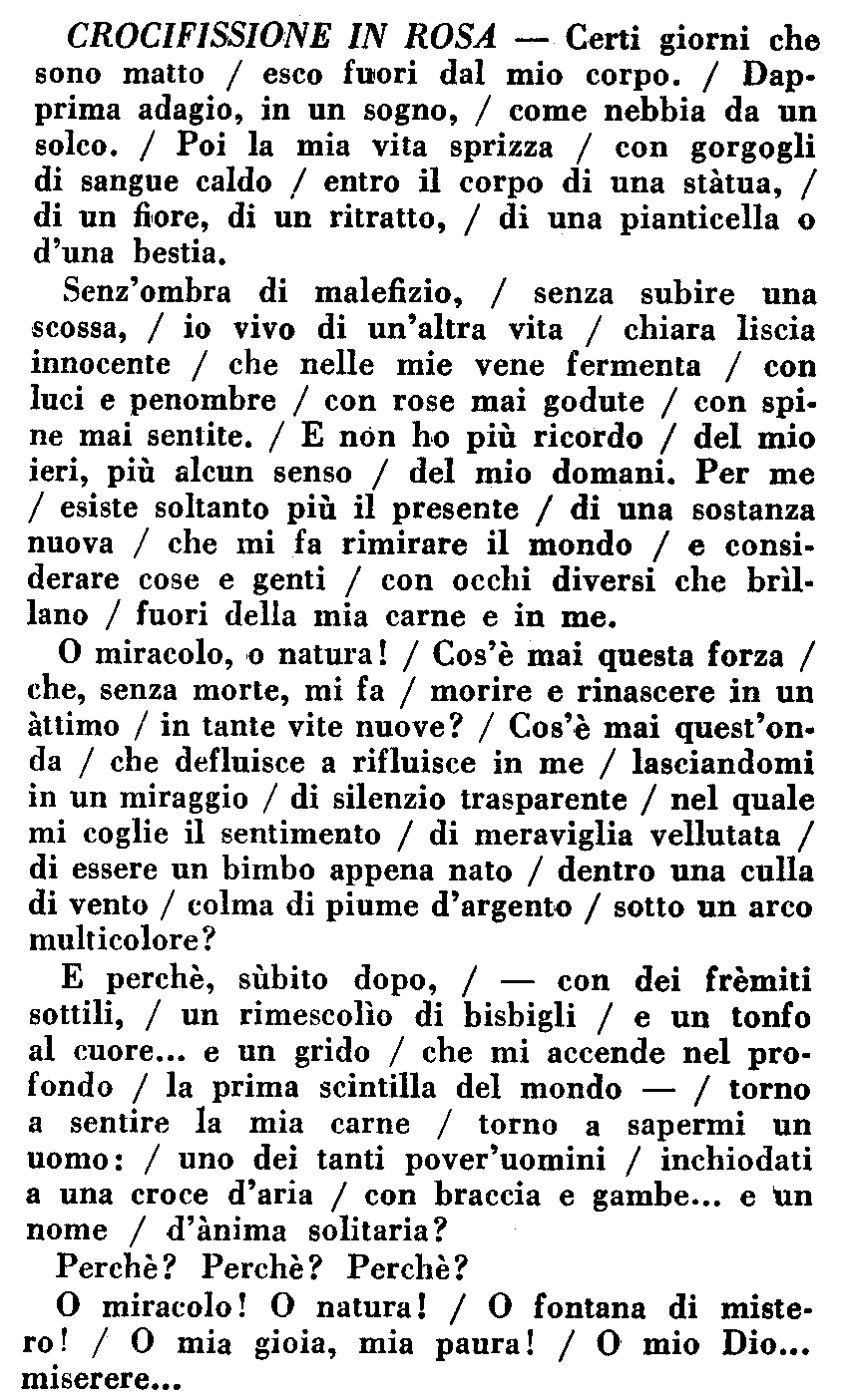
La traduzione, tratta da Ij faunèt, è di Clemente Fusero
La prima neuit d’Adam

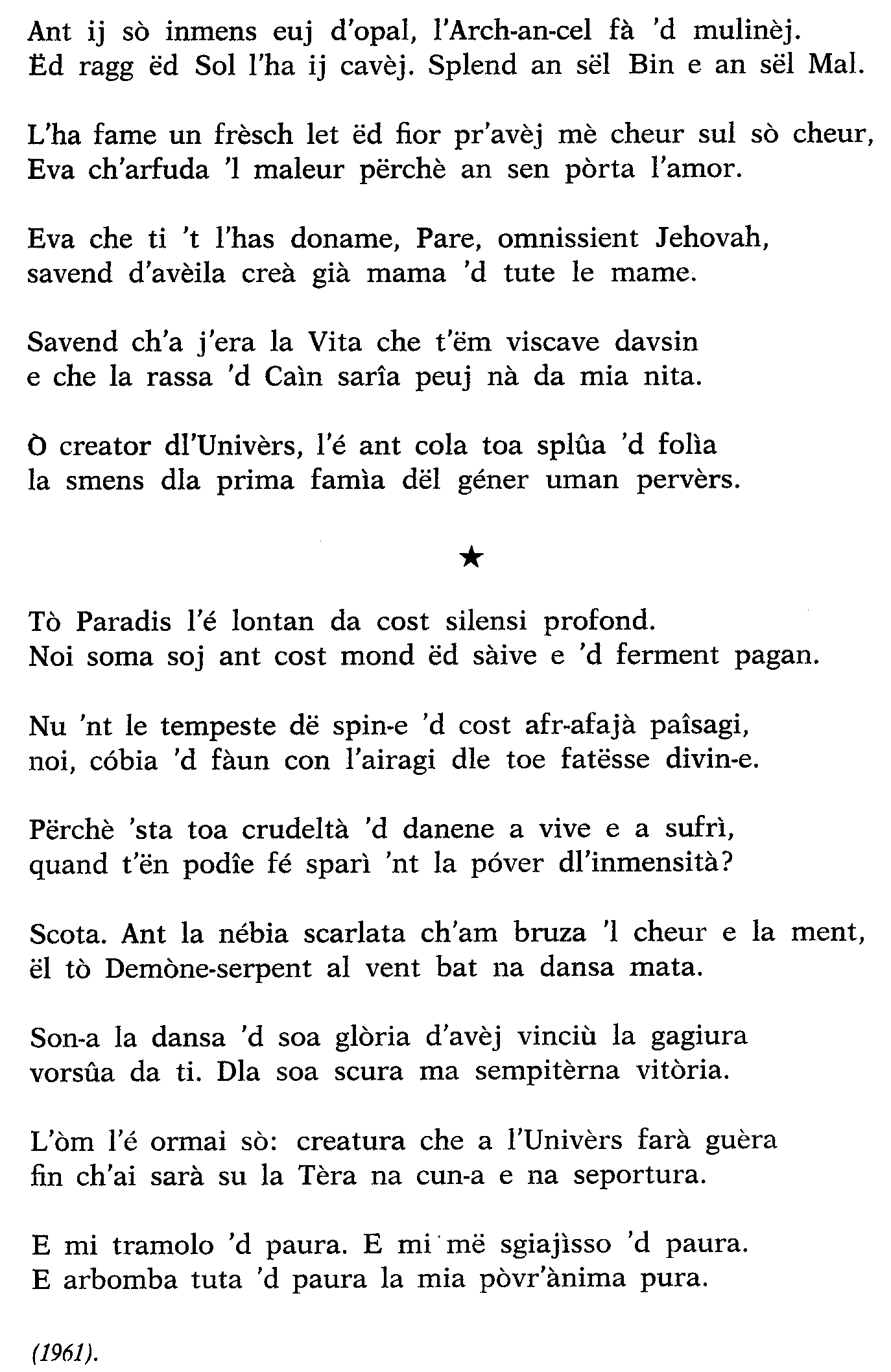
Ëd costa poesìa Olivero a l’ha scrivù un sò coment përsonal, ma cost coment a më smija ridutiv tant rispet al contnù poetich ëd l’euvra e tant ant na valutassion global. La poesìa an question a s’antren-a sël problema dl’Òm ciapà ’nt na mòrsa fra la Bin e ’l Mal, chiel a l’ha consiensa ’d costa soa condission e ambelessì a stà ’l drama: an fond ij Des Comandament, consignà da Dé a Mosé sël mont Sinai, a son nen mach lej positiva fornìa «brevi manu» da Dé a j’òmini, ma a son imàgine (e ch’as fasa atension, tant che l’aveniment dël Sinai a sia ancapità për dabon [apopré 1.200 ani anans ëd Crist] o ch’a sia nen verificasse për gnente, restand mach na conta ’d pura fantasìa). A venta ten-e cont che cola Lej Positiva che Dé a l’ha dàit a Mosé a sonerìa tutun mach e peui mach coma un «promemòria», na confermassion importanta ’d na Lej Natural ëscrita ’nt la consiensa e ’nt ël cheur ëd l’òm fin-a da quand l’òm a l’é òm.
A l’é su costa suposission ch’a venta enté ’l contnù dla poesìa.
Donca «la prima neuit d’Adam». Quaidun as ciamerà: «ma ’nt la prima neuit d’Adam, Eva a j’intra?...» E coma nò? As capiss che Eva a l’ha pòst, dësnò che prima neuit ch’a sarìa? Ma a l’é nen la presensa d’Eva ch’a dà turbament a Adam ant cola prima neuit ëd soa esistensa, nen mach përchè Adam a fà na difèisa sostnùa d’Eva, a la diciara nossenta dë ’dnans a chiel e dë ’dnans a Dé; nopà le presense ambarassante ’d col Paradis Terestr a son cole ’d Dé e ’d Satanass o mej, lòn ch’a bolversa Adam e a lo fà nen deurme ’nt la neuit, a l’é ’l serché ’d capì an quaj rapòrt ch’a stan fra ’d lor Dé e ’l Demòni e còs ch’a «màchino» lor doi, miraco a dann ëd l’òm ch’a dventa donca, an costa poesìa, ël ters incòmod...
Anandiomse dal prinsipi dla poesìa:
«La lun-a a orient l’é na vela ch’a splend tra ij Pèss d’òr dël cel», a smija, coma prim achit, un bon inissi, për conseguensa dlë splendor ëd la faussìa dla lun-a, ma a l’é nen parèj. La faussìa dla lun-a, a forma ’d na vela, a l’é projetà, slë sfond ëd le stèile lontan-e, andrinta a la costelassion dij Pess e për cost motiv ël cel lontan a ven paragonà a ’n mar: a-i é na vela, a-i son ij Pess d’òr dël cel, a-i é ’l cel, squasi un mar përfond, ma col mar dël cel, për colpa dla neuit, a l’é scur, mnassos quasi a vorèj pronostiché un destin tràgich për l’òm... ëdcò s’a manco nen j’arciam, ambelessì sla Tèra, a ’d còse gentij; a s’antërvëddo le stèile che, quasi lusentele, a mando d’arbat ëd lus sla pel d’Adam, le fior che con l’avansé dla neuit a saro ij sò càles, ël cant dij grij sì... sì... ma ant lë scur ëd la neuit a-i é ’dcò quaicòs d’àutr... ant la nebia, ch’as ambaron-a con l’intré ’d pì ’nt la neuit përfonda, as sent an lontanansa, ma con un son ciàir e net, ël rumor ansigà dal «serpent a sonaj», la përsonificassion dël Demòni, ch’a smija ritmé ’l temp ëd na dansa «mata».
I sentoma già lë scur presentiment ëd lòn ch’a vnirà dòp: ma as pronta ’dcò da lògn ël moment ëd la «rusa» fra Adam e Dé midem (ambelessì a l’é Olivero ch’a pija ’l pòst d’Adam, chiel ch’a ciacotava con tuti...).
Ti Dé it l’has creà l’òm, it l’has creame mi: për na minuta d’amor a-i saran «milion ëd sécoj ëd guère»...
Un di – a dis Adam a Dé – Ti it lasseras meuire Tò Fieul sla cros, mè arbut pì radios, sangonand mè pecà: ambelessì, con na «penelà», a ven ësfiorà ’l misteri dl’«incarnassion» ëd Gesù Crist-Dé, che as carierà su Chiel midem la natura Uman-a për salvé l’òm da le conseguense ’lòn ch’a stà për ancapité ’nt ël Paradis Terestr (scond la tradission e le scriture Ebreo-Cristiane), e për provëdde a cost arcuper, a costa Redension ëd Gesù Crist a dovrà meuire sla cros. Ël tema dla Redension a l’é pen-a sfiorà ’nt la poesìa d’Olivero, ma a l’é pa na còsa da pòch: Gesù Crist, al 100% Dé, përchè a pija da Pare Dé la natura Divin-a e al 100% Òm, përchè a pija la natura uman-a da la Madòna, a carierà su ’d chiel midem le conseguense ’d cola còsa... ma quala còsa? As capiss che Dé a deuv avèj vëdù ’nt l’Òm quaicòs ëd grand e d’important fra tute le còse creà se a l’ha decidù, a na bela mira, ëd condivide con l’Òm soa natura midema; la natura uman-a a l’é nen forëstera a Dé e Gesù Crist a lo dimostra, për sòn essendje tut l’Òm an Dé a-i sarà ’dcò quaicòs «pen-a pen-a» ëd Dé an minca òm...
La presensa dla natura Uman-a an Dé a sorprend e a fà maravijé ’dcò Dante Alighieri, che ant l’ùltim cant dël Paradis, tramentre che – ant na lus ambalucanta – a l’é an camin ch’a serca ’d capì coma ch’a fonsion-a la circolassion d’Amor an Dé fra ’l Pare, ël Fieul e lë Spìrit Sant, a armarca che... ël sénter ëd cola circolassion d’Amor... «mi parve pinta della nostra effige»... An d’àutre paròle: ant la lus ëd Dé che Dante a ved a-j compariss (quasi stampà su na «Sìndon») l’imàgine ’d n’Òm, pròpi Gesù Crist. Costa avsinansa s-ciassa fra l’Òm e Dé a l’é oget ëd dëscussion e d’arpensament da part ëd la teologìa Cristian-a, ma a bin vardé da mila ani, da doimila ani a sta part gnente a l’é cambià ’nt l’impostassion d’un tentativ dë spiegassion ëd cost misteri: vàire ani fa i sentìo da ’n teòlogh turinèis che a ’ndasìa për la magior, Don Andrea Fontana, costa spiegassion miraco nen adeguà, ma rapresentativa dël rapòrt Òm-Dé për ij Cristian.
Dé a l’é Amor, a l’é pienëssa d’Amor. Për serché ’d capì costa còsa noi i paragonoma l’Amor ëd Dé a na gròssa doja pien-a ’d bira. La bira, (visadì l’Amor ëd Dé) a l’é talment bondos e dëbordant ch’a seurt fòra sota forma dë s-ciuma dal bòrd dël bicer e a casca an tèra... A së spòrca... Ma cola s-ciuma cascà për tèra – l’Òm creà da Dé – a l’é sèmper part integranta dl’Amor ëd Dé,... e përchè l’essensa ’d sò Amor a vada nen përdùa, Chiel as chin-a fin-a a tèra – Vardé-sì Gesù Crist – për arcuperé col Amor ch’a l’era scapà dal bòrd dla doja...
Se, tornand a la leteratura piemontèisa, i andoma a arpësché, a distansa ’d mila ani, ij famos Sermon Subalpin, i trovoma, fra cole 22 prédiche, na conta ch’a smija la stòria an «fòtocopia» ëd lòn ch’i l’oma pen-a contà: «Ant la neuit dij temp Dé a strenzìa an mes a le man na perla pressiosa e pì che bela (L’Òm) e ’nt l’amirela Dé as dësmorava, as divertìa con cola... ma a na bela mira, sensa adess-ne, la perla a jë scapava da le man, a tombava, a ròlava për un pòch sla tèra e peui a ’ndasìa a finì drinta a na tubassion dla rian-a, la tampa dla botala, na fognadura i dirìo noi... (la forana ’nt ël test original)... e Dé për arcuperesse cola perla pressiosa, dòp che un servidor a l’avìa nen trovala, a calava bele Chiel ant la rian-a për serchela, pijandse daspërChiel la natura Uman-a e Divin-a ’d Gesù Crist». I sai nen s’i l’hai mastrujà na frisa ’l test ëd col Sermon, ma i dovrìo nen esse lògn dal contnù e dal sens vorsù trasmëtte da cola prédica.
An fond la teologìa – spiegà a branche a la gent d’antlora coma a cola dël di d’ancheuj – a l’é nen cambià tant rispet a cola ch’a së spiegava mila ani fa dovrand la lenga piemontèisa dël temp.
Dòp ëd coste divagassion (i dovroma cost termo) tornoma pura al test ëd la poesìa d’ Olivero.
Adam a sent ël pèis ëd la maledission divin-a dòp dël pecà orìginal e ’dcò ’l misteri dl’incarnassion e dla passion ëd Crist a-j compariss su në sfond scur e misterios; sò destin sombr ëd mòrt e l’Infern an prevision, a smijo coma na conseguensa direta dël fàit d’esse stàit creà e d’esse intrà ’nt l’«esistensa» che, për soa incertëssa e ij paràmetro dë spassi-temp ch’a la carateriso, a son nen adat a chiel...
A sent ël pèis d’esse projetà ’nt la natura, ël verd dij pra e dël mond vegetal a l’ha na soa blëssa creusa, ma as peul nen dëstachesse da cola notassion ëd «lus vërda lussiferina» ch’a pòrta lus sì, ma a arciama ’dcò a la ment ël feu ’d Lucifer... E peui a-i é l’onda sla qual a sghija con gòj, dësvijandse «patanùa e rijenta» Eva – «mia seur ësposa» coma ch’a la ciama Adam –
A ven dapress na notassion ch’a son-a parèj d’un soris, an mes a la seriosità dla situassion, coma ch’a càpita soens ant le poesìe pì tràgiche d’Olivero, chiel parland d’eva a dis «Ant ij sò inmens euj d’opal, l’Arch-an-cel fà ’d mulinèj. Ëd ragg ëd Sol l’ha ij cavèj. Splend an sël Bin e an sël Mal». Donca inmens euj d’opal... ma a saran peui pròpi j’euj d’Eva? A më smija nen tròp probàbil, dësnò Eva a l’avrìa doi euj coma Polifemo (Bele se chiel a n’avìa un sol chila a n’ha doi...)
A mè avis ambelessì ’l poeta a fà arferiment ai sen d’Eva. D’àutra part, vëdend dë ’dnans a chiel Eva patanùa, la prima còsa a la qual a coro j’euj d’Adam a l’é giust ch’a sio ij sen e nen j’euj... adess coj inmens euj, arferì ai sen, a stà mej, a më smija pì convenient. Dël rest a l’é col color opalin-opalessent ch’am armanda a la giusta antërpretassion... ij riond dij mimin dël sen d’Eva a son d’un color na frisa maròn-opalessent e surtend umid da l’eva a mando, për colpa dël sol bass sl’orisont ëd la matin, j’arbat ëd l’arcancel; për fesse n’idèja ’d paragon as peul disse coma le piume scure ’d n’ania ch’a seurt da l’eva dòp ëd na noada, a l’han ij rifless ëd l’arcancel. E peui Eva dai cavèj biond «Ëd ragg ëd Sol l’ha ij cavèj» a pronta un let ëd fior – a dis Adam – për avèj sò cheur sël mè cheur. Eva ch’a arfuda e a scapa dal maleur përchè an sen a pòrta l’amor, ... Eva ch’a l’é già mare ’d tute le mare... as capiss la maternità ch’a pressied a la trasmission ëd la vita da generassion a generassion. Tutun ëd cost pass, pensand a Eva, a ’rtorno an ment a Adam ëd pensé fiosch... përchè an conseguensa ’d cola trasmission ëd la vita passand travers a la sesualità as continua la specie, la rassa dij dissendent ëd Càin... tuti dissendent d’Adam gropà a còrda dobia con ël Mal.
Ambelessì a s’anandia, a l’improvisa e sensa speteslo, la tirada dësdeuita d’Adam contra Dé, da sì an anans la poesìa a peul ëdcò esse considerà coma l’alegorìa ’d n’arvira violenta dl’Òm contra Dé, quasi na rapresentassion ëd lòn ch’a l’é sucedù për dabon ant ël Paradis Terestr al temp dël pecà original.
E a dis Adam a Dé fasend arferiment a la creassion ëd l’òm e dla dòna: «Ò Creator dl’Univers, l’é ant cola splùa ’d folìa la smens dla prima famìa dël géner uman pervérs. Tò Paradis l’é lontan da cost silensi profond. Noi soma soj ant cost mond ëd sàive e ’d ferment pagan.» Dzorpì ’nt ël rapòrt fìsich e spiritual Òmo-Fomna a-i é quaicòs dë scur e pòch acetàbil bin avend Dé provëdù a creé l’òm a soa imàgine e smijansa (noi, Adam e Eva, cobia ’d Faunèt, metà òmo e metà cravon, ma ’dcò caraterisà da toe fatësse divin-e...).
As riva peui a la part pì agressiva dla poesìa: Adam a dis a Dé «Scota. Ant la nébia scarlata ch’am bruza ’l cheur e la ment, ël tò Demòne –serpent al vent bat na dansa mata. Son-a la dansa ’d soa glòria d’avèj vinciù la gagiura vorsùa da ti. Dla soa scura ma sempiterna vitòria». Adam a dis a Dé ch’a l’é nen na dansa mata cola ch’a son-a ’l Demòni coma ch’a l’era smijà për un moment a l’inissi dla poesìa, ma na dansa ’d «glòria» e ’d «sodisfassion» për avèj vagnà la «scomëssa» (la gagiura) vorsùa da Ti, quasi che Dè a sia giugasse con ël Demòni, ant na misteriosa partìa d’arzigh, ij destin d’Adam e dl’Umanità antrega përdend an efet costa scomëssa e butand l’Òm e sò destin ant le man ëd Satanass. Për son ël «Mal» a dòmina ij destin ëd l’òm ant la stòria, dzortut le guère e la grama condussion dij rapòrt fra òm e òm ant ij termo generaj (homo homini lupus).
A sarìa costa la conseguensa cola scura scomëssa përdùa da Dé ’nt ij confront dël Demòni, ch’a l’avìa coma gage ’l destinëd l’Òm stravirà ’nt na sempiterna lòta fra la Bin e ’l Mal.
COMENT CRÌTICH AL CONTNÙ E A LA TESI DLA POESÌA
Da ’n ponto ’d vista Cristian, la tesi portà anans an costa poesìa a l’é nen acetàbila e a l’é, se pa d’àutr për na bon-a part dël sò contnù, drinta a l’Eresìa. La Cesa Catòlica, e nen mach chila, a sosten che për lòn ch’a rësguarda a la conta dël pecà original, coma a rportà ’nt ël lìber ëd la Genesi, nen mach ha l’ha un caràter alegòrich për spieghé ’l Mal ch’a-i é ’nt ël mond, ma ’dcò che l’Òm «tocà» dal mal, an conseguensa dël pecà original a sarìa sì sensibilisà al mal tutun nen tant e gnanca tròp da esse butà an discussion soa libertà ’d sernia fra Bin e Mal, sò «lìber arbitri» a la finitiva, e donca se l’òm a resta lìber a resta ’dcò responsàbil ëd la sernia fàita tra ’l bin e ’l mal.
Nen tuti però, ant ël cors ëd la stòria dla Cesa, a l’han acetà costa antërpretassion. La stòria a conta d’un religios, Giansenio, e dij sò dissépoj, ij Giansenista, a l’han sotnù che con ël pecà original l’òm a l’é stàit parèj tocà e marcà a feu dal mal che da cost a peul pì nen gavesse e donca le responsabilità ’d minca òm dë ’dnans al mal a vnirìa pì legera e ’d conseguenza a sarìo motobin gropà j’ale a soa libertà. Già costa posission a l’é un bel pòch ant l’eresìa për la Cesa ’d Roma. Ma a-i é chi a l’é andàit pì an là: Calvin e ij Calvinista (soa patria ’d difussion a l’é la Svissera e ’l sènter dë spantiament Zurigh) a diso adritura che l’òm a l’é pa lìber për gnente. Tra Libertà e Predestinassion, l’òm a l’é destinà a fé lòn ch’a farà: a farà la bin se a l’é destinà a fé la bin, a farà ’l mal s’a l’é destinà a fé mal. Nen essendje libertà ma predestinassion, l’òm a farà lòn ch’a deuv fé, sensa libertà, ma ’dcò sensa responsabilità. Ëdcò ij Calvinista as diso Cristian, eretich as capiss për la Santa Roman-a Cesa: për lor a l’é Gesù Crist che an «giustifica», noi i podoma nen feje gnente... «Chërd an Nòstr Sgnor Gesù Crist e it saras salvà»... Pròpi al contrari ’d lòn ch’a dis la Cesa Catòlica: «La fé an Dé e an Gesù Crist, sensa j’euvre a l’é mòrta».
A l’é comsìa interessant consideré coma Olivero an tute soe poesìe andoa ch’a va a dëscore con Dé, bele se restand con sò meud ëd fé agressiv, a trata con Dé a ti për ti: ël Dé dij Cristian a l’é ’dcò Òm, da la testa ai pé e a l’é donca a l’autëssa (e Olivero a lo fà capì da sota) ëd capì j’emossion, ij rasonament, ij sentiment,le manere d’esprimse dj’àutri òmini e a parla con Dé coma s’a parlèissa con n’àutr sò simil. Noi i artrovoma cost ategiament an «Dies Irae», «La preghiera dël sangh» e ant tute cole poesìe ’nt le quaj a-i sia n’arciam a Dé për qualsëssìa motiv.
Domenico Appendino
Traduzione di Michele Bonavero. Pubblicata sulla rivista Piemontèis ancheuj di Torino dell'ottobre 2011.
La prima neuit d’Adam
Di questa poesia esiste un commento all’interno del testo in cui essa è contenuta Rondo’ dle masche, ma quel commento mi pare riduttivo sia rispetto al contenuto poetico dell’opera sia ad una valutazione globale. La poesia affronta il problema dell’Uomo catturato in una morsa tra il Bene ed il Male, l’uomo ha coscienza di questa sua condizione e qui sta il dramma: in fondo i Dieci Comandamenti consegnati da Dio a Mosè sul monte Sinai non sono solo legge positiva fornita “brevi manu” da Dio agli uomini ma sono immagine (e si badi bene, sia che il fatto del Sinai sia avvenuto davvero [circa 1200 anni avanti Cristo] – sia che non sia avvenuto (fosse cioè un racconto di pura fantasia). Si badi bene quella Legge Positiva data da Dio a Mosè suonerebbe comunque solo ed esclusivamente come un “promemoria”, una conferma solenne di una Legge Naturale scritta nella coscienza e nel cuore dell’ uomo fin da quando l’uomo è uomo.
E’ su questo presupposto che si deve innestare il contenuto della poesia .
Dunque La prima neuit d’Adam. Qualcuno si chiederà: ma ne La prima neuit d’Adam, Eva c’entra? … E come no? Certo che c’entra Eva , altrimenti che “prima notte” sarebbe, ma non è la presenza di Eva che turba Adamo in quella prima notte della sua esistenza, anzi di Eva Adamo fa una difesa strenua, la dichiara innocente davanti a sé e davanti a Dio, ma le presenze ingombranti di quel Paradiso Terreste sono quelle di Dio e di Satana o meglio, ciò che turba Adamo , e non lo fa dormire la notte, consiste nel cercare di capire in quali rapporti stanno tra loro Dio ed il Demonio e che cosa “tramano” loro due eventualmente a danno dell’ Uomo che diventa in questa poesia il terzo incomodo…
Ma partiamo dall’ inizio della poesia:
“La luna a Oriente è una vela che splende tra i pesci d’oro del cielo”: Sembra a prima vista un buon inizio, per via dello splendore della falce di luna, ma non lo é. La falce di luna, a forma di vela, è proiettata, sullo sfondo delle stelle lontane, all’interno della costellazione dei Pesci e per questo motivo il cielo lontano viene paragonato ad un mare : c’è una vela, ci sono i Pesci d’oro del cielo, c’è il cielo, quasi un mare profondo, ma quel mare del cielo a causa della notte è oscuro, minaccioso quasi a presagire un tragico destino per l’uomo.. anche se non mancano richiami, qui sulla Terra, a cose gentili: si intravedono le stelle che, quasi lucciole inviano riflessi di luce sulla pelle di Adamo, i fiori, che con l’avanzare della notte chiudono le loro corolle, il canto dei grilli sì… sì… ma nella oscurità della notte c’è anche qualcos’altro … nella nebbia che s’addensa con l’ inoltrarsi della notte profonda si sente in distanza, ma con suono chiaro e distinto, il rumore provocato dal “serpente a sonagli”, la personificazione del Demonio, che sembra cadenzare il tempo di una danza “matta”.
Avvertiamo già l’oscuro presagio di ciò che verrà dopo: ma si prepara anche da lontano il momento della “zuffa” tra Adamo e Dio stesso (qui è Olivero che prende il posto di Adamo, lui che si azzuffava con tutti…). Tu Dio io hai creato l’uomo, hai creato me: per un minuto di amore ci saranno “milioni di secoli di guerre”….
Un giorno - dice Adamo a Dio - tu lascerai morire sulla croce tuo Figlio, il mio germoglio più radioso, insanguinando il mio peccato: qui con una “pennellata” viene sfiorato il mistero dell’ “incarnazione” di Gesù Cristo – Dio che assumerà su di sé la natura Umana per salvare l’uomo dalle conseguenze di quello che sta per accadere nel Paradiso Terrestre ( secondo la tradizione e la scrittura Ebraico-Cristiana) , e per provvedere a questo recupero, a questa Redenzione Gesù Cristo dovrà morire sulla croce. Il tema della Redenzione è appena sfiorato nella poesia di Olivero , ma non è cosa da poco: Gesù Cristo al 100% Dio perché assume da Dio Padre la natura Divina ed al 100% Uomo perché assume dalla Madonna la natura umana prenderà su di sé le “conseguenze” di quella cosa… ma quale cosa ??? Certamente Dio deve aver visto nell’Uomo qualcosa di grande e di importante tra tutte le cose create se ha deciso, ad un certo punto, di condividere con l’uomo la sua stessa natura, la natura umana non è estranea a Dio e Gesù Cristo lo dimostra, per cui essendoci tutto l’ Uomo in Dio e ci sarà forse qualcosa “appena” di Dio in ogni uomo…. La presenza della natura Umana in Dio sorprende e fa meravigliare anche Dante , che nell’ ultimo canto del Paradiso, mentre – in una luce accecante - sta cercando di capire come funziona la circolazione di Amore in Dio tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, annota che… il centro di quella circolazione d’Amore … “mi parve pinta della nostra effige”…. In altre parole: nella luce di Dio che Dante vede, gli comparve, [quasi impressa su una “Sindone”] l’immagine di un Uomo, Gesù Cristo appunto. Questa vicinanza intrinseca tra l’ Uomo e Dio è oggetto di discussione e ripensamenti da parte della teologia Cristiana ma a ben guardare da mille anni, da duemila anni a questa parte nulla è cambiato nell’ impostazione di un tentativo di spiegazione di questo mistero: diversi anni fa sentivo da un teologo Torinese, che andava per la maggiore, Don Andrea Fontana, questa spiegazione forse inadeguata, ma rappresentativa del rapporto Uomo-Dio per i Cristiani.
Dio è Amore, è pienezza di Amore. Per cercare di capire questa cosa noi paragoniamo l’Amore di Dio ad un grosso boccale colmo di birra . La birra, [cioè l’ Amore di Dio] è talmente esuberante e traboccante che tracima sotto forma di schiuma al di fuori del bicchiere e cade a terra …. Sporcandosi…. Ma quella schiuma caduta a terra – l’uomo creato da Dio– è sempre parte integrante dell’amore di Dio, ….e perché l’essenza del suo Amore non vada perso, Egli si china fino a terra – Ecco Gesù Cristo – per recuperare quell’Amore che era sfuggito dall’orlo del boccale…
Se, tornando alla letteratura piemontese, andiamo a ripescare, a distanza di mille anni , i famosi Sermon Subalpin, troviamo una storiella tra quelle 22 prediche che sembra la narrazione di una “fotocopia” di quello che abbiamo appena raccontato : “nella notte dei tempi Dio stringeva tra le mani una perla preziosa e bellissima [ L’uomo ] e nel rimirarla Dio si “gingillava”, si “trastullava” con quella.. ma ad un certo punto inavvertitamente la perla gli sfugge dalle mani, cade, un po’ rotola per terra e poi finisce in una condotta di scarico, una cloaca, una fognatura diremmo noi….. E Dio per recuperare per sé quella perla preziosa si cala nella fognatura alla ricerca della perla, assumendo su di sé la natura Umana e Divina di Gesù Cristo… non so se ho manipolato un po’ il testo di quel Sermone Subalpin, ma non dovremmo essere lontani… dal contenuto …di quel Sermone.
In fondo la teologia – spiegata a braccia alla gente di oggi - non è diversa da quella che si spiegava mille anni fa in lingua piemontese.
Dopo queste divagazioni… usiamo questo termine…torniamo al testo della poesia di Olivero.
Adamo sente il peso della maledizione divina dopo il peccato originale ed anche il mistero della incarnazione e della passione di Cristo gli compare su uno sfondo oscuro e misterioso… ad Adamo, Il suo destino oscuro di morte e l’Inferno in previsione, gli appaiono come una conseguenza diretta del fatto di essere stato creato e di essere entrato nell’ “esistenza” che, per la sua precarietà e i parametri di spazio-tempo che la caratterizzano non gli è congeniale…
Sente anche il peso di essere proiettato nella natura , il verde dei prati e del mondo vegetale ha una sua bellezza intrinseca , ma non separabile da quell’annotazione “lus verda lussiferina” porta luce sì ma richiama anche alla mente il fuoco di Lucifero… E poi c’é l’onda su cui “scivola” gioiosa, risvegliandosi “nuda e ridente” Eva – “mia sorella e mia sposa” dice Adamo – Segue una annotazione che suona come un sorriso, in mezzo alla drammaticità della situazione , come accadde spesso nelle poesie più tragiche di Olivero, parlando Di Eva dice “ nei suoi immensi occhi di opale , l’arcobaleno fa mulinelli, ha raggi di sole per capelli, splende sul Bene e sul Male”… Immensi occhi di opale dunque …ma saranno proprio gli occhi di Eva ? Mi pare un po’ improbabile, altrimenti Eva avrebbe due occhi come Polifemo (lui ne aveva uno solo) Eva ne ha due …. A mio avviso qui il poeta fa riferimento ai seni di Eva. Del resto vedendo davanti a sé Eva nuda la prima cosa a cui corrono gli occhi di Adamo, è giusto che siano i seni e non gli occhi … adesso quegli immensi occhi, riferiti ai seni ….sta meglio…mi sembra più appropriato. Del resto è quel colore opalino-opalescente che mi rinvia alla giusta interpretazione … le areole dei capezzoli del seno di Eva sono di colore marroncino-opalescente e uscendo umidi dall’acqua mandano, a causa del sole basso sull’orizzonte del mattino dei riflessi di arcobaleno ….per farsi un’idea di confronto…. più o meno come le piume scure di un anitra che esce dall’acqua dopo una nuotata, hanno di riflesso i colori dell’arcobaleno.
E poi Eva dai capelli biondi (‘d ragg ‘d sol l’ hai caveij”) prepara un letto di fiori - dice Adamo – per avere il suo cuore sul mio cuore – Eva che rifiuta e rifugge dal “malheur”, perché in seno porta l’ amore, ….Eva che è già mamma di tutte le mamme …. Certo la maternità che presiede alla trasmissione della vita di generazione in generazione . Ma di questo passo, pensando a Eva, ritornano in mente ad Adamo dei pensieri oscuri … perché in conseguenza di quella trasmissione della vita attraverso la sessualità si perpetuerà la specie , la razza , dei discendenti di Caino… di tutti i discendenti di Adamo legati al a corda doppia con il Male.
E qui incomincia improvvisamente ed inaspettatamente l’invettiva aggressiva di Adamo contro Dio : di qui in poi la poesia può anche essere considerata come “allegoria” di una ribellione violenta dell’uomo contro Dio, quasi “figurazione” di quello che è avvenuto davvero sul campo nel Paradiso Terrestre al tempo del peccato originale .
E dice Adamo a Dio facendo riferimento alla creazione dell’ uomo e della donna : “è in quella Tua scintilla di follia il seme della prima famiglia del genere umano perverso, il Tuo paradiso è lontano da questo silenzio profondo, noi siamo soli in questo mondo in cui gli uomini non sono in armonia tra di loro e con le cose e con la natura da cui sono circondati.”
E in più nel rapporto fisico e spirituale Uomo-Donna c’ è qualcosa di oscuro e poco accettabile pur avendo Dio provveduto a creare l’uomo a sua immagine e somiglianza. ( noi - Adamo ed Eva - coppia di Fauni – metà uomini e metà caproni , ma pure caratterizzati dalle Tue fattezze divine…..) .
Ma poi arriva la parte più aggressiva della poesia: Adamo dice a Dio , “ascolta un po’ il rumore sollevato dal Tuo Demonio-serpente che arriva da lontano attraverso la nebbia … dice a Adamo a Dio non è una danza “matta” quella che suona il Demonio – come era parsa in un primo momento all’ inizio della poesia, ma una danza di “gloria” e di “soddisfazione” per aver vinto la “scommessa” [ la gagiura] voluta da Te… quasi che Dio si sia giocato con il Demonio, in una misteriosa partita d’azzardo i destini di Adamo e dell’Umanità intera perdendo di fatto questa scommessa e consegnando l’ uomo ed il suo destino nelle mani di Satana . Per questo il “male” domina i destini dell’ uomo nella storia , soprattutto le guerre e la cattiva conduzione dei rapporti tra l’uomo e l’uomo in termini più generali [ homo homini lupus]
Sarebbe questa la conseguenza di quella oscura scommessa persa da Dio nei confronti del Demonio, avente come posta in gioco il destino dell’ Uomo straziato in una continua lotta tra il Bene ed il Male .
COMMENTO CRITICO AL CONTENUTO ED ALLA TESI DELLA POESIA
Da un punto di vista Cristiano, la tesi sostenuta in questa poesia non è accettabile ed è, almeno per buona parte del suo contenuto, dentro l’ Eresia . La chiesa Cattolica , e non solo essa, sostiene che per quanto si riferisce al racconto del peccato originale , come riportato nel libro del Genesi, non solo ha carattere allegorico per spiegare il Male che è nel mondo, ma anche che l’ Uomo “toccato” dal Male , in conseguenza del peccato originale sarebbe sì, sensibilizzato al male, ma non tanto e non troppo da essere messa in discussione la sua libertà di scelta tra il bene ed il male , il suo “libero arbitrio” insomma, e pertanto se l’uomo rimane libero, resta anche responsabile della scelta effettuata tra il bene ed il male
Non tutti però nel corso della storia della Chiesa hanno accettato questa interpretazione. Storicamente un religioso, Giansenio, ed i suoi seguaci, i Giansenisti hanno sostenuto che con il peccato originale l’uomo è stato così toccato e marchiato a fuoco dal Male che da esso non si può più risollevare e quindi la responsabilità di ogni singolo uomo di fronte al male verrebbe di molto alleggerita e di conseguenza verrebbero fortemente “tarpate” le ali ala sua libertà. Già questa posizione è ampiamente nell’eresia per la Chiesa di Roma . Ma c’è anche chi è andato oltre: Calvino e i calvinisti (La loro patria di diffusione è la Svizzera ed il centro di irradiazione Zurigo,) dicono addirittura che l’uomo non è libero affatto. Tra Libertà e Predestinazione , l’uomo è predestinato a fare quello che farà : farà il bene se è predestinato a fare il bene, farà il male se è predestinato fare il male. Non essendoci libertà ma solo predestinazione, l’uomo farà quello che deve fare, senza libertà ma anche senza responsabilità. Anche i Calvinisti si dicono Cristiani, eretici naturalmente per Santa Romana Chiesa: per loro è Gesù Cristo che ci “giustifica”, noi non possiamo fare niente… “Credi in nostro Signor Gesù Cristo e sarai Salvato”.. Proprio contrario di ciò che dice la Chiesa Cattolica “ La fede in Dio ed in Gesù Cristo , senza le opere, è morta”.
E’ comunque interessante notare come Olivero in tutte le sue poesie in cui entra in colloquio con Dio, pur con la sua caratteristica aggressività tratta Dio a tu per tu: Il Dio dei Cristiani è anche Uomo, dalla testa ai piedi, ed è quindi in grado, [ed Olivero lo sottintende] , di capire le emozioni, i ragionamenti i sentimenti i modi di esprimersi dell’uomo e parla con Dio come se parlasse con un altro uomo. Noi ritroviamo questo atteggiamento in “Dies Irae”, “La preghiera del sangh” e in fondo in tutte le poesie in cui ci sia un richiamo a Dio per qualunque motivo.
Domenico Appendino
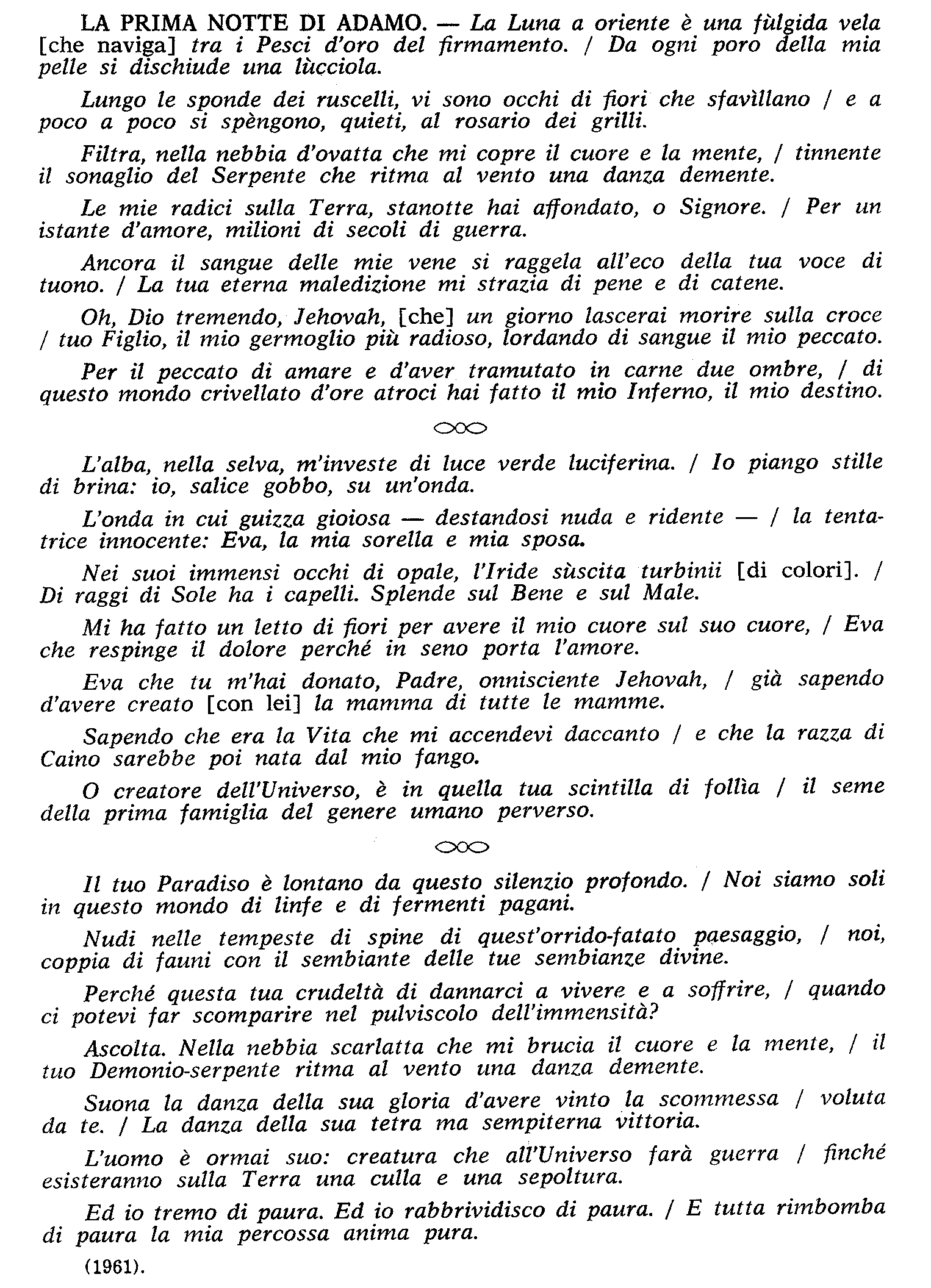
Traduzione di Luigi Olivero da Rondò dle masche L'Alcyone Roma, 1971
Commento alla poesia di Luigi Olivero
Paesagi sota la fioca
La poesia è stata scritta nel 1929, [Olivero ha 20 anni] , ed è ambientata a Villastellone : quasi una fotografia di uno scorcio, di un angolo della città di Villastellone: Il punto di vista del poeta, che come in altre poesie sembra dipingere nei versi come su una tela con pennellate rapide ciò che vede, si situa all’ingresso di Villastellone: chi entra in città arrivando da Santena o da Poirino e passa sotto il ponte della ferrovia, lasciandosi a sinistra il cimitero di Villastellone, incontra un semaforo: praticamente è all’attuale posizione del semaforo che noi troviamo la posizione di scatto della fotografia di Olivero.
Sulla destra rispetto al semaforo troviamo la chiesa di S. Anna, citata espressamente nella poesia, che si affaccia sulla via e l’obiettivo, da quella posizione è puntato verso la piazza del paese che si trova circa 150 metri più avanti (Il paesaggio ritratto, specifica il testo, va da Sant’Anna alla piazza )
E che cosa vede il poeta in questa fotografia ? Tutto il paesaggio è coperto da un manto di neve; su di esso dominano i piccoli pini piantati al di là della recinzione della tenuta del Marchese di Villastellone. Ma appena definito il luogo di riferimento il poeta si lascia trasportare da un susseguirsi di parole in libertà (alla maniera futurista: siamo a vent’anni dalla pubblicazione del manifesto del futurismo). Attraverso il libero sfogo della fantasia risulta arduo trovare un filo logico nella successione dei pensieri: piuttosto in questa prima parte della poesia che ha un sottotitolo specifico Tristitia, lo scopo è quello di mettere in evidenza in maniera irrazionale ed approssimativa la situazione di disagio dello spirito e del corpo suscitata dalle contingenti condizioni di maltempo: la nevicata, il cielo basso e plumbeo, i pensieri di quasi oscuro presagio che questa situazione provoca in persone particolarmente sensibili a condizioni meteorologiche avverse. È inutile quindi cercare di trovare una logica nella gestione dei pensieri e delle parole e delle immagini in questa prima parte della poesia.
Nella seconda parte della poesia che ha per sottotitolo Confiteor il poeta reagisce alla situazione di disagio e di frustrazione che si era venuta a generare nella prima parte e il susseguirsi delle strofe contiene elementi e propositi di volontà di reazione che sono anch’ essi tipici del futurismo e dell’esaltazione dell’ impulso vitale che lo caratterizza.
Qui per reagire ai pensieri di tristezza collegati al cattivo tempo il poeta sfodera la sua proverbiale aggressività verbale: dice ad un certo punto … e se il cuore rantola sotto la percossa di una fitta – quasi un attacco di angina pectoris – voglio che bruci la vita nel rogo dell’ora felice. Questo legare la morte e invocare che la morte arrivi nel momento dell’ora più bella e più felice della vita ricorrerà almeno in un’altra poesia di Olivero avente un titolo alquanto enigmatico Roca-luva-destin .
Anche questo pensiero, l’aspirazione a morire nell’ora della vita più bella e felice, è di ispirazione futurista: non dimentichiamo che la canzone Giovinezza, che verrà in parte stravolta, riadattata e rimaneggiata dal fascismo per altri scopi molto più tardi, negli anni 20, nasce proprio in ambiente futurista nel 1909. Un inno alla vita, ma valida, attiva, aggressiva. Qui non c’è posto per la malattia, la vecchiaia, il decadimento fisico e psichico prima della la morte; tutto deve svolgersi con rapidità e tutto ha da essere consumato in fretta in un rogo di bellezza e di gloria. Del resto Olivero ha vent’anni ed è giusto che sia così.
E aggiunge nel testo della poesia: e l’amore voglio che canti ed il piacere voglio che gridi. Qui l’amore è l’amore fisico, quel cantare non è certo riferito alla richiesta che l’amore, o la persona amata gli canti una canzone: l’amor voi ca canta significa in altre parole che l’amore fisico voglio che canti diremmo noi - come il motore di una Ferrari - a pieni giri ed il piacere che si accompagna all’amore fisico voglio sia pieno e soddisfacente, voglio che gridi e continua : Voglio che l’anima sia una spada nell’acqua santa, in altre parole questa volontà di penetrazione della realtà fisica e spirituale da parte dell’anima del poeta, la penetrazione aggressiva nelle cose della vita da parte del principio di vita, - cioè l’ anima appunto - che nell’immaginario collettivo si associa al rito pagano appena richiamato dell’amor profano” dice il poeta: voglio sia in qualche modo giustificato dalla religione cristiana (l’acqua santa)- Qui forse quasi un ricatto, come a suo tempo la spada [la violenza] dei crociati, trovò la sua giustificazione nella liberazione del Santo Sepolcro di Cristo a Gerusalemme [la spada e l’acqua santa, appunto].
Paesagi sota la fiòca (Tristizia ~ Confiteor)
A Pinin Pacòt
Tristizia
I pin an miniatura
sislà ‘nt un cel ëd giassa
scajo ‘d neir la bordura
da Sant’Ana a la piassa.
Parpajòle ferije
- file drite, antërsìe -
ale càndie, fior càndie,
fiòco le litanie.
E ‘l silensi bianch-reusa
(la grand’ala dësteisa!)
cova l’ànima ofeisa
për ch’a s’ciòda la reusa.
Ma i nassrà na baldanza
ògni rupia ‘ndurmìa
ch’a massrà la speransa
euj-ëd-nita da strìa.
Se ‘l cussin a l’è candi,
s’a dindano le pene,
ël savuj ëd le vene
scor adase, a pié l’andi.
…Mi veuj fé na corona
con le giòie pì fine
për cissela dë spine
l’ora freida ch’a sona.
Confiteor
Nen pioré, veuj, nen meuire.
Gnune nòte doleuire
veuj ch'arsono 'nt le vene
che ti, amor, t'ëm fass piene.
Veuj tenté n'armonìa
faita 'd nòte lontane
con j'andure paisane
vërde-giaje 'd malìa.
Veuj pasié la tristëssa
con ël mòrs e la brila,
con na gòi pì sutila
d'una bianca carëssa.
E se 'l cheur a rantela
sota l'ansa 'd'na sfita
veuj ch'a brusa la vita
ant ël reu dl'ora bela.
Veuj che un crìj ëd vitòria
rompa l'aria dla seira:
foatand l'ala neira
con la fiama dla glòria.
E l'amor veuj ch'a canta!
E la gòi veuj ch'a crìja!
Veuj che l'ànima a sia
una spà 'nt l'aqua santa!
Da Armanach piemontèis 1936
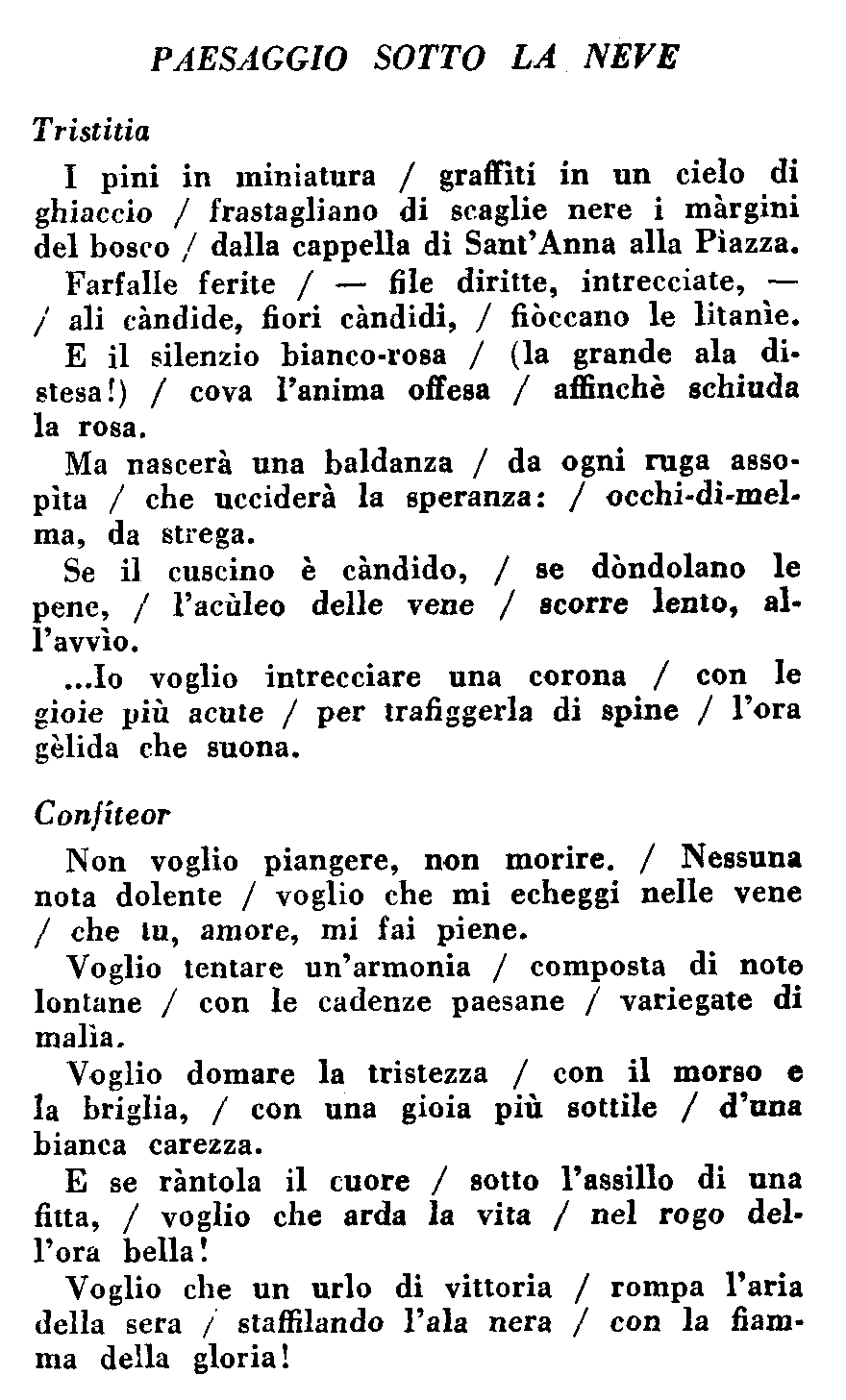
Traduzione di Clemente Fusero tratta da Ij faunèt, Il Delfino, Roma, 1955
Commento alla poesia di Luigi Olivero
Tòrce a vent
Esaminiamo la struttura di questa poesia fatta di 70 versi raggruppati a 5 a 5 in quattordici strofe.
La prima osservazione è questa. Tutte le strofe sono caratterizzate da un contenuto fantastico di riferimento al titolo della poesia. Come se esse dovessero rispondere a queste domande: cosa mi fanno venire in mente, a che cosa posso paragonare le tòrce a vent? Ma anche quali emozioni, quali azioni di movimento mi suggeriscono? Procedendo di questo passo, con l’affollarsi dei paragoni si fa presto ad essere catturati dal colore e dalla plasticità delle immagini in movimento richiamate dal testo e a perdere di vista il termine di riferimento che è nel titolo. Il susseguirsi delle fantasie e delle parole in libertà alla maniera dei futuristi, tende a rendere molto labile il pur sempre presente confronto con il titolo. Questa osservazione vale, a mio avviso, per tutto il contenuto della poesia.
Ma andiamo ad analizzare la struttura delle singole strofe: in linea generale si può vedere che dei 5 versi di ciascuna strofa il 5° verso rappresenta sempre una cesura rispetto agli altri: come una battuta in controtempo. Quasi che il prestigiatore ogni volta, dopo aver tirato fuori dal cilindro le cose contenute nei primi quattro versi, dicesse : toh guarda non me ne ero accorto, é rimasto ancora qualcosa in fondo al cilindro. Inoltre il contenuto dei primi quattro versi risulta a struttura variabile: a volte pur nello sviluppo di una stessa immagine fantastica hanno comunque un doppio riferimento contenutistico: così nella prima, nella terza, nella quarta strofa (in questa quarta e nella successiva ci sono ben quattro differenziazioni di riferimento come versi a sé stanti ad eccezione dei primi due che nel termine di confronto interno presentano un leggero filo di collegamento). Nella quinta strofa due termini di confronto separati contengono la loro spiegazione: al verso 2 ed al verso 4.
Il 5° verso comunque va sempre per conto suo come al solito. La sesta strofa ha una continuità discorsiva pur nel susseguirsi dei colori.
Il 3°ed il 4° verso della settima strofa, possono essere intesi, secondo me, in 2 modi.
Di fatto quella parola sbrincià può essere interpretata come un sostantivo o come un aggettivo: nel primo caso “sbrincià” equivale a “sbrinc” sostantivo, [io personalmente propendevo per questa interpretazione] oppure è un aggettivo allora si collega automaticamente ai “fianch foà ‘d bailadura” sarebbero loro ad essere sbrincià ‘d sang benedì, nell’ altro caso, con il sostantivo, saremmo in presenza di una cesura tra i primi due versi e gli altri due. A questo riguardo ho interpellato il Dottor Delfino Giovanni il quale in base a ricerche effettuate mi conferma che “sbrincià” deve intendersi solo ed esclusivamente come aggettivo. (Visto che sono tirato in ballo, preciso di aver comunicato all'amico Domenico che il lemma sbrincià è un participio passato e, come tale, può essere utilizzato come aggettivo, concordandolo al sostantivo cui si riferisce. Giovanni Delfino)
E siamo arrivati esattamente a metà poesia, il 35 ° verso. Qui succede qualcosa di incredibile. Con il 35° verso io posso continuare imperterrito nella mia lettura e pensare che la strofa successiva possa continuare a contenere termini di paragone fantastici con l’assunto del titolo, e nessuno mi vieta di proseguire su questa strada beninteso, ma succede che da quel verso (il 35° appunto) posso infilare un’altra strada interpretativa che mi porta ad insabbiarmi: il posto dove vado ad insabbiarmi è quello più naturale che ci sia: la sabbia del deserto. Pertanto faccio come colui che deviando dalla pista battuta dalle carovane del deserto finisce fuori pista, s’insabbia e dopo qualche anno se ne ritrova lo scheletro, suo e della jeep senza ruote… bruciate nel tentativo di fare le segnalazioni…
Vediamo come avviene a questo punto la possibile dicotomia interpretativa del testo.
Lasciamo da parte per il momento la strada di confronto del testo con il titolo, seguiamo piuttosto dove sta andando la fantasia del poeta, per aver scritto quello che ha scritto al 35° verso: s-cirpe ‘d musica mòra. Ci chiediamo dove sono i mori, cui fa riferimento il verso? Sono in Africa (banale!), ci trasferiamo in Africa. Ma l’Africa, il continente a forma di cuore, come lo definisce Olivero in Romanzìe, è molto esteso Vediamo se nel prosieguo della poesia troviamo altri indizi. I primi versi della strofa successiva ci portano nel deserto. A partire dal primo verso con bussonà ‘d rose mate (le rose del deserto), troviamo il vento del deserto, il ghibli, e i tramonti di cielo verde. Manca il quinto verso a sé stante: vediamo se contiene un altro indizio in vista dell'insabbiamento: simitare scarlate. Gli arabi li collego alle scimitarre. Quindi ricapitolazione dei primi indizi: siamo in Africa, nel deserto, ci sono gli arabi. Il contenuto della strofa successiva è esplosivo: contiene una indicazione geografica precisa in forma di indizio (come nella caccia al tesoro): Siamo in Egitto, siamo nel deserto che qui assume il colore dello zafferano (rossiccio: la polvere dello zafferano prima di essere cotto con il risotto che lo fa diventare giallo limone!). Su quel deserto, che sembra abbastanza piatto ci sono qua è la delle palme isolate, annota il poeta. Cosa vediamo in Egitto, in mezzo al deserto oltre alle palme sperdue? Dove la terra curva, quasi al limitare dell’orizzonte si vedono trombe 'd sabia e de splue ??? Che cosa sono queste splue? Le trombe di sabbia, le nuvole di sabbia non sono qui sollevate dal ghibli ma vanno a braccetto con quelle splue, il fuoco delle vampe (direbbe Giovanni Pascoli) dei pezzi d’artiglieria, o meglio dei carri armati che corrono sul campo di battaglia nel deserto e sollevano la polvere del deserto. A questo punto il poeta senza dire niente a nessuno, è come se afferrasse il binocolo (ce lo fa intuire) per vedere più vicino la scena della battaglia: e che cosa vede?
Non li vedeva prima da lontano ma, avvicinando la scena, ecco il campo di battaglia con degli aerei da guerra in volo (ale ‘d macchine d’guera) oltre ai carri armati. Ad entrambi gli elementi, aerei e carri armati in battaglia viene conferita una valutazione ed un giudizio positivo, (tra garlande ‘d color e cansson drùe ‘d motor come prevede il manifesto del futurismo).
Questo dru, riferito al rumore dei carri armati, ha in sé qualcosa di irrazionale (le parole ricercate dru e drugia, di origine longobarda, significano in piemontese rispettivamente fertile e fertilizzante, con riferimento alla terra. Pur utilizzate a sproposito qui parlano di uno stato di esaltazione personale e collettiva riguardo a quello che stiamo vedendo) * È descritta qui con poche pennellate una grande battaglia del deserto dell’ultima guerra mondiale. Ma quale? L’ ultimo verso della decima strofa ci fornisce l'indizio, secondo me inequivocabile. Il risultato di quella battaglia visto da parte Italiana.
Tèra ‘d senner amera…. Una battaglia persa che vale la guerra persa. Quale ? Forse la battaglia di El Alamein a 115 Km da Alessandria d’Egitto in terra egiziana, nel deserto egiziano? Gli indizi ci sono tutti. Perché non nominarla ? Forse per una forma di pudore? Per rispetto a quegli italiani che sono caduti in battaglia (ricordo che la divisione Folgore, tra le altre divisioni italiane annientate ad El Alamein, schierava più di 5000 uomini di cui sono tornati a casa solamente in 308, come affermano le cronache. La divisione Folgore è entrata nella leggenda ad El Alamein. Avrebbero potuto ritirarsi o arrendersi. Lo ha fatto anche Rommel disobbedendo all’ordine di Hitler o vincere o morire. Questo suo indietreggiare davanti a soverchianti forze nemiche gli sarebbe poi costato caro.) Gli italiani nò. La Folgore, la divisione Trieste e le altre hanno combattuto fino all’ultimo uomo ed all’ultimo mezzo tanto che Montgomery si è visto costretto a lasciare agli italiani l’onore delle armi. Di armi non ce n’erano più. Disse Montgomery di non aver mai visto nulla di simile su un campo di battaglia. Se qualcuno pensasse che tutto ciò avesse qualcosa di retorico in sé sarebbe invitato a prendere visione dei documentari girati sul campo della battaglia in svolgimento, dall’ una come dall’ altra parte, ora resi disponibili dagli archivi di Stato. Ma questi eroi, definiamoli così, si sono immolati per chi? Per che cosa? E’ la risposta difficile a questa domanda che induce il poeta a stendere un velo di silenzio sul nome della battaglia (quando ha scritto questa poesia, nel dicembre del 1947, a 5 anni da quei fatti ). Il sacrario di El Alamein che contiene i resti di oltre 5000 soldati italiani tra i 17.000 e più morti in quelle zone durante la seconda guerra mondiale, probabilmente non era ancora stato costruito. Lo costruisce in anticipo Olivero con questa poesia. Ma Olivero avrebbe forse da dire qualcosa rispetto alla scritta che campeggia sulle mura di quell' enorme mausoleo ottagonale Quota 33 – qui agli Italiani mancò la fortuna, non il coraggio. Sono sicuro che Olivero la riterrebbe un tantino incompleta e forse anche ingiuriosa e scriverebbe forse così: Qui gli italiani, di fronte a soverchianti forze nemiche per uomini e mezzi, piuttosto che arrendersi o indietreggiare preferirono farsi annientare e sono entrati nella leggenda in ossequio a quei principi di esaltazione della Volontà , del culto della guerra per sé stessa, il tutto condito da una prevista buona dose di Irrazionalità cui per 20 anni erano stati educati in patria, principi che in fondo affondano le loro radici nel manifesto del futurismo del 1909. Del resto questo è il contenuto (reso da me un po’ più prolisso) dell’ intera decima strofa. Quasi un consuntivo a posteriori, del bene e del male sulle conseguenze dell’applicazione del contenuto nel testo del manifesto del futurismo che ha così condizionato fortemente a livello mondiale il modo di essere degli uomini e lo svolgersi degli avvenimenti nel corso della prima metà del secolo XX.
E quelli che non hanno percorso nella lettura questa strada interpretativa ? Beh, si saranno accontentati della sequenza delle parole in libertà e del loro tenue legame con il titolo della poesia, salvo rendersi conto che comunque, ad un certo punto, c’è un chiaro riferimento al contenuto del manifesto del futurismo nella decima strofa.
Dopo l’ultimo verso della decima strofa la fantasia riprende il largo con altri paragoni e confronti con le tòrce a vent del titolo, sempre con la stessa struttura zoppa (4 versi più uno scollegato). Ma se il finale della strofa undicesima sembra sfociare in un non-sense (euj d’ olive ant le gèrle) quella successiva accenna al male di vivere del poeta. Forse lo svanire di quegli ideali a cui anche lui stesso aveva creduto nel periodo fra le due guerre, oppure vissute vicende personali.
Nelle ultime due strofe le tòrce a vent riacquistano progressivamente importanza ed identità.
L’ultima strofa è a mio avviso un capolavoro: oltre a contenere un esplicito quanto inaspettato atto di fede cristiano nell’immortalità dell’anima umana e nella speranza di una vita futura, quelle torce a vent diventano persone vive a cui Olivero si rivolge direttamente, parla con loro e dice in fondo questo: nella notte del passaggio mio dalla vita alla morte, fatemi un po’ di luce, fatemi intravedere almeno la strada verso la Luce più grande (La luce di Dio, quella che ha visto Dante nell’ultimo canto del Paradiso, per intenderci). Davanti a quella luce lo sta aspettando, da un anno circa, la mamma. (Innocenza Perlino, morta il 16 novembre 1946, questa poesia porta la data del 7 dicembre 1947). Ma è su quella ultima parola il silenzio di mia mamma che mi voglio soffermare. Silenzio sarà stato scelto a caso? Credo di no. Credo che, in fondo in fondo, quel silenzio si colleghi ai paesaggi africani prima richiamati, a quei luoghi in cui stanno in silenzio i caduti nel deserto africano. Perché? 20 anni fa, nel 1990, stavo facendo un giro turistico tra le oasi del deserto Algerino, eravamo una ventina di persone, una specie di Armata Brancaleone La guida araba che ci accompagnava, un impiegato statale, perché in Algeria il turismo è azienda di stato, (O.N.A.T Organization Nationale Algerienne Tourisme) passando vicino ad un cimitero nel deserto ci chiese: come lo chiamate al vostro paese il cimitero? Noi rispondiamo, lo chiamiamo il camposanto. Egli replica sapete come lo chiamiamo noi arabi qui nel deserto?: Il giardino dei silenziosi.
Ecco la mamma di Olivero riposa nel giardino dei silenziosi di Villastellone e oggi anche l’autore di quel verso sta vicino a lei. (Dalla fine di luglio del 1996)
Domenico Appendino
* Il termine drùe utilizzato però da Olivero come druve ne Ij faunèt a pag. 161, (drùe nella revisione pubblicata in Romanzìe) viene tradotto da Clemente Fusero, ovviamente con l'avvallo di Olivero, canzoni fervide di motori e in francese da Anton Francesco Filippini ardentes chansons des moteurs. Dizionari differenti dal Gribaudo, forniscono termini ben differenti da fertile. Ad esempio il compianto Giovanni Magnani, nella sua bella pubblicazione Mila bele paròle piemontèise, dove prende in considerazione termini a volte desueti, traduce drù con robusto. Non mi pare quindi che Olivero abbia usato il termine a sproposito. (Giovanni Delfino)
Tòrce a vent
Yo tengo el fuego en mis manos.
Federico Garcia Lorca
Fiame, rosse caviere
che spatare ant ël vent
le farfale d'argent
ëd le spluve legere.
Fiame, rosse bandiere.
L'hai sercà 'd carësseve
pen-a vistve, da cit:
ché 'm cissave un invit,
n'anvìa fòla 'd baseve.
Spricc ëd sangh ch'iv soleve.
Mese lun-e 'd faussije
anfiorà, come 'd làver,
dë spi 'd gran e 'd papàver
sota 'n vòle d'avije.
Lenghe 'd fàun cioch ëd rije.
Crëste vive 'd galòro
come giòle 'd sufrin;
doje përgne dël vin
dle vos càude dij còrp.
Feuje 'd vis ch'a s'andòro.
Foèt giàun ch'a s-ciuplisso
dësneudà come 'd sèrp;
tra la fum ëd ji stèrp
euj ëd brasa ch'at fisso.
Cove 'd tigri ch'as drisso.
Cheur avisch d'alegrìa
ant la neuit frissonant
con rifless ëd diamant
cangià 'n feu për magìa.
Cornà 'd tòr ëd Sevija.
Fianch foà 'd bailadora
ch'a së stòrzo 'd piasì
sbrincià 'd sangh benedì
dël Crist nu con j'òss fòra.
S-cirpe 'd mùsica mòra.
Bussonà 'd reuse mate
'nt ij tramont ëd cel vèrt
che l'hai vist sui desèrt
con ël ghibli a combate.
Simitare scarlate.
Reu 'd colàne torzùe
'd mausolei egissian
'nt j'orizont ëd zafran
tajà 'd palme spërdùe.
Trombe 'd sabìa e dë splùe.
Ale 'd màchine 'd guèra
tra garlande 'd color,
canson drùe 'd motor
ch'a rimbombo 'n sla tèra.
Tèra 'd sënner amèra.
Scaje 'd pèss tra le fèrle
dij boschèt ëd coral
sota ij mar stërnì 'd sal
e 'd cuchìe orlà 'd pèrle.
Euj d'olive ant le gèrle.
Fiame! Stèile marin-e
fëstonà 'd zora ij sen
dl'Aventura ch'a ven
coroneme dë spin-e.
Òh, ij mè seugn, mie ruvin-e!
Ma sul nèir païsagi
dla mia vita 'd torment
àusso un pugn prepotent
con na tòrcia 'd coragi.
E 'n sorch, ross, l'é mè viagi...
*
Tòrce a vent, crij ëd fiama
ant la neuit sensa fin:
compagné mè destin
vèrs la lus doa lo ciama
ël silensi 'd mia Mama.
Da Ël Tòr N° 31/32 del 12/1947~1/1948. (Anche su Ij faunèt 1955 e Romanzìe 1983)
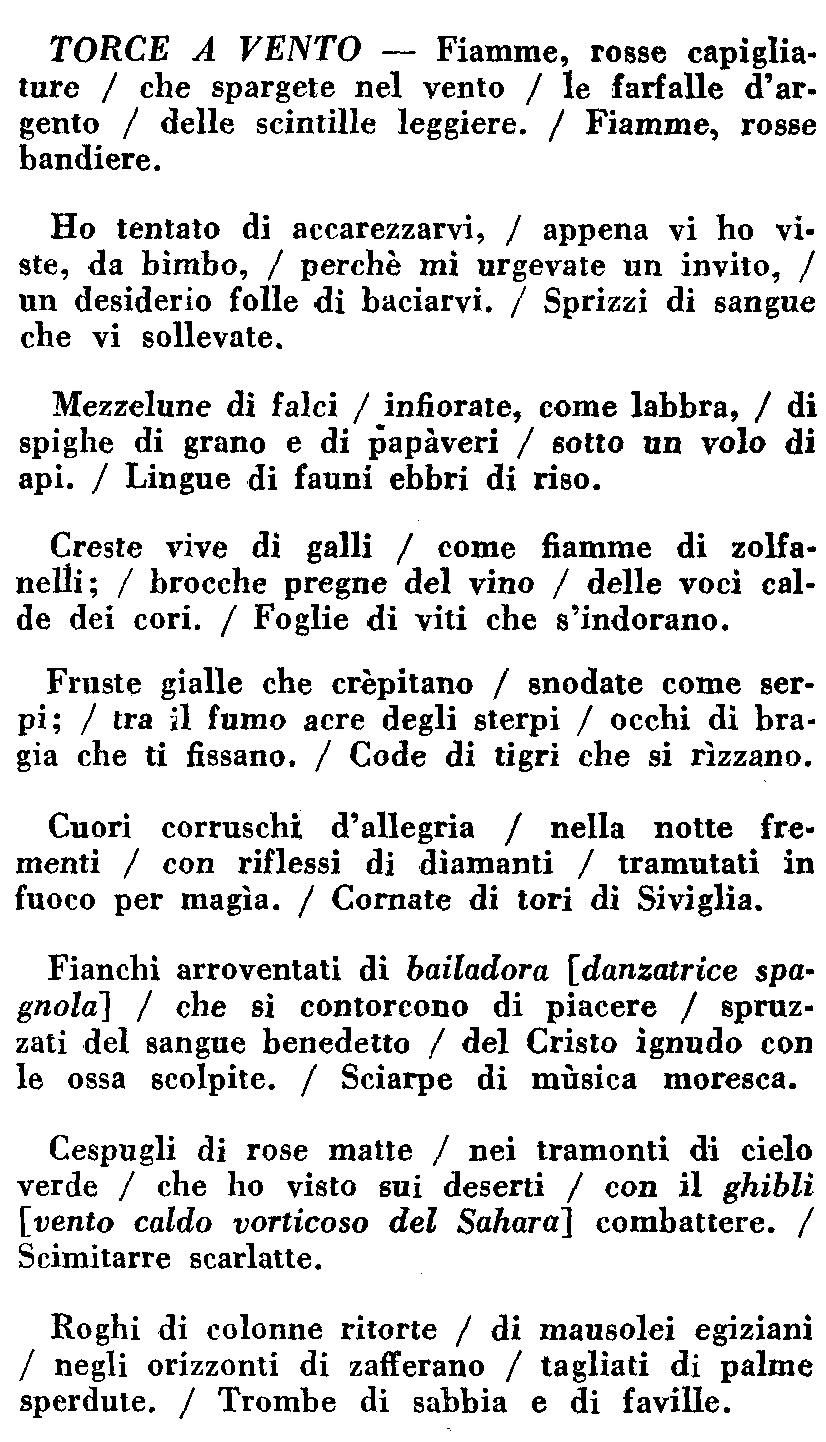
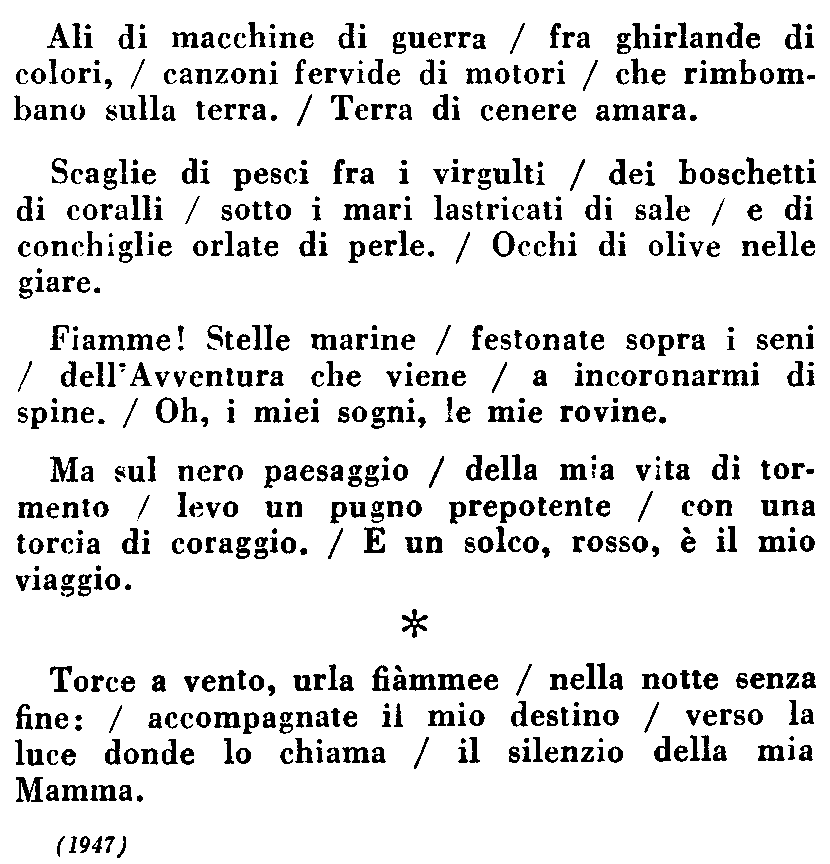
Traduzione di Clemente Fusero tratta da Ij faunèt Il Delfino, Roma, 1955
Alcune poesie di Luigi Olivero della raccolta Ij faunèt sono caratterizzate da un titolo spezzettato, vale a dire, le parole che costituiscono il titolo sono legate tra loro da un tratto di penna. Nella raccolta appena citata ne troviamo tre: Seugn-mignin, Lun-a-bal-sovnir e Ròca-luva-destin. Si tratta di sonetti, composizioni poetiche costituite da 14 versi , due quartine seguite da due terzine di endecasillabi. La prima poesia citata si può configurare come un idillio ove il poeta narra dell’addormentarsi, del suo prender sonno in compagnia di un gattino con un richiamo nel finale ad un ricordo struggente della sua primissima infanzia. La seconda poesia trae spunto ed occasione dalla vista, giù in fondo alla valle, di una balera, che rimanda in alto, verso il suo punto di osservazione, bagliori di luci, di suoni e di colori a cui segue un rapido collegamento a ricordi, quasi rimpianti, di sua gioventù. La terza ha un tono e un contenuto assolutamente diverso: questa poesia si differenzia da tutte le altre perché è a mio avviso enigmatica: insieme futurista, di introspezione e ha in sé qualcosa di magico. Certo ad una lettura affrettata può sembrare come espressione di aspirazione all’auto-annientamento nel momento dell’ora più bella e felice, come avviene del resto anche in un verso di un’altra poesia, del periodo giovanile Paesagi sota la fiòca. Finire la vita, sul più bello. Proprio un’ambientazione futurista, se vogliamo, ma qui vorrei tentare una interpretazione più fantasiosa, ma anche più azzardata.
Quando ho letto il titolo per la prima volta Ròca-luva-destin, senza conoscerne ancora il contenuto, sono stato automaticamente indotto a vedere un collegamento quasi una associazione di idee tra le due ultime parole del titolo luva e destin. Il motivo è semplice: la parola ultima destin impone di associare ad essa una lupa. Sì, ma attenzione, una lupa e una sola : la lupa capitolina, quella statica, per intenderci, con la testa rivolta da un lato, attenta a ciò che succede attorno (a l’avàit, dice il poeta) nell’atto di allattare e proteggere Romolo e Remo: è la lupa che troviamo ancora oggi nei palazzi del potere e della politica a Roma. Ecco: questa lupa richiama alla mente i fasti dell’antica Roma, della sua fondazione nel 754 a. C. I suoi primi re (i sette re di Roma) e via via i fasti del potere e della grandezza: i fasti imperiali. I destini di Roma insomma. Ma quasi a farlo apposta quei sacri destini di Roma imperiale sono stati fatti rivivere, in maniera molto retorica, un po’ goffa ed artificiosa, anche dalla dittatura italiana nel corso del XX° secolo, nel periodo tra le due guerre: qui la retorica del periodo fascista ha dato grande importanza ai santi destini di Roma. Era addirittura stata ripristinata come festività civile da celebrare in pompa magna la data del Natale di Roma: il 21 Aprile, il tutto organizzato con le parole e con i fatti per cercare di far rivivere i fasti dell’ Antica Roma Imperiale.
Non solo: tra il 1935 e il 1937 con la conquista militare del Corno d’Africa ed il consolidamento del possesso dell’Abissinia, della Somalia, dell’Eritrea e della Libia , si era ricostituito il famigerato Impero: il re d’Italia, Vittorio Emanuele III, assunse il titolo di Imperatore. Nelle Colonie e in Italia vennero portate avanti grandi opere di bonifica volute da Roma imperiale: fondazione di città, strade, ferrovie e via di questo passo. Tanto che tra il 1936 e il 1937 la dittatura di Mussolini, all’ombra dell’Impero, era riuscita a procurarsi un consenso molto vasto tra la popolazione; l’opposizione al regime era stata messa a tacere, non solo grazie alla repressione di polizia, ma anche per i risultati reali di stabilità politica ed economica: la Lira italiana era in quel periodo moneta di riferimento a livello mondiale, era insomma l’apoteosi del fascismo e del suo capo indiscusso. Ma….ma... ma... Il tempo passa, le cose si complicano, gli uomini invecchiano e invecchiando è inevitabile che vadano ad incappare in qualche errore, in qualche disavventura. Cavalcando incautamente l’onda dei precedenti successi scivolano maldestramente in qualche errore di valutazione cui consegue la polvere, la morte violenta, il vilipendio a futura memoria, come è successo per davvero per l’ eroe della nostra Storia.
Partendo da queste considerazioni un po’ fantasiose, ma non troppo….vediamo quale interpretazione possiamo dare, possiamo azzardare…. al contenuto dei 14 versi di questa indimenticabile poesia di Olivero….
Nel primo verso la voce narrante, cioè il poeta, (ma potrebbe essere, secondo il procedere della nostra fantasia, anche l’imperatore, il capo o il dittatore, in una atmosfera serale di assoluta solitudine – la solitudine del capo che cavalca il potere) parla con uno spuntone di roccia, a tu per tu, come se fosse una persona viva. Siamo su un'alta montagna e non ci accorgiamo lì per lì che egli sta cavalcando questo spuntone di roccia proteso nel vuoto; sembra piuttosto che la voce narrante stia osservando questo spuntone di roccia da una posizione sicura, più arretrata rispetto al precipizio. Ma subito dopo ci accorgiamo che non è così: egli sta a cavalcioni di quella roccia che si protende sul burrone e quella pietra sembra possedere le fattezze della testa di un lupa nera. Addirittura il sole che tramonta, dalla sua posizione bassa sull’orizzonte, accende una luce negli occhi scavati della lupa di pietra: doe luzentele d’òr visco na spluva - Due lucciole d’oro accendono una scintilla. L’ambientazione insomma conferisce a quel simulacro di lupa capitolina qualche cosa di misterioso ed eccitante per chi guarda con occhio futurista, ma anche qualcosa di inquietante per un osservatore che guardasse con gli occhi del disincanto.
Ma intanto la roccia agli occhi della voce narrante - quella roccia - sembra davvero essersi trasformata nella lupa della nostra Storia. Animata da occhi di fuoco, la lupa fissa la valle giù nel profondo dove una grande quantità di persone - si potrebbe arguire dal contesto - si addormenta, dice il poeta, in un letto caldo di piacere. In questo piacere si potrebbe con un po’ di fantasia intravedere il compiacimento, il sostegno della gente per i risultati di grandezza, di bellezza e di potenza raggiunti dal dittatore: insomma la gente ed il dittatore si sostengono e si compiacciono a vicenda. Qui viene spontanea una osservazione: nessuna dittatura, neanche la più efferata e sanguinaria può stare in piedi se non è sostenuta da una qualche forma di consenso popolare, espresso o implicito: quando viene a mancare il consenso popolare tutto crolla. Recenti fatti sui teatri politici più disparati, a livello mondiale, lo dimostrano. Ma a questo punto la poesia, sul volgere del finale, presenta un fulmen in clausola inaspettato ed imprevedibile: il poeta, il dittatore, il sovrano, al massimo della sua popolarità sfida la lupa, che egli sta cavalcando a cedere, a rompersi. Non la sfida, anzi, ma la invita e la sollecita a rompersi lì per lì all’improvviso e senza indugio per poter precipitare nel burrone, fermare per sempre l’attimo di bellezza, di gloria fuggente e di consenso con la morte. Pìù in là c’è il Paradiso: con queste parole termina il testo della poesia.
Quasi a dire che se il dittatore fosse morto per una causa qualsiasi interna od esterna in quel momento di gloria, la sua fama sarebbe stata fissata per sempre in positivo nei libri di Storia al posto della condanna e del ludibrio.
Questa potrebbe essere una interpretazione della poesia.
Ma devo aggiungere una annotazione di commento per quei lettori che ritenessero questa interpretazione un tantino troppo fantasiosa.
Supponiamo per un istante che sia il poeta a parlare con sé stesso, per se stesso e con la lupa senza il coinvolgimento di altre persone.
Il discorso appena concluso vale allo stesso modo anche se il poeta l’avesse rivolto a sé stesso: in un’altra poesia - già citata all’inizio di questo commento e scritta forse 25 anni prima - Paesagi sota la fiòca Olivero dice ad un certo punto e se ‘l cheur a rantela / sota l’ansa d’na sfita, / veuj ch’a brusa la vita / ant ël reu ‘d l’ora bela. E se il cuore rantola sotto la pressione di un fitta, voglio che finisca la vita (la vita vada bruciata) nel momento dell’ora felice. Qui è lo stesso pensiero di quel più in là c’è il Paradiso! Morire nel momento dell’ora più bella: un concetto che possiamo considerare tipicamente futurista.
Certo è un po’ inusuale e raro che qualcuno si auguri di poter morire nel momento dell’ora più bella in quanto per tradizione Amore e Morte quasi a dire Felicità e Morte sono alla base di tutte le tragedie più classiche.
Ma allora ci si potrebbe chiedere chi siano, cosa vogliano questi futuristi. Ci sono ancora dei futuristi oggi con queste aspirazioni (e a questi chiari di luna) in giro per il mondo? Segue immediatamente un’altra domanda: futuristi si nasce o si diventa?
Leggevo in questi giorni su internet la lista completa (a oggi) degli scalatori, meno di una trentina in tutto il mondo, che hanno conquistato tutti e 14 gli ottomila della terra. Faceva seguito una lista di scalatori, almeno 15, che sono morti tragicamente nel tentativo di portare a termine la stessa impresa (chi aveva già scalato 3 ottomila, chi 6, chi 8, chi 10) e con queste valutazioni di rischio (a oggi) c’è chi persevera. Che dire? Saranno questi i futuristi di oggi? Rischio di morte a braccetto con la felicità, la massima aspirazione? Gabriele D’Annunzio aveva coniato un motto per i volontari che andavano alla guerra in Africa; ricamato su un pezzo di stoffa veniva cucito sulla divisa: recitava così …e la morte a paro a paro […e la morte vicina-vicina]: il massimo dell’aspirazione per poter raggiungere la felicità. Forse futuristi si nasce per poter sfidare, per altro verso, il destino e la lupa che sta sulla montagna: con la morte a paro a paro.
Domenico Appendino

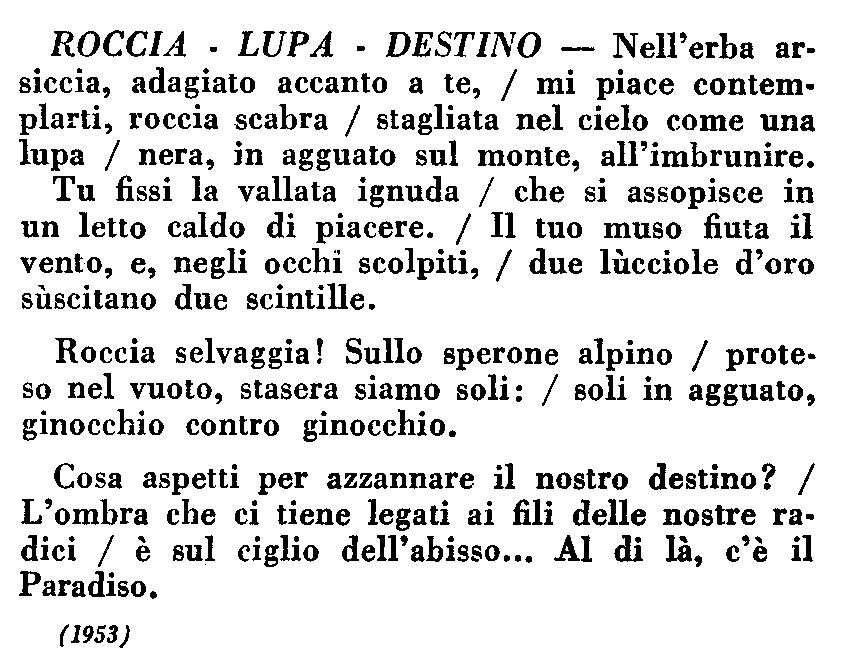
Traduzione di Clemente Fusero tratta da Ij faunèt Il Delfino, Roma, 1955
COMMENTO E CONSIDERAZIONI
SULLA POESIA DI LUIGI OLIVERO
TÈRA PAISAN-A
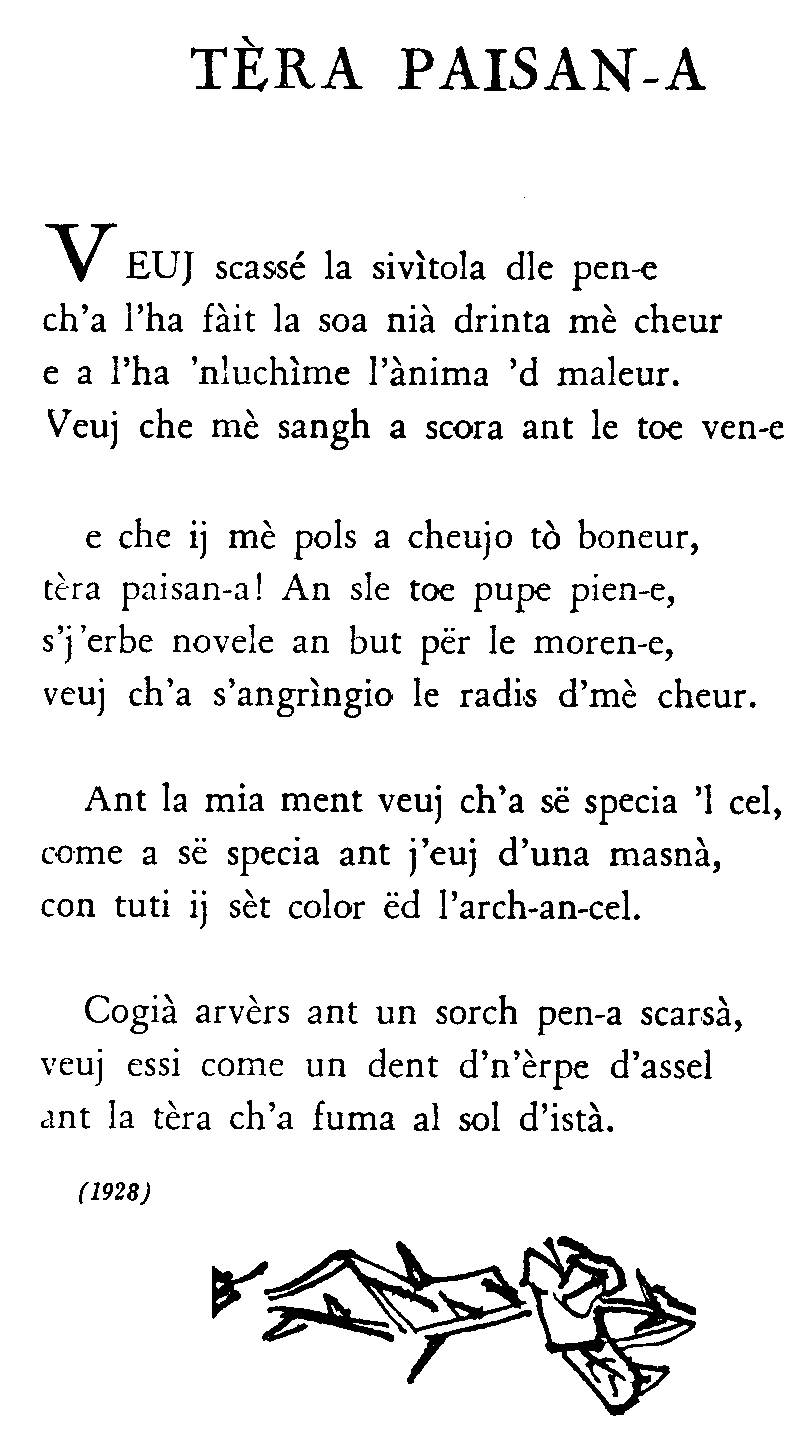

Traduzione di Clemente Fusero da Ij faunèt, Il Delfino, Roma - 1955
Il rischio che questo sonetto di Olivero, di rara bellezza, passi sotto silenzio è da collegare al fatto che, ad una lettura affrettata, il suo contenuto appare, a prima vista, piuttosto datato. E’ del 1928 (almeno quella è la data riportata in calce alla poesia nella raccolta Ij faunèt), quindi risale al periodo giovanile della produzione poetica di Olivero, all’incirca ventenne.
Quell’atmosfera di idillio, che pervade il testo, almeno all’apparenza, non sarebbe comprensibile ai giorni nostri.
La terra in rapporto al mondo agricolo.
Ma qui, nel testo, il rapporto con la terra si trasforma in un rapporto sessuale, in un amplesso vero e proprio raccontato in maniera fantastica, di assoluta originalità.
Un incontro sessuale con la terra descritto fin nei minimi particolari. Il poeta, il contadino, si identifica con la terra fino a riconoscere in essa la donna amata.
Esaminiamo il testo della poesia.
Fin dall’inizio il poeta esprime la volontà di reagire ad uno stato di frustrazione, di infelicità, di incerta definizione e provenienza, con queste parole: voglio scacciare la civetta delle pene che ha costruito il suo nido dentro il mio cuore e mi invaso l’anima di infelicità. E seguita Voglio che il mio sangue scorra nelle tue vene e che i miei polsi raccolgano il tuo piacere, Tèra Paisan-a! Le parole maleur e boneur nella lingua piemontese possono accogliere in se stesse sfumature diverse: non solo infelicità e felicità, ma anche piacere (in parte simile a goj come in questo caso), ma anche abbondanza e fortuna. Nelle frasi appena trascritte ci sono già i presupposti dell’incontro sessuale a cui il poeta fa riferimento: i polsi avvinghiati alla terra sono quelli sui quali si risentono i frisson dell’amplesso amoroso quando dice voglio che il mio sangue scorra nelle tue vene, richiama alla mente un suo altro verso di quegli stessi anni tratto da Paesagi sota la fiòca: …nessuna nota dolorosa voglio che risuoni nelle vene che tu, amore, mi fai piene, cioè mi rendi turgide: il significato fisico-sessuale è evidente.
Il significato di quei due versi alla fine della prima quartina della nostra poesia Tèra Paisan-a diventa così inequivocabile .
E a chi si rivolge il poeta nello scrivere quei due versi? Ce lo dice subito dopo con l'esclamazione Tèra Paisan-a! A lei si rivolge come a persona viva e la chiama per nome. Ma ritorna subito dopo all’annotazione sessuale …sulle tue pupe piene (vale a dire sulle tue mammelle turgide, di latte beninteso). Qui, sul richiamo a quelle mammelle turgide, la terra sembra assumere delle forme vagamente giunoniche. La terra vista come rappresentazione della fecondità della prosperità e dell’ abbondanza quasi una figurazione della dea Cibele dell’antichità, di cui mi è capitato di ammirare le statuette di terraccotta in diversi musei del medio oriente, particolarmente nel museo archelogico di Ankara in Turchia. Quindi la terra dalle forme di una donna prosperosa simbolo di fertilità, di fecondità e di abbondanza. Orbene, dice il poeta, voglio che sui tuoi seni prosperosi, sulle erbe novelle in germoglio sulle moren-e attecchiscano le radici del mio cuore. Il termine moren-e è di difficile traduzione in italiano: si tratta di quelle parti limitate di terreno dei fondi agricoli coltivati a prato che venivano parzialmente dissodate, arate ed intensamente concimate per poter poi trasferire, in autunno, da quella zona a tutta l’area del prato uno strato di humus produttivo: la moren-a serviva quindi anche da luogo di raccolta, in campagna, del concime naturale proveniente dalla stalla. La moren-a costituisce quindi la delimitazione di quello spazio adibito a particolari cure come supporto di concimazione per il tutto. Oggi questa annotazione non è più attuale perché il concime naturale, lo stallatico, viene ammucchiato in modo meccanico ed automatico fuori della stalla per essere poi all’occorrenza trasportato e distributo con macchine che provvedono alla sua dispersione immediata su tutta la superficie del prato, rendendo quindi inutile la moren-a. Inoltre l’uso intensivo di concimi chimici di sintesi ha ridotto anche e di molto l’impiego di concime naturale.
Ebbene, sui seni e sulle erbe novelle in germoglio sulle moren-e voglio che attechiscano le radici del mio cuore. Qui cuore costituisce ancora un richiamo, benchè attenuato, alla sessualità.
Se l’aspetto sessuale sembra affievolirsi nel verso successivo: Voglio che nella mia mente si rispecchi il cielo come si rispecchia negli occhi di un bambino, con i sette colori dell’arcobaleno, nel finale non ci sono più dubbi: coricato a pancia in giù, sopra un solco appena aperto (dall’aratro) voglio essere come un dente di erpice di acciaio sulla terra che fuma al sole dell’estate: quel dente di erpice di acciaio a cui fa riferimento, senza mezzi termini è figurazione ed essenza dello strumento di quell’atto sessuale che egli mima nei confronti della terra con cui è direttamente a contatto.
Quel cogià arvèrs: ha il significato a mio avviso di coricato a pancia in giù anche se esiste un forte dubbio al riguardo: qualche vocabolario piemontese traduce cogià arvèrs inequivocabilmente coricato a pancia all’aria.
Ma in almeno altre due poesie quel cogià senza la precisazione di arvèrs ha in Olivero il significato di coricato a pancia all’aria (confrontare la poesia Message: mentre ero coricato tra spighe di grano e papaveri un farfalla vellutata mi è volata sulle labbra: certamente quella farfalla non avrebbe potuto posarsi facilmente sulle labbra del poeta se egli fosse stato coricato a pancia in giù. E in un'altra poesia Lë stronel Olivero scrive: tra i peli dello stomaco – (é coricato in campagna mentre piove al sole, precisa) mi brilla una piccola guerra di mosche e farfalle accese da raggi bollenti: se fosse a pancia in giù il testo non avrebbe senso. Pertanto, a mio avviso, l’interpretazione corretta potrebbe essere questa: cogià = coricato a pancia all’aria, cogià arvèrs = coricato a pancia in giù.
In ogni caso, che sia coricato a pancia in giù o a pancia in su quel dente d’erpice di acciaio rivolto verso la terra o verso il cielo è figurazione e sostanza di un simbolo fallico a tutti gli effetti, quasi un menhir modernamente interpretato.
Fin qui la lettura e l'analisi dei versi della poesia, parola per parola, per meglio comprendere testo e contesto. Ma andiamo oltre…
Leggendo e rileggendo la poesia, alla luce di questa interpretazione, ho avuto l’impressione di aver già visto in passato qualcosa di simile al cinema e come in un barlume di memoria mi è venuto in mente il titolo del film: Novecento di Bernardo Bertolucci del 1976 .
Sulla scorta di questi pensieri sono andato a cercare su internet se per caso avessi potuto trovare qualche riferimento alla scena di cui avevo un vago ricordo.
Tramite Google ho trovato ampi riferimenti a quel film che, a suo tempo, ebbe un grande successo di pubblico e forse anche di critica. Varie scene di breve durata, tratte dal film, sono state scaricate da persone volenterose e sono disponibili in rete.
Per un caso fortunoso ho trovato che qualcuno, aveva anche scaricato la scena del film che io cercavo: due protagonisti, più bambini che adolescenti, mimano in aperta campagna la scena di un rapporto sessuale con la terra .
Chissà che, circa cinquant’anni dopo, Bernardo Bertolucci abbia letto questa poesia di Olivero, magari tradotta, e da essa abbia tratto spunto per la scena del film?
Ma non è più la Terra di Olivero e con l’ambientazione di Tèra paisan-a non ha nulla da condividere.
Qui il rapporto sessuale si configura come una violenza, uno stupro alla terra, consumato oltretutto contro natura (mi si conceda questo termine ormai desueto a questi chiari di luna nostri di una cultura-non-cultura). Quello stupro mimato avrebbe forse nel testo del film la valenza di una rivalsa, di una vendetta da parte del contadino nei confronti del padrone della terra, a mio modo di vedere, quasi una violenza uno stupro consumato nei confronti della donna, della moglie del padrone: quell’atto descritto come una cosa bella, e quindi positiva, dalla poesia di Olivero (quasi a voler fecondare la terra) nel rapporto uomo-terra di Bertolucci diventa una bruttura, quasi a volergli conferire una valenza sociale e politica di rivalsa. Bruttura, violenza , prevaricazione da consumare in pompa magna sull’altare della celebrazione della lotta di classe.
Certamente la tela di Pellizza da Volpedo, Il quarto stato , che fa da sfondo ai titoli del film, nella sua bellezza e nella sua grandezza mi sembra un tantino deturpato dal contenuto reale del film. Quel film, nei miei vaghi ricordi, pur nella grandiosità degli intenti e delle scene, con la presunzione di voler dividere politicamente e socialmente l’umanità tra buoni e cattivi, rossi e neri, sembra a me alimentare in maniera surrettizia e artificiosa quei contrasti che, in altro contesto, nel 1936 portarono a morte Garcia Lorca considerato non antifranchista schietto ma tiepido nei confronti del franchismo. Non dimentichiamo che fu proprio quel suo non volersi schierare, assieme alla sua omosessualità dichiarata a decretarne la morte.
Del resto parlando di grandi film, o presunti tali, di qualche anno antecedente a Novecento mi viene in mente Africa Addio. Anche in quel film c’è qualcosa di corrosivo come in Novecento ed altrettanto condannabile a mio modo di vedere (il giudizio non impegna che il sottoscritto). In forma subdola, sottile, corrosiva, in fondo Africa Addio sostiene la tesi che i bianchi sono meglio dei neri, ovvero i neri sono in fondo peggio dei bianchi. Base ed essenza di tutte le forme di razzismo passato, presente e futuro.
Ma a parte questo confronto dal risultato infelice tra la descrizione della poesia e la scena del film, su Tèra Paisan-a e su quello che si è consumato poi davvero all’ombra dei fatti narrati in Novecento si possono costruire, col senno di poi, delle importanti considerazioni fatte apposta per smontare le possibili mistificazioni su quello che è avvenuto in seguito.
Dunque, se nel periodo tra le due guerre l’agricoltura in Italia aveva un suo posto di prestigio e in fondo non c’era sentore di una lotta di classe tra contadini e padroni (tra gli agrari e i lavoratori della terra) i motivi erano diversi: prima di tutto il prezzo più alto pagato dall’Italia alla grande guerra andò a pesare sul mondo contadino: la maggior parte dei caduti sul fronte italiano erano di estrazione contadina: ce lo ricorda, se ce ne fosse bisogno, la poesia di Olivero Dies Irae. Con la fine della guerra quel mondo contadino faticò non poco per ritornare ad una fase di sviluppo pur sostenuto dal nascente regime, (ricordiamo per esempio le terre e le case distribuite in Piemonte proprio nelle campagne di Villastellone, Carmagnola, Poirino ai contadini Veneti che avevano visto le loro terre di origine sconvolte e rese impraticabili dalle scorrerie della guerra). Ma l’agricoltura incominciava a subire i contraccolpi di una prima affermazione della rivoluzione industriale (sarà forse a questo cui si riferisce Olivero nei primo verso della poesia?). Sta di fatto che solo dopo la fine della seconda guerra mondiale scoppia la lotta di classe tra i contadini: i lavoratori, i braccianti da una parte e i padroni, gli agrari dall’altra. Ma la riforma Agraria messa in piedi dall' Italia Repubblicana dopo la fine della guerra si rivelò peggiore dei mali che avrebbe dovuto, voluto o preteso curare. Solo l’incalzare della rivoluzione industriale, che cancellò in modo definitivo l’antico mondo contadino, riuscì a stendere un velo di pietoso silenzio sul flop di quella riforma agraria tanto sbandierata.
Mi è capitato di trascorrere, nella stagione estiva, diversi periodi di ferie nel profondo sud d’Italia, nel basso Salento: per intenderci l’estremo lembo sud della Puglia, nel corso degli anni ’80. La Puglia ancora oggi è considerata a buon diritto il granaio d’Italia, ma l’estremo sud di quella regione, brulla e arida, è in gran parte in stato di quasi abbandono. Andando a passeggio per la campagna desolata di quella regione, si trova di tanto in tanto qualche masseria. Le masserie, quelle che io ho avuto modo di visitare, sono tutte disabitate e in stato di abbandono: si tratta di vere e proprie cittadelle fortificate, con un enorme portale di ingresso, apribile a fatica a causa del suo peso e dentro la cittadella si vedono i resti di una civiltà finita con la famigerata riforma agraria: si capisce da ciò che si può ancora vedere: lì, dentro quelle cittadelle le comunità agricole avevano tutto il necessario per vivere. C’era a capo di quella comunità un padrone? Un despota? Un feudatario? Può darsi. Ma, per non giudicare con mentalità antistorica, gli schiavi, veri o presunti di quella comunità, avevano vita, sostentamento e sicurezza in qualche modo garantita in quel territorio ostile. Il latifondo era una necessità, dettata dal fatto che la terra era brulla e arida e si poteva raccogliere qualcosa solo lavorando su grandi distese (un po’ come mi è capitato di vedere nel sud della Patagonia Argentina ancora ai giorni nostri. Le aziende agricole di centomila, duecentomila ettari di terreno, almeno, (sarebbe meglio dire di deserto, a scanso di equivoci) sono la norma.
Sta di fatto che con la riforma agraria questo stato di schiavitù, di prevaricazione, di sfruttamento delle braccia umane andò a finire. E per sopperire a questa novità le istituzioni dell’Italia Repubblicana che cosa si inventarono? Per chi, come il sottoscritto, negli anni ’80 avesse percorso la strada che dal sito archeologico delle Tavole Palatine o di Metaponto, vicino a Taranto, conduce verso Matera, (può darsi che oggi sia ancora così) avrebbe visto una serie infinita di piccole case, palazzine tutte uguali tra di loro, tutte abbandonate e ridotte a ruderi con sopra un cartello di avviso (attenzione pericoloso avvicinarsi, caseggiato pericolante); tutt’attorno il deserto, terra riarsa e ogni forma di vita vegetale bruciata dal sole nella solitudine e nel silenzio più assoluto.
Più avanti la ferrovia abbandonata e le rotaie divelte a destra e a sinistra e i ruderi di un passaggio a livello in disuso. Ma che cosa era successo, chi era passato da qui? Forse i barbari? Si forse la barbarie istituzionale? Si può intuire che quelle case vennero assegnate agli schiavi delle masserie.
A ciascuno la sua casa, con un piccolo appezzamento di terreno: ma quel fazzoletto di terra arida ed improduttiva non poteva essere neppure trasformata in un piccolo orto per uso familiare. Così senza servizi, senza scuole, senza assistenza, lontano dai centri abitati quelle persone abbandonarono le terre e le case al loro destino in pochissimo tempo emigrando di preferenza in Germania (parlo proprio di coloro che abitavano questa zona della Basilicata) ad ingrossare le truppe di operai vessati e mal pagati delle fabbriche tedesche . Mi è capitato verso la metà degli anni ’90 di visitare, per motivi di lavoro, dei grandi complessi industriali in Germania: c’erano molti Italiani tra le maestranze, chiedo da dove venite? Veniamo tutti dalla Basilicata: siamo figli dei figli di quelli che sono emigrati negli anni ’50. Qui siamo trattati come schiavi, ditelo in Italia… (sembrano parole fuori del tempo e della realtà, negli anni ’90, ma le riporto qui testualmente, tanto che a riportarle mi emoziono ancora ).
Ma l’emigrazione all’estero da quelle regioni non è stata per tutti così.
Nei luoghi dove trascorrevo le mie vacanze, sulla costa ionica a sud di Gallipoli, fin dall’inizio (1980) ero rimasto impressionato dalle targhe delle autovetture che incontravo là: non una targa italiana, tutte immancabilmente CH, Svizzera. Mi sono detto il primo giorno guarda gli svizzeri hanno scoperto la bellezza incontaminata di questi posti (oggi, 2012, non é più così) e sono venuti fin qui dalla Svizzera. Ma no, tutti erano originari di quella zona del Sud Italia ed emigrati a suo tempo in Svizzera . A loro è toccata miglior sorte rispetto agli emigranti dalla Basilicata: la maggior parte di quelli che ho conosciuto, in Svizzera nel tempo di due generazioni hanno fatto fortuna, quelli che stavano adesso acquistando una casa a mare, laggiù, poco lontano dalle masserie dei loro antenati erano diventati in Svizzera degli imprenditori di tutto rispetto. Mi è capitato di andare a trovare in Svizzera qualcuno di quelli che al sud mi affittavano stagionalmente la casa: io sono curioso, non bisogna mai accontentarsi del sentito dire, di quello che si legge sui giornali, o magari si ascolta alla televisione, o quello che ci è stato raccontato nel film Novecento e dagli altri persuasori occulti a senso interpretativo unico e preconfezionato.
Per capire perché al Sud molte cose non vanno bisogna prendere le mosse da queste storie.
Sta di fatto che la riforma agraria, con l’affermarsi definitivo della civiltà industriale capitalistica, tanto al sud come al nord, nella pianura padana, il mondo contadino tradizionale è stato liquidato in breve tempo e questa circostanza ha pemesso di mettere a tacere tutte le voci di dissenso e stendere un velo di pietoso silenzio sull’abominio di quella riforma agraria.
Adesso, dopo circa ottant’anni, che possiamo dire di questo quadro raffigurato in Tèra paisan-a ?.
Finita l’epoca del latifondo (ecco una parola che riempie la bocca), finita anche l’epoca delle piccole proprietà agricole direttamente coltivate a livello familiare che erano in grado di garantire all’epoca condizioni di sussistenza e di relativo benessere a molte famiglie singole o allargate, almeno al nord, l’agricoltura si è sviluppata anch’essa in senso industriale: catturata nell’ingranaggio pigliatutto di investimento, produzione, creazione di valore aggiunto, reinvestimento del valore aggiunto appena acquisito e via di questo passo in una spirale sempre più veloce, senza senso e senza uscita. Chi vivrà vedrà.
Intanto il mondo vagheggiato dalla poesia di Olivero non esiste più: molti terreni sono stati rubati all’agricoltura per costruire case, ponti, vie di comunicazione, infrastrutture...
Ma non ci sarà qualcosa di veramente, profondamente insensato in tutto questo? Quando andavo a scuola ricordo un mio professore di storia e filosofia (era un Salesiano) che diceva: attenti ragazzi, al mondo esistono solo tre cose che producono ricchezza: la terra, il lavoro, il capitale. Ma se il lavoro ed il capitale falliscono, e possono fallire, la terra non può permettersi di fallire, se fallisce la terra (così come se si spegnesse il sole) sarebbe la fine della vita sul nostro pianeta. Per il nostro sostentamento, il nostro mantenimento in vita, la nostra sopravvivenza fisica, la terra è necessaria: solo la terra, eventualmente coltivata, è in grado di garantire la vita, perché la terra è la sola entità in grado di garantire la cattura dal sole, la gestione e la sintesi, attraverso il mondo vegetale, e solo quello, di tutta l’energia, di tutto ciò che serve alla vita delle piante degli animali e dell’uomo: non c’è altro.
Pertanto, a parte qualunque altra considerazione sull’inquinamento della terra, del mare e dell’atmosfera, tutto ciò che è rubato alla Terra coltivata o coltivabile è rubato alla Vita.
Di qui non si scappa: così come gli oceani garantiscono il ricambio dell’ossigeno sulla Terra (non come molti credono la foresta amazzonica e le aree verdi in generale, che al ricambio dell’ossigeno contribuiscono solo in minima parte) e per questo l’integrità degli oceani va tutelata, così va tutelata la terra coltivata che garantisce la vita in ogni sua forma: vegetale, animale ed umana.
Chissà se i responsabili delle istituzioni che ci ritroviamo, a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, da giovani sono andati a scuola e hanno imparato queste cose?
Ora possiamo dire che qui da noi la terra è stata sacrificata sull’altare del lavoro industriale e del capitale. La Costituzione Italiana recita dall’inizio L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Ma questa frase a me suona falsa o comunque incompleta: dovrebbe essere L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro al servizio del capitale. E questo vale sia per il lavoro industriale che per quello dei contadini. Agli Agrari di un tempo si sono sostituiti gli imprenditori agricoli. La forza lavoro, le braccia, eventualmente le importiamo dall’India, con contratti regolari o con il bracciantato della disperazione degli emigranti dall’Africa.Ma ci vantiamo di aver eliminato la mezzadria e gli altri tipi di contratti ritenuti vessatori. Per quanto concerne l'agricoltura, solo grandi aziende, con grandi investimenti e correndo rischi, possono pensare di sopravvivere e prosperare .
Per l’uomo non c’è più posto: ai tempi della poesia di Olivero, ancorchè molti contadini fossero analfabeti, fortunosamente allora non c’era la televisione, non c’era internet e al di fuori della radio (allora appena sdoganata), non c’erano molti mezzi di comunicazione, non c’erano insomma i persuasori occulti che costituiscono uno specchietto per le allodole per i veri analfabeti dei giorni nostri.
Allora ogni piccola comunità rurale era un centro di aggregazione e di cultura originale, unica ed irrepetibile. In questo senso il mondo raccontato da Olivero ed il racconto del suo rapporto speciale con la terra va interpretato, al di là di ogni equivoco e di ogni possibile strumentalizzazione e malversazione dettata dal pregiudizio.
Domenico Appendino
COMMENTO ALLA POESIA DI OLIVERO D’ZORA LA BARCA ‘D J’ILUSION PËRDÙE
D’ZORA LA BARCA ‘D J’ILUSION PËRDÙE
D'zora la barca ‘d j’ilusìon përdùe
a j’era trè fumele patanùe.
La prima, la Speransa, con j’euj vèrt
fissava ‘l cel, ij sò brassin duvèrt.
La seconda, la Gòi, coronà ‘d reuse,
sagnava an front cissà dë spin-e ancreuse.
La tèrsa, Gioventù, smòrta e passija
a së speciava ‘nt l’eva e a sangiutija.
E tute trè, con ij cavèj al vent,
ampinijo la neuit dij sò lament.
E ‘l mar a l’era an fùria antorn a lor,
j’onde a scumavo ‘d rabia e dë sgrisor.
E la barca, lontan-a da ògni pòrt,
corìa sensa timon vers a la Mòrt :
la gran sansùa angorda ’d vite bele
ch’a spetava ‘d ranché le trè fumele
e a sghijava sle sàbie, ant ël profond,
sbavand tuta la bava, ch’a j’è al mond.
* * *
… Tant che ‘nt la neuit ëd fùria trè fumele
saravo j’euj su tute còse bele.
Tant che – ‘nt un pòrt velà ‘d silènsi fros –
con tuti ij pì bej nòm ch’a sa un moros
mi ij ciamava, ij ciamava, ‘nt la neuit sombra,
con la vos sensa son.. Mi j’era un’ombra.
Sensa le trè compagne ‘d mè boneur
mi j’era un mòrt, le man rèide sul cheur:
un cheur ch’a niava ant un angorgh ëd pior
tant che, lontan, sul mar, sensa dolor
ëd mia vita a sparìo j’ùltime fior.
Da Ël Tòr N° 29/30 del 15 dicembre 1946.
Sopra la barca delle illusioni perdute
Sopra la barca delle illusioni perdute / c'erano tre fanciulle nude. / La prima, la Speranza, con occhi verdi / fissava il cielo, le sue braccia aperte. / La seconda, la Gioia, coronata di rose, / sanguinava in fronte punta da spine profonde. / La terza, Gioventù, smorta ed appassita / si specchiava nell'acqua e singhiozzava. / E tutte e tre, con capelli al vento, / riempivano la notte dei loro lamenti. / E il mare era in furia intorno a loro, / le onde spumeggiavano di rabbia e di ribrezzo. / E la barca, lontana da ogni porto, / senza timone correva verso la Morte: / la gran sanguisuga ingorda di belle vite / che attendeva di afferrare le tre fanciulle / e scivolava sulle sabbie, nel profondo, / sbavando tutta la bava che è al mondo.
... Tanto che nella notte di tempesta tre fanciulle / chiudevano gli occhi su tutte le belle cose. / Tanto che - in un porto velato di silenzi sinistri - / con tutti i più bei nomi che conosce un innamorato / io le chiamavo, le chiamavo, nella notte oscura, / con la voce senza suono... Ero un'ombra. / Senza le tre compagne della mia felicità / ero morto, le mani rigide sul cuore: / un cuore che annegava in un ingorgo di pianto / tanto che, lontano, sul mare, senza dolore / della mia vita sparivano gli ultimi fiori.
Traduzione di Giovanni Delfino (senza alcuna pretesa letteraria)
Commento
Mi piace immaginare il contenuto di questa poesia di Olivero sulla continuità del testo di una famosa poesia di Leopardi “ Il sabato del villaggio”. Che cosa racconta quella poesia di Leopardi: il poeta descrive nei suoi versi raffinati una esperienza che è di tutti e di ciascuno ad ogni fine settimana: “si fa più festa al sabato che alla domenica”: ma perchè ? E in fondo la risposta, il messaggio sta in questo: al sabato decollano i sogni di quella felicità che si spera di poter realizzare il giorno successivo la domenica: ma quella speranza rimane una bella speranza… Alla domenica più che con i “sogni” del giorno precedente si devono fare i conti con la realtà. E la realtà è sempre un po’ diversa rispetto ai sogni. Ma quand’anche tutto andasse liscio e alla domenica si potesse realizzare tutto quello che si era progettato al sabato, la domenica ha in sé qualche cosa di intrinsecamente corrosivo… e cioè il pensiero che domani è lunedì e si ritorna al lavoro usato, al lavoro di tutti i giorni, alla noia della routine. Ma Leopardi non si accontenta di tutto questo: alla fine della poesia mette a confronto il sabato e la domenica con le due importanti stagioni della vita: la fanciullezza, la giovinezza [cioè il sabato della vita] con l’età matura, [vale a dire la domenica della vita]: in gioventù si fanno i progetti su quello che “farò da grande”, nell’età matura si devono fare i conti con quello che effettivamente si è fatto, si è realizzato, se e quanto di quella “felicità futura” ha trovato la sua realizzazione… Allora Leopardi termina la poesia con quella esclamazione che non sai mai se è una minaccia o una promessa, una maledizione o un augurio intriso di pungente ironia: Godi, fanciullo mio; stato soave, / Stagion lieta è cotesta. (La fanciullezza, la giovinezza, il sabato della vita…) /Altro dirti non vo’; ma la tua festa (l’età matura… la domenica della vita) / Ch’anco tardi a venir non ti sia grave, [anche se tarderà ad arrivare , non ti sia di peso…]
E su queste “buone parole” decolla il testo della poesia di Olivero: per lui quell’augurio, al raggiungimento dell’età matura, si è davvero “volto” in maledizione e la poesia di Olivero narra il fallimento completo (vero o presunto), il naufragio dei sogni di gioventù, “le illusioni perdute” appunto.
Ma la poesia inizia con una frase ad effetto, quasi per sollecitare l’attenzione degli uditori: il poeta ci propina tre donne nude in copertina, come per i “rotocalchi” con l’ intento di incrementare il numero delle copie vendute.
Molto tempo fa mi era capitato di recitare questa poesia su un palco di un teatro di periferia. Al passaggio d’zora la barca ‘d j’ilusion përdùe a j’era trè fumele patanùe, dalla platea si era alzato un brusìo, un rumoreggiare, quasi a dire: ah ! beh! se su quella barca ci sono tre donne nude, la cosa promette bene. Dunque tre donne nude, tre “femmine” che di primo acchito potrebbero fare venire in mente le tre Grazie, nel pieno del loro splendore giovanile. Ma l’immagine di giovinezza, “primavera di bellezza”, non solo si stempera, ma crolla miseramente nei versi immediatamente successivi. Il brusio della gente cessa, le tre presunte Grazie nell’ età matura del poeta si sono trasformate in tre “Megere”, e la loro descrizione è caratterizzata da annotazioni un po’ grottesche, alla maniera delle descrizioni di personaggi femminili che troviamo nelle poesie di Padre Isler.
La Speranza con gli occhi verdi: il verde si addice alla Speranza [come il nero si addice alla morte, avrebbe detto Bergman nel suo famoso film Il settimo sigillo]. Ma questa Speranza con gli occhi verdi, con le braccia protese al cielo è solo più l’ombra di sé stessa e, se le braccia protese al cielo possono esprimere da una parte la speranza, l’augurio, la preghiera che le nubi minacciose che incombono sulla barca che sta per affondare si plachino e ritorni il sereno, dall’altra parte questa Speranza così descritta sembra voler dare anche un “colpetto” alla Speranza Cristiana (per i Cristiani, Fede, Speranza e Amore sono le tre virtù cosiddette “teologali” o “divine”). In questa descrizione della Speranza, esile e male in arnese, con le sue piccole braccia aperte verso il cielo si nasconde a mio avviso un po’ di quell’appellativo di “gagno malefic” riferito ad Olivero.
Qui la “quasi” caricatura della Speranza Cristiana ci dice come essa sia inesorabilmente schiacciata dall’incombere dell’ “esistenza” che non concede spazio né tregua all’Uomo e alla Speranza fino alla morte.
Ma sulla barca delle illusioni perdute, in balìa dalla tempesta, non c’è solo la Speranza, troviamo anche un’altra donna nuda: la Gòj , cioè il “desiderio”, il “piacere” (soprattutto sessuale), alla quale la corona di rose che le cinge la testa, diremmo, “ le va stretta “e le spine che l’accompagnano si conficcano nella carne procurando lesioni e sanguinamento alla fronte. Una Gòj ben diversa da quella richiamata da una poesia giovanile di Olivero (Paisagi sota la fiòca ambientata a Villastellone) nella quale il poeta, a 20 anni, scrive:
E l’amor veuj che a canta ! – [L’amore fisico voglio che “canti” cioè vada a “pieni giri” come il motore di una Ferrari (Ai tempi belli!)] e la Gòj veuj ca cria (cioè il piacere che si accompagna all’amore fisico voglio che ”gridi“ – [di piacere appunto]. Qui la Gòj sulla barca delle illusioni perdute non è più quella. E tutto questo, cioè come stiano davvero le cose, ce lo spiega la terza donna nuda “ La Gioventù smorta e passija [pallida ed appassita].
E tutte e tre con i capelli al vento, riempivano la notte dei loro lamenti, mentre la barca su cui stavano veniva trascinata senza scampo nel gorgo del mare profondo dalla tempesta incombente.
La descrizione della tempesta notturna possiede una sua magìa: qui non di una tempesta si tratta ma di uno “tsunami” che tutto travolge. Le parole, poche pennellate all’interno del testo, rendono la descrizione più efficace ed intensa di quella a cui forse il poeta si è ispirato o ha fatto riferimento: sempre Leopardi (frammento XXXIX) dove una ragazza, uscita di casa in una sera tranquilla di luna per un incontro amoroso, pur con le più belle premesse, trova la morte travolta dall’improvviso sollevarsi di una tempesta inattesa ed imprevedibile (qui si tratta di una tempesta notturna terrestre, Olivero parla di una tempesta notturna sul mare e l’efficacia della descrizione in lingua piemontese è mio avviso di gran lunga maggiore rispetto a quella, pur descritta nei particolari, del giovane Leopardi).
Sta di fatto che la barca nella tempesta, ormai senza governo né timone, viene travolta dai marosi e le “tre donne nude” trovano la morte. Segue una digressione sulla morte, [altro argomento ricorrente e caro ad Olivero] che qui viene paragonata ad una “grande sanguisuga” ingorda di vite belle, che in attesa di “artigliare” le tre ”femmine nude” scivola continuamente tra la sabbia della spiaggia e le profondità del mare – dice il poeta – sbavando tutta la bava che esiste al mondo. La descrizione della tempesta e della morte che l’accompagna qui raggiunge il culmine della sua efficacia. Mi piace notare come in Olivero la parola “sanguisuga” affibbiata alla morte abbia qui un significato al tempo stesso dispregiativo e rivoltante, quasi di un vampiro avido di sangue umano.
Ma non è sempre così: in un'altra poesia giovanile Ël sanssué dël Pasch ambientata nelle campagne di Villastellone, Olivero descrive l’attività inconsueta di questo uomo che camminando a fatica nella melma di una palude a Villastellone, va raccogliendo le sanguisughe da fornire alle locali farmacie che le utilizzeranno per “salassi” terapeutici [sanguisuga officinale – Hirudo medicinalis]: comunque si voglia interpretare qui, la sottile ironia che si riscontra nel testo [soprattutto l’ambiguità e l’ironia dell’ultimo verso] è cosa diversa rispetto all’equivalenza sanguisuga = morte, della poesia che stiamo commentando. Questo passaggio ci fa capire come non solo gli aggettivi, ma anche i sostantivi, gestiti con genialità all’interno di un testo, possono assumere significati diversi quando siano diversamente ambientati.
Dunque le tre Grazie, anzi le tre Megere vengono a morte, inghiottite dal mare in tempesta in una notte di tregenda.
Ma il poeta non si da per vinto: crede di poter ancora “recuperare” le tre “donne” che hanno alimentato i sogni di sua gioventù.
E proteso in avanti sul molo di un porto, le chiama, le chiama, nella notte minacciosa ed oscura.
Ma c’è un particolare su cui si sofferma l’attenzione del lettore: le chiama sì, ma con la voce “senza suono”. Il poeta, egli stesso – dice - è ormai un ombra.
Ed è quella voce “senza suono” che richiama alla mente un altro riferimento letterario. Non più Leopardi ma Pascoli [ Mi piace ricordare questo poeta, proprio ora, proprio qui, a cento anni dalla sua morte, [1912-2012] grandissimo e sconosciuto, lui che per tutta la vita nelle sue poesie “ha sfogliato avanti-indietro, indietro-avanti, il libro del mistero”].
Tra le poesie di Pascoli cosiddette “del ritorno” se ne trova una (nella raccolta I Canti di Castelvecchio) avente per titolo La Tessitrice. Le poesie “del ritorno”, sono quelle in cui Pascoli immagina di “ritornare” al suo paese, San Mauro di Romagna, dopo che da giovane era stato costretto ad abbandonare quei luoghi in seguito alla morte del padre, assassinato in un agguato nel 1867.
Allievo del Carducci, dopo aver girovagato a lungo per l’Italia come professore in vari licei al nord a al sud si stabilirà poi definitivamente in Toscana [Castelvecchio di Barga] in compagnia della sorella Maria, e non ritornerà mai più a vivere stabilmente in Romagna.
Ma quei “ritorni” alla terra delle sue origini, sono tutti un po’ “allucinati” perché troppo grande e travolgente é il ribollire dei ricordi e dei sentimenti nel rivedere in sogno [o nella realtà] i luoghi della fanciullezza e dei suoi primi affetti. Da questa logica non si allontana neppure La Tessitrice a cui mi sembra possa fare riferimento la poesia di Olivero.
Che cosa racconta la poesia La tessitrice?
Pascoli è dunque ritornato al suo paese e nel luogo solito, su una stradina di San Mauro, trova una panchetta, quasi fosse lì dai tempi della sua giovinezza. Su quella panchetta c’è una ragazza: una ragazza che il poeta conosceva bene. Pascoli si siede vicino a lei, come tanti anni fa. Lei, inspiegabilmente sembra proprio quella di allora, come allora. Sta fabbricando una tela con un telaio artigianale proprio come tanti anni fa. Ma, nota il poeta, la ragazza non parla, il telaio non fa più rumore come una volta. Allora Pascoli, incuriosito, prova a rivolgerle la parola: Perché non suona / dunque l’arguto pettine più? Risponde lei perché non suona ?/ Non t’hanno detto? Non lo sai tu? / Io non sono viva che nel tuo cuore./ Morta! Sì morta! Se tesso, tesso/ per te soltanto; come, non so;/ in questa tela, sotto il cipresso,/ accanto alfine ti dormirò. La ragazza che incontrava in gioventù su quella panchina si era trasformata nella Parca che alla fine taglierà il filo della vita. Nella Parca che lo porterà con sé, nel luogo di morte, al cimitero.
Ed è appunto quella vos sensa son che troviamo nella poesia di Olivero, che risveglia nella mente il silenzio della tessitrice di Pascoli, ormai morta.
Qui il morto è Olivero, che articola parole “senza suono” nel tentativo, senza speranza, di far rivivere i sogni di sua gioventù e recuperare la bellezza di quelle tre donne nude “ speciali” , ma inutilmente
Le tre Grazie che si erano trasformate dapprima in tre Megere, con la loro morte diventano per lui le tre Parche che lo condurranno e lo accompagneranno a morte.
Nel finale della poesia il poeta raffigura sé stesso come morto, con la mani fredde ed immobili in croce sul letto di morte, mentre il “simulacro” di quei fiori di speranza di sua gioventù spariscono definitivamente in fondo al mare. E con la morte ha termine anche il dolore fisico e spirituale che col passare del tempo sempre più si era accompagnato alla vita, alla Speranza, alla Gòj, alla Giovinezza.
Domenico Appendino