Rondò dle masche L'Alcyone, Roma, 1971
Ij faunèt Il Delfino, Roma, 1955
Articoli di Giovanni Delfino riguardanti Luigi Olivero pubblicati su giornali e riviste
Le poesie di Luigi Armando Olivero (Seconda parte)
Le poesie di Luigi Armando Olivero (Terza parte)
Poesie di Luigi Olivero dedicate allo sport
Articoli su Olivero pubblicati da Giovanni Delfino su giornali e riviste
INDICE DEGLI ARTICOLI
I) Luigi Armando Olivero poeta al Montserrat di Borgo San Dalmazzo
2) Il centenario della nascita di un grande poeta dialettale, Luigi Armando Olivero
3 ) Luigi Armando Olivero
4) Una poesia inedita (?) di Nino Costa
5) Luigi Armando Olivero – Gli inizi
6) Luigi Armando Olivero – Gli inizi – Seconda parte
7) Luigi Armando Olivero e il “Futurismo” Su Piemontèis ancheuj
8) Un poeta borgarino Callisto Ghibaudo
9) Luigi Armando Olivero e il “Futurismo” Su Gioventura piemontèisa
10) Luigi Armando Olivero scritor ëd sagg e ‘d romanz
11) Luigi Armando Olivero e ‘l fassism
12) Luigi Armando Olivero dal 1940 al 1945: Pound, von Leers, Harrer…
13) Il tema religioso in Luigi Armando Olivero
14) N’amicissia dificila, ma sincera; fràgila ma pressiosa.Pinin Pacòt e Luigi Olivero
15) Pinin Pacòt tra rondel ed inni
16) Alda Merini
17) Alex Alexis alias Luigi Alessio
18) Pinin Pacòt tra poesia, prosa ed editoria
19) Nino Autelli nel 70° anniversario del suo assassinio
20) Nino Autelli per il 70° anno del suo assassinio
21) Filippo Tartùfari
22) Nino Costa
23) Pinin Pacòt e la Famëja Anaunèisa
24) Teresio Rovere
25) La bela companìa dij Brandé
26) Luigi Armando Olivero (L’Araldo)
27) Nino Autelli nel 70° anniversario del suo assassinio (L’Araldo)
28) La bela companìa dij Brandé – Nuovi arrivi
Rivista Marittimepubblicata a Borgo San Dalmazzo CN
N° 34 aprile 2009 pagg. 36 ~ 42
Luigi Armando Olivero poeta
al Montserrat di Borgo San Dalmazzo
Luigi Armando Olivero
Luigi Armando Olivero nasce a Villastellone, grosso borgo agricolo nei pressi di Torino, il 9 novembre del 1909. Inizia giovanissimo a scrivere poesie in piemontese, le sue prime risalgono alla metà degli anni ’20. Agli inizi degli anni ’30 intraprende la carriera giornalistica che lo porterà a viaggiare per gran parte del mondo e che proseguirà per tutta la sua lunga vita. È dapprima in Africa: Algeria, Tunisia, Marocco, Sahara da dove invia reportage e pezzi di colore che appaiono su Stampa e Stampa Sera. A metà degli anni ’30 è in Turchia dove intervista Ataturk che sta portando la sua nazione alla modernità Il viaggio permetterà a Olivero di scrivere il saggio Turchia senza Harem del 1945, ancora oggi di grande interesse per la storia, gli usi e costumi di quella nazione. È a lungo negli Stati Uniti dal cui soggiorno deriveranno il saggio Babilonia stellata – La gioventù americana d’oggi del 1941, non sempre amichevole reportage sull’America del tempo e Adamo ed Eva in America alla vigilia del diluvio universale, saggio romanzato di vita femminile americana del 1946.
Già all’inizio degli anni ’30 aderisce e diventa uno dei principali componenti della Compania de ij Brandè fondata da Pinin Pacòt con Mottura, Nicola, Albano, e tanti altri.
Compone più di 1000 poesie, parte delle quali troviamo nei volumi Roma Andalusa 1947, Ij faunèt 1955, Rondò dle masche 1971 e Romanzìe 1983.
Da molti è considerato il più grande tra i poeti contemporanei in piemontese.
Luigi Armando Olivero al Montserrat
Nel 1947 Olivero acquista casa sulla collina del Montserrat, proprio sotto il Santuario di Borgo San Dalmazzo. Vi trascorrerà il tempo libero che gli lascia il suo lavoro di cronista parlamentare, da solo o in compagnia della moglie, Felicina Viscardi, figlia di un celebre pellicciaio torinese. Vi comporrà moltissime delle sue poesie più belle.
Olivero oltre che poeta è anche giornalista, critico letterario, cinematografico, teatrale, autore di testi per la radio ed il cinema, traduttore dall’inglese e dal tedesco nonché vivacissimo polemista. Proprio quest’ultima sua attività ha modo di esercitare al suo arrivo a Borgo.
La guida, giornale cattolico di Cuneo, in occasione della messa in funzione del primo forno dello stabilimento Italcementi di Borgo San Dalmazzo, sul N° 31 del 2 agosto del 1947 accenna al pulviscolo che comincia a depositarsi dappertutto: l’aria, prima limpida e pura è oggi alterata e viziata; l’anonimo cronista de La guida aggiunge non crediamo sia un danno alla salute, ma si potrà ovviare in qualche modo? Qualche settimana dopo lo stesso anonimo redattore de La guida riprende il tema, elogiando però lo stabilimento, uno dei più moderni d’Europa, e magnificando l’opera dell’Italcementi che produce il cemento per la necessaria ricostruzione dell’Italia.
Olivero, che proprio sotto la sua casa, a un tiro di schioppo, ha le ciminiere dello stabilimento, inizia a scrivere lettere di protesta in Comune e a vari giornali locali. Se ne dovrebbe poter trovare traccia in almeno una lettera diretta da Olivero, probabilmente nel 1951, al Comune con accompagnamento di numerosissime firme (si vocifera addirittura di un migliaio, un quarto degli allora abitanti del paese!). In una lunga mattinata trascorsa nell’archivio del Comune di Borgo San Dalmazzo non ne ho purtroppo trovato traccia nonostante lì fosse presente un cospicuo faldone riguardante proprio l’inquinamento atmosferico prodotto dal cementificio; stranamente in detto faldone non sono presenti lettere od altri documenti per quasi tutto il 1951 (Nonostante siano ben presenti numerose lettere e documenti sia del 1950 che del 1952). Anche il registro del Comune della posta in arrivo ed in partenza si ferma al 1950 e non esistono poi gli anni immediatamente successivi. Qualche cosa però la lettera di Olivero pare aver prodotto. L’Italcementi invierà in loco, nello stesso 1951, due incaricati: il danese Larsen con il compito di occuparsi dei mulini e dei macchinari industriali e il finlandese Ericson per cercare rimedio ai fumi prodotti. Annedottica sui due inviati a Borgo per oltre due anni a spese dell’Italcementi: il Larsen ghiottissimo di dolci, l’Ericson in compagnia della moglie notevole consumatore di wisky, pare circa due bottiglie al giorno! (1)
Calisto Ghibaudo
Estate del 1954. Trascorre le vacanze nella “bicocca” del Montserrat di Borgo San Dalmazzo. Qui, il 2 di agosto, scrive la lunga prefazione al libro di poesia Noi soma Alpin del borgarino Calisto Ghibaudo. Questi dedicherà ad Olivero la sezione del libro dal titolo Dòp-guèra con queste parole:
A LUIGI OLIVERO
Maestro ‘d mas-cia poesìa piemontèisa
ch’a l’ha piantame an man
la Piuma Nèira ‘d mè Capel d’Alpin
e che l’ha dime:
«Nompà ‘d ciaramlé tant
për conteme ij tò ricord ëd naja
scrivije».
E mi, bin ò mal, l’hai scrivuje.
Nella prefazione, una lettera aperta, Olivero si scusa dell’invio della poesia L’Alpin che ritiene poca cosa. Afferma …e io ti ricambio inadeguatamente offrendoti il sonetto che precede questa letterina e che non è nemmeno tra le mie cose più efficaci. Abbi pazienza. Ognuno dà ciò che ha. Il nostro gesto equivale alla stretta di mano tra poeti: la tua più calorosa, la mia forse meno intensa ma ugualmente cordiale… Olivero preconizza poi l’intervento di qualche super-psicòlogo che definirà lo scambio una concertata puerilità reclamistica richiamando la definizione data dei poeti da Ernesto Renan con l’arguto verso:
«Ce sont des enfants qui se sucent le pouce».
Pollice, indice, medio – chiosa Olivero – anulare o mignolo, in ogni caso le dita sono nostre e ce le succhiamo individualmente o intrecciamo reciprocamente come ci pare.
Olivero prosegue poi ricordando gli inizi in patois della poesia di Ghibaudo e del suo consiglio di addivenire al dialetto …è proprio qui, sul terrazzino di questo mio èremo solitario, dirimpetto alla schiena loricata d’oro della Bisalta, che abbiamo discusso insieme di questi effimeri ma per noi interessanti problemi di strategia letteraria: e che tu hai accolto il mio modesto suggerimento di lasciare il patois per dedicarti al dialetto il quale, a suo modo, è già un idioma: in quanto è codificato da secoli nella sua struttura filologica ed è comprensibile ad un maggior numero di creature che, se non sempre lo scrivono o leggono, lo parlano sin dall’infanzia…
Quindi il ricordo della genesi dell’opera di Ghibaudo …lo avvertii e te lo dissi improvvisamente durante una delle nostre quasi quotidiane «scarpinate» su per i verdi castagneti che popolano, in duplice declivio, le balze a groppa di caimàno sovrastanti il Santuario della Madonna del Montserrat, un giorno in cui mi narravi, liricamente infervorato, le vicende di pace e di guerra che hanno costellato la tua santa naja di Tenente dei 5°, 2°, 4° Reggimenti degli Alpini…Chi ci vide su quella cresta rocciosa, contro lo sfondo del cielo azzurrino - io in tuta olimpionica blu e tu scamiciato, entrambi arruffati e gesticolanti -, potè credere a due pazzi colpiti da insolazione che impegnassero una pericolosa partita di pugilato sull’orlo dell’abisso. Invece, no. Disegnavamo semplicemente nell’aria l’architettura del piccolo breviario in rima degli Alpini che tu poi hai felicemente costruito: ma facendo di meglio, conferendogli quasi i lineamenti di un’agiografia profana del Santo Alpino: l’Alpino che, infatti, tu scrivi sempre con l’iniziale maiuscola.
Del libro di Ghibaudo, appena pubblicato, Olivero, nella terza uscita per ‘l caval ‘d brôns delle sue Lettere romane, nel numero del 6 giugno 1955, per il pubblico piemontese traccia queste note:
Il libro è una rivelazione portata qui dai partecipanti, subalpini romanizzati, al recente Convegno degli Alpini a Trieste. È tutto scritto in assai comunicativi versi piemontesi e illustrato, meglio che da Salvator Dalì, da quel Beato Angelico del pennello fatto con i fili di paglia d’un fiasco di barbera che è il pittore di Chiasso, ma da vent’anni residente a Roma, Gabriele Cena. Questa ingenua eppure calda rapsodia del canto Alpino, che mancava alla nostra poesia dialettale, ha trovato a Roma un’accoglienza entusiastica. Poi - curiosa, eh! – se n’è arrivata alla Capitale da Cuneo passando per Trieste. Dove pare che l’autore minacciasse di dar fuoco con l’accendisigari alle penne nere degli ex commilitoni se non gliela compravano. Ad ogni modo Nôi sôma Alpin! sprizza faville dalle vetrine romane. Lo acquistano anche i quiriti, sicuri che si tratti di un vademecum del perfetto alpinista dilettante, per consultarlo nelle loro ardite escursioni estive al Terminillo, a Monte Cavo e a Montecòmpatri. E il giovane ex tenente delle Penne Nere Calisto Ghibaudo da Borgo San Dalmazzo deliba il suo dolce quarto d’ora incartato di celebrità romana: scommetto a cavalcioni - qui dicono a cavacecio - di una montagna di diritti d’autore spuntatagli inaspettatamente sotto le scarpe chiodate, fra la sua Besimauda e il suo Monserrato.
Il figlio del poeta borgarino, Marco, da pochissimo deceduto a soli 56 anni, ricorda che il padre, quando lui era piccolo, lo portava a trovare Olivero nella sua casa del Montserrat e qui assisteva a lunghe chiacchierate, davanti ad una buona bottiglia di vino, che spesso sfociavano in accese discussioni. Quando Olivero si infervorava, Marco ricorda che, con la canna (il bastone) che aveva sempre con se, picchiava ripetuti colpi sul tavolo a dare maggiore enfasi alle sue asserzioni. Furono sempre amici, Calisto e Luigi. Una delle poche persone con cui, nonostante le discussioni, non ci furono mai momenti di separazione netta. (2)

Olivero non ha mai imparato a guidare l’automobile né ha mai preso la patente di guida, nessuno me ne ha saputo indicare il motivo che potrebbe, però, essere un suo problema alla gamba che si trascina dall’infanzia. Forse, anche per questo, ha stretto amicizia con un borgarino, di una quindicina d’anni più giovane, rampollo di una nota famiglia locale. Questi, per ragioni di lavoro, viaggia spesso per il Piemonte e non per il solo Piemonte. Sovente porta con se l’Olivero che coltiva così le numerose conoscenze che ha sparse per la regione. Lo troviamo a Cherasco per incontrare l’amico scrittore Clemente Fusero che Olivero definisce principe della biografia contemporanea (il figlio Sergio dirà che Olivero passava da loro tutte le volte che arrivava a Borgo San Dalmazzo); poi ad Asti, Alessandria (Rina Faccio alias Sibilla Aleramo?) ed anche a Cannes in Costa Azzurra. Olivero contraccambia spesso con le “Nazionali” che acquista a basso prezzo in Parlamento. Regalerà anche al giovane amico una copia con dedica de Ij faunet e un’edizione BUR in due volumi di un Dizionario di Spagnolo con dedica nella stessa lingua. In occasione dell’annunciato matrimonio, il borgarino ebbe pure una lettera dall’Olivero in cui, con varie argomentazioni, gliene veniva sconsigliato il passo. L’amicizia finirà, come tante altre, nel 1955 per un episodio che vale la pena di raccontare.
Nel suo lavoro di critico d’arte Olivero spesso si trova a recensire personali di Emanuele Martinengo, noto pittore savonese (1888 – 1962) con cui intrattiene rapporti più che professionali, non disdegnando di allacciarne anche con la di lui figlia, anch’essa pittrice in fieri. In cambio delle recensioni favorevoli, a volte il Martinengo omaggia l’Olivero di sue opere che il Nostro, oltre che trattenere per se, utilizza per regali di una certa importanza. Per questo, ogni tanto, fa incorniciare le opere del Martinengo presso una notissima corniceria di Cuneo e a volte, incaricato del ritiro, se non anche della consegna, è il nostro borgarino viaggiatore ed autista.
Siamo proprio in uno di questi casi. Olivero ha fatto recapitare un paio di quadri, ha pattuito tipo di cornice, prezzo e data della consegna. Dopo venti giorni (Olivero è in partenza per Roma e deve portare con se i quadri per un omaggio) l’amico di Borgo si reca alla ditta di Cuneo per il ritiro. Non conosco di chi sia la colpa ma, in ogni caso, trova chiuso il negozio (una porta di legno, modo di dire locale per “fuori orario”) e non può ottemperare all’incarico che si è assunto. Tuoni e fulmini, Olivero si arrabbia moltissimo. È veramente furibondo tanto da trascinare in seguito i rappresentanti della ditta in tribunale (non volendo più pagare il pattuito) con l’amico citato quale testimone. Questi dirà “mai avevo portato la mia faccia in Tribunale, men che mai dopo”. Rottura di un’amicizia ma anche, e forse più importante per Olivero, perdita del suo autista. (3)
Nella sua casetta di Borgo San Dalmazzo il 3 luglio del 1955 compone Amor-masnà, il 10 Le masche e il 13 El bal dle lusentele. Nel successivo 1956, il 15 di maggio vi comporrà Seugn d’istà. Dai lunghi soggiorni nella Provincia granda nascono molte poesie, parecchie al Piemonte dedicate, e tanti articoli, alcuni pubblicati dai giornali locali. Le poesie indicano sia l’anno che la località che di volta in volta è Monserrato, Monserrato di Borgo San Dalmazzo, Monserà, Monserà dël Borgh San Dalmass.
Borgo San Dalmazzo, Collina del Monserrato (Lato fiume Gesso), la casa di Luigi Olivero
La poetessa e scrittrice Albina Malerba, nel 1983 incontra nella sua casa romana Olivero nel corso di una lunga intervista (Pubblicata su due numeri de ‘l caval ‘d brôns del 1983). Albina Malerba se ne viene via dalla villetta di Olivero, ai piedi del Pincio, quando il sole è già calato dietro il cupolone; scendendo per via del Babbuino con negli occhi e nel cuore le parole di Olivero e le immagini della sua casa, traboccante di preziose opere d’arte degli artisti che gli furono amici e collaboratori, la poetessa porta con se una certezza:
Gli angeli saranno generosi con un poeta della tempra e della forza di questo piemontese di Roma.
Le sensazioni ed i sentimenti di Albina Malerba sono gli stessi che ho provato, e che mi permetto di condividere pienamente, il 25 di maggio del 1996 dopo aver trascorso l’intera giornata nella casa di Vicolo del Borghetto mentre, attraversando Via Margutta e Piazza di Spagna, me ne tornavo verso Termini e la metropolitana che mi avrebbe condotto a Fiumicino e da lì a Torino. Mi permetto una parafrasi, con piccole modifiche, alla frase sugli angeli di Albina Malerba:
Gli angeli sono stati generosi a farci dono di un poeta della tempra e della forza di questo piemontese.
Luigi Armando Olivero muore a Roma, quasi da tutti dimenticato, il 28 (o 31) luglio 1996. Ecco l’accorato ricordo che gli dedica l’amico poeta Giovanni Magnani.
It j’ere nen sol…
It j’ere nen sol quand’an sël frèid dla pera
Tò cheur a gëmmia pian l’ultim frisson:
dobià e an pior ant l’ultima preghiera,
j’amis pì s-cet a ciosioné ‘n perdon.
Përdon për coj omnèt che ‘nt la mnisera
dle fausserìe, dl’angann ë dël ghignon,
a l’han sercà ‘d sotré Toa vos sincera
che an tut ël mond a l’ha otnù ‘l blason.
Nò. It l’has mai avù n’ombra ‘d boneur,
nen n’agiut o ‘l consens për Tò travaj
dai borenfi savant ëd nòstr Piemont
e se cheivira a l’è vnù dur Tò cheur
ant le bataje ‘n sij libèr e ij giornaj,
adess la Glòria at baserà la front.
Gioanin Magnani
Da Assion piemontèisa 10, 1996
Nota 1
Notizie fornite da un vicino di casa di Olivero sulla collina del Montserrat di Borgo San Dalmazzo che non desidera però essere citato con nome e cognome e di cui, pertanto, rispetto il desiderio.
Nota 2
Calisto Ghibaudo Noi soma Alpin Istituto Grafico Bertello Borgo San Dalmazzo (CN) 30 marzo 1955
A LUIGI OLIVERO
Maestro di maschia poesia piemontese
che mi ha piantato in mano
la Penna Nera del mio Cappello d’Alpino
e che mi ha detto:
«Invece di parlare tanto a vanvera
per raccontarmi i tuoi ricordi della naja
scrivili.»
E io, bene o male, li ho scritti.
«Sono dei fanciulli che si succhiano il pollice».
Ernest Renan. (Tréguier Bretagna 28 febbraio 1823 – Parigi 2 ottobre 1892.) Filosofo, filologo, storico delle religioni francese. Dopo lunghi studi religiosi, si avvicinò alle scienze sotto la guida del chimico Marcellin Berthelot, con cui strinse un’amicizia che durò fino alla morte. A sessant’anni inizia la sua Storia d’Israele in cinque volumi, di cui gli ultimi due appariranno postumi.
Bibliografia
Histoire générale et système comparès des langues sèmitiques Paris 1845; Vie de Jesus Levy Frères Paris 1863 ; Les Evangiles et la seconde generation chretienne Levy Frères Paris 1871 ; Les apôtres Levy Frères 1866 ; L’Antechrist Levy Frères SD ; Ricordi d’infanzia e di gioventù Astrea Roma 1945 ; San Paolo Dall’Oglio Milano 1960; Prière sur l’Acropole Alberto Tallone Editore Alpignano Torino 1976 Levy Frères Paris 1865; Histoire du peuple d’Israel 5 vlLevy FrèresParis 1887-1893; L’avenir de la science Levy Frères 1890.
Calisto Ghibaudo Antibes (Costa Azzurra, Francia) 1920 - Boves 1992. Giovanissimo si trasferisce a Borgo San Dalmazzo. Lungo periodo di naja come tenente del 5°, poi del 2° ed infine del 4° Reggimento degli Alpini. Ricordi di guerra che sfoceranno poi nel suo secondo libro di poesia Noi soma Alpin del 1955. Laureato in lettere, nel 1954 viene trasferito a dirigere l’Ufficio di Collocamento di Fossano. Qui conoscerà, in seguito ad una manifestazione teatrale organizzata nella casa di pena, un carcerato, Leandro Balestra, organizzatore dello spettacolo, condannato a 24 anni per omicidio, che si professa però innocente. Il Leandro si manifesta poeta. Tra i due ci sarà un lungo scambio di poesie che durerà fino al ritorno a Cuneo del Ghibaudo l’anno seguente. Il tutto porterà Calisto, famigliarmente chiamato Kaly, 35 anni dopo, a pubblicare, derivandone il titolo dal nome del carcere, il suo Santa Catlin-a, opera di non molte pagine, una trentina, parte in prosa, parte in poesia, ricca di sentimento e di un sogno: fare del carcere un luogo di speranza.
Bibliografia:
Dal Monserà ai Camorei (Scelta di poesie piemontesi riguardanti Borgo San Dalmazzo) Istituto Grafico Bertello Borgo San Dalmazzo 1952; Noi soma Alpin (Scelta di poesie piemontesi riguardanti gli Alpini in guerra) Istituto Grafico Bertello Borgo San Dalmazzo 30 marzo 1955; Gent dël Borgh (Poesie piemontesi su Borgo San Dalmazzo) Amministrazione Comunale Borgo San Dalmazzo1988; Santa Catlin-a (Dialogo rimato tra due poeti: uno libero l’altro carcerato) Edizioni Gianfranco Martini Borgo San Dalmazzo 5 dicembre 1989.
Nota 3
Notizie raccolte nell’agosto del 2007 tra i ricordi personali di un abitante di Borgo San Dalmazzo (ovviamente l’amico autista di Olivero), oggi ottantenne ben prestante sia fisicamente che intellettualmente, che però non desidera essere citato direttamente.
Clemente Fusero scrittore e biografo (principe della biografia contemporanea, lo definisce Olivero) nasce a Caramagna Piemonte il 21 febbraio 1913, muore a Cherasco il 10 maggio 1975. Nel 1970 riceve il Premio della Cultura dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Di Luigi Olivero si veda Clemente Fusero principe della biografia contemporanea La Carovana Roma 1954).
Bibliografia:
Leonardo Corbaccio Varese 1939, Raffaello Corbaccio Varese 1939 - Dall’Oglio Milano 1963, Mozart SEI Torino 1941, Bargellini Vallecchi Firenze 1948, Daniele Comboni Nigrizia Verona 1953, Il romanzo di Modigliani Dall’Oglio Milano 1958, Lorca Dall’Oglio Milano 1969, Cesare Borgia Dall’Oglio Milano 1974, Giulio II Dall’Oglio Milano 1974, Gandhi Dall’Oglio Milano 1977.
1941 Babilonia stellata. Gioventù americana d’oggi Ceschina Milano (Tradotto in tedesco da Johann von Leers, Berlino 1944; Otto Muller, Düsseldorf 1952. Traduzioni in spagnolo, portoghese, bulgaro).
1945 Turchia senza harem Donatello De Luigi Editore Roma (Traduzione inglese di Ivy Warren MacDonald & Co Londra 1952).
1946 Adamo ed Eva in America. Alla vigilia del secondo diluvio universale L’Atlantica editrice Roma. (Traduzione inglese di Ivy Warren MacDonald & Co Londra 1951 Traduzione tedesca Hertz Dame Düsseldorf 1952).
1946 Emili Ludwig Barbari e musicisti. Chi sono questi tedeschi? Andrea Viglongo Torino. Traduzione di Luigi Olivero.
1947 Roma andalusa Stefano Calandri Moretta (CN) Piemonte.
1954 Giovanni Papini non è l’avvocato del diavolo La Carovana Roma.
1954 Clemente Fusero principe della biografia contemporanea La Carovana Roma.
1955 Ij faunèt Il Delfino Roma.
1955 Carlo Maria Franzero ambasciatore del romanzo italiano in Inghilterra La Carovana Roma.
1958 Carlo Maria Franzero La vita ed i tempi di Cleopatra Mursia Milano Traduzione dall’inglese di Luigi Olivero.
1959 Epicedion dij mè dòdes gat mòrt Casa Editrice Liguria Genova.
1963 Saggi sul D’Annunzio. Questioni biografiche. Torino e il Piemonte nella cronologia dannunziana Casa Editrice Liguria Genova.
1967 Tutte le canzoni e poesie satiriche piemontesi del Padre Ignazio Isler Edilibri Torino (Andrea Viglongo).
1971 Rondò dle masche L’Alcyone Editore Roma.
1983 Romanzie Centro Studi Piemontesi, Ca dë studi piemontèis Torino
1993-1995 Aereopoema dl’élica piemontèisa Piemontèis Ancheuj Torino (dal N° 132 del dicembre 1993 al N° 144 del gennaio 1995)

Litografia di Orfeo Tamburi, rappresentante Giandoja, da Ël Tòr N° 1 del 14 luglio 1945
Voci dialettali, organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali pubblicato a Roma N° 146/11 agosto 2009 pagg. 24 ~ 27
Il centenario della nascita di un grande poeta dialettale, Luigi Armando Olivero,
socio fondatore dell'A.N.P.O.S.DI
2 11 1909 - 2 11 2009
Cento anni or sono, il 2 novembre 1909, nasce in Villastellone (TO) Luigi Armando Olivero, uno dei 6 soci fondatori, nel lontano 1952, dell’Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali.
Terminata la frequenza delle Scuole Tecniche a Torino, Olivero inizia giovanissimo a scrivere poesie. Le prime in lingua, come dirà lui stesso carduccianeggiando, rapisardeggiando, dannunzianeggiando. Queste appaiono a stampa già dal 1926 sulla rivista letteraria orobica Il pensiero. Quindi sulla torinese rivista teatrale dell’Opera Nazionale Dopolavoro Rassegna filodrammatica. Sempre del 1926 è il suo primo articolo letterario sulla già citata rivista bergamasca Mario Rapisardi, un poeta dimenticato.
Diciottenne inizia a viaggiare per il mondo e ad intessere conoscenze le più svariate. Quattro continenti. Diciotto nazioni. I suoi primi scritti sono pezzi di colore dalla Tunisia, dall’Algeria, dal Sahara per La Stampa, Stampa sera, La gazzetta del popolo. Nella sua lunga vita arriverà a collaborare a più di 200 testate italiane e straniere.
Giunge alla poesia dialettale verso la fine degli anni venti grazie all’amicizia con il poeta Alfredo Nicola (Alfredino) che lo presenterà poi a Giuseppe Pacotto (Pinin Pacòt) che con altri amici poeti stava dando vita alla Compania dij Brandé (Brandé: alari) con lo scopo di ravvivare, riaccendere, rivitalizzare la poesia piemontese che si riteneva allora sul punto di spegnersi se non già del tutto spenta.
Comporrà nel dialetto piemontese oltre 1000 poesie e non solamente sonetti di 14 versi, ma componimenti che spesso superano, e ampiamente, i 100 versi. Sperimenterà ogni possibile forma metrica anche con lunghi componimenti in monostici, splendide poesie queste ultime con ogni singolo verso compiuto e i cui versi possono tranquillamente essere interscambiati. Il suo canto abbraccerà quasi ogni campo dello scibile umano e la sua poesia sarà universale: dall’aereopoesia futurista de L’aeropoema dell’elica piemontèisa, alla poesia dell’eros, a quella religiosa per giungere persino a poetare su discipline dello sport.

Infiniti sono i temi che ha poi trattato nei suoi scritti, sia in piemontese che in lingua: letteratura, pittura, scultura, musica nelle sue più variegate accezioni. Ho rintracciato suoi articoli sullo sport, sull’arte dei pupi siciliani, sugli UFO, sui capelloni…
Nel 1941 esce per i tipi dell’editore Ceschina di Milano Babilonia stellata, un saggio sulla gioventù americana d’anteguerra. In particolare sui suoi vizi e difetti. Ebbe in breve tempo tre edizioni. In una quarta del giugno 1943 aggiunge numerosi capitoli di feroce denuncia in particolare della politica economica americana. A questi capitoli collaborò attivamente con suggerimenti e lettere il più grande dei poeti americani e caro amico di Olivero, Ezra Pound. Babilonia stellata ebbe anche edizioni tedesche ed in altre lingue.
Nel 1945, per i tipi dell’Editore romano Donatello De Luigi, frutto di una lunga permanenza, esce Turchia senza harem che ancora oggi è un ottimo libro sulla storia, usi e costumi di un paese che Kemal Ataturk stava portando verso la modernità. Anche questo saggio ebbe traduzione in inglese ed altre lingue.
Del 1946 è il suo unico romanzo Adamo ed Eva in America alla vigilia del secondo diluvio universale. Ai tempi dell’edizione inglese in Italia aveva già tirato più di 650.000 copie.
Dedicherà poi brevi saggi a Giovanni Papini, a Carlo Maria Franzero, a Clemente Fusero e Gabriele d’Annunzio. Curerà per l’Editore Viglongo di Torino la raccolta delle poesie di Padre Ignazio Isler trascrivendole pazientemente dalle edizioni settecentesche.
Le sue poesie in piemontese, oltre che essere sparse in decine di pubblicazioni periodiche, sono raccolte in quattro volumi.
Roma andalusa nasce presso l’Editore Calandra di Moretta (CN) nel 1947; contiene tredici poesie tutte dedicate alla Città eterna. È introdotta da una lettera di Gabriellino d’Annunzio, figlio secondogenito dell’Ariel nazionale e contiene splendide incisioni di Giuseppe Macrì. (Olivero curerà sempre in modo particolare la veste tipografica e la perfetta simbiosi tra parola ed immagine nelle sue opere valendosi di grandi artisti)
Del 1955 sono Ij faunèt dell’Editore Il delfino di Roma. 69 poesie precedute da una prefazione di Alex Alexis (pseudonimo di Luigi Alessio da Caramagna Piemonte, scrittore, poeta, drammaturgo, giornalista, biografo, primo traduttore italiano dell’opera di Celine oggi praticamente sconosciuto ai più, ma che rivalutazione meriterebbe) e con le poesie tradotte in italiano da Clemente Fusero il noto biografo anch’egli da Caramagna Piemonte ed in francese dal poeta corso Anton Francesco Filippini. Bellissima veste grafica ed iconografia di Giuseppe Macrì, Orfeo Tamburi, Gabriele Cena, Giovanni Consolazione e Gregorio Prieto.
1971: la sua opera forse più importante Rondò dle masche. 39 poesie con traduzione in italiano dello stesso autore. Prefazione intervista a cura del poeta, scrittore e giornalista romano Icilio Petrone. Incisioni di John Castberg, Eugen Dragutescu, José Escassi, Giuseppe Macrì, Orfeo Tamburi, Henri Matisse, Gregorio Prieto.
Nel 1983 esce un’antologia di sue poesie con la prefazione di Giovanni Tesio per i tipi della Ca dë Studi Piemontèis di Torino: Romanzìe. Una trentina di poesie ma soprattutto alcune versioni in piemontese da opere di autori di ogni tempo e di ogni nazione. Olivero disse di compiere con la traduzione una sorta di transfert liberandosi così dal pericolo di incorrere in più o meno evidenti plagi. Una delle sue traduzioni più memorabili è quella del Cantico dei cantici da Salomone ma non meno meritorie altre ad esempio da Catullo, da Saffo.
Per la presentazione di Romanze lo va ad intervistare a Roma la Dott. Albina Malerba, oggi direttrice della citata Ca dë Studi Piemontèis. La lunga intervista è pubblicata sulla rivista torinese, organo della Famija Turinèisa, ‘l caval ‘d brôns N° 5 e N° 12 del 1983. Albina Malerba se ne viene via dalla villetta di Olivero, ai piedi del Pincio, quando il sole è già calato dietro il cupolone; scendendo per via del Babbuino con negli occhi e nel cuore le parole di Olivero e le immagini della sua casa, traboccante di preziose opere d’arte degli artisti che gli furono amici e collaboratori, la poetessa porta con se una certezza:
Gli angeli saranno generosi con un poeta della tempra e della forza di questo piemontese di Roma.
Le sensazioni ed i sentimenti di Albina Malerba sono gli stessi che ho provato, e che mi permetto di condividere pienamente, il 25 di maggio del 1996 dopo aver trascorso l’intera giornata nella casa di Vicolo del Borghetto mentre, attraversando Via Margutta e Piazza di Spagna, me ne tornavo verso Termini e la metropolitana che mi avrebbe condotto a Fiumicino e da lì a Torino. Mi permetto questa piccola modifica, alle parole di Albina:
Gli angeli sono stati generosi a farci dono di un poeta della tempra e della forza di questo piemontese.
Olivero compone poesie fino a tarda età. Ancora sul finire del 1989 (a 80 anni) compone, di ben 133 versi, la Cantada del balon mondial dedicata al Campionato Mondiale di Calcio Italia 1990!
Luigi Armando Olivero muore il 31 luglio del 1996 nella sua casa romana solo e dimenticato quasi da tutti. Solo pochi amici lo ricorderanno: Camillo Brero sul suo Piemontèis ancheuj, Franca Spagarino e Giovanna Viglongo sull’Almanacco fondato dal marito e padre Andrea Viglongo e Beppe Burzio sulla sua Assion piemontèisa.
In conclusione una poesia di Olivero tratta da Roma Andalusa, dal 1947 mai più ristampata. Mia è la libera traduzione che non ha altra pretesa se non quella di mettere in grado il lettore, cui sia ostico il piemontese, di capire la poesia.
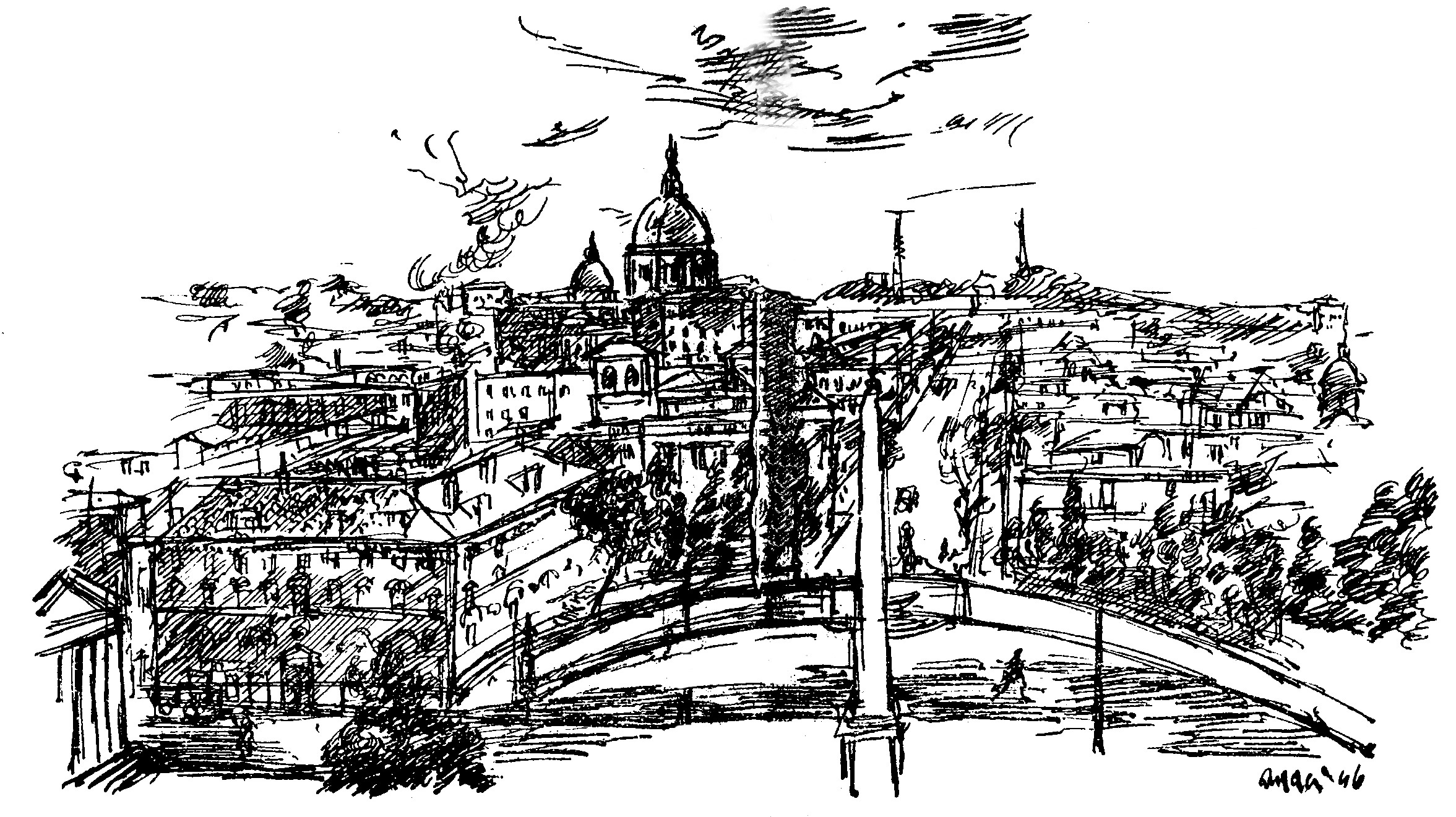
Incisione di Giuseppe Macrì da Roma andalusa Editore Calandra Moretta CN 1947
Le ciòche ‘d Roma Le campane di Roma
Al poeta Aldo Daverio
T’ij sente le vos ëd le ciòche roman-e Senti le vocii delle campane romane
ch’a prego, ch’a pioro, ch’a rijo, che pregano, piangono, ridono,
ch’a taso e a s’arpijo che tacciono e riprendono
pi s-clin-e più squillanti
davsin-e vicine
pi pian-e più smorte
lontan-e? lontane?
Ant l’ora Nell’ora
‘d mesdì ch’as colora del mezzogiorno che si colora
dël nimb andorà ch’a circonda la testa dell’aureola dorata che circonda il capo
‘d j’àngei nossent degli angeli innocenti
e tuta una festa e tutta una festa
‘d bianche colombe as na vòla di bianche colombe se ne vola
ant ël cel macià ‘d viòla nel cielo trapunto di viola
su j’ale dël vent, sulle ali del vento,
su tute le pòrte su tutte le porte
a bato nonsiand ël mesdì come ‘d man battono annunciando il mezzogiorno come mani
ch’a spòrzo, giunzùe, la reusa dël pan. che porgono, giunte, la rosa del pane.
Ant l’ora sèiran-a Nell’ora della sera
quand che tuta la pian-a quando tutta la piana
immensa dl’immensa sità immensa dell’immensa città
a l’é un mar pontinà è un mare cosparso
dë stèilin-e di stelline
ch’a bruso ant la conca vlutà che rilucono nella conca vellutata
dle tërsent mila cà delle trecentomila case
sprofondà sprofondate
(parej ëd cuchije marin-e) (come conchiglie marine)
ai pé dle sèt bleuve colin-e, ai piedi delle sette colline blu,
le vos ëd le ciòche a frisson-o le voci delle campane tremolano
a zonzon-o ronzano
a bësbijo bisbigliano
a s’anlijo si legano
come ‘d tòrtole garve an amor come soffici tortore in amore
‘d zora ij bòrd d’una vasca sopra i bordi di una vasca
ant un òrt corm ëd fior. in un orto colmo di fiori.
Ma a la matin, Ma al mattino
ant la primalba, alle prime luci dell’alba,
quand che ‘l sol a l’é un sèrcc ëd rubin quando il sole è un cerchio di rubino
ch’a bërlus an sla valba che risplende sulla regione
nen deserta non deserta
ma viva e duverta ma viva ed aperta
ma ciaira e seren-a ma chiara e serena
(parej d’un gran lagh an pien-a (come d’un gran lago in piena
ch’a res na parada che regge una parata
‘d tërsent mila nav ancorà di trecentomila navi ancorate
con pont, siminiere, erbo, oblò ‘mbandierà) con ponti, ciminiere, alberi, oblò imbandierati)
dla sità, della città,
anlora le vos ëd le ciòche roman-e allora le voci delle campane romane
a son càude, a son tante, son calde, son tante,
a son sante. son sante.
E ti, cheur, i t’ancante E tu, cuore, t’incanti
a scoteje. ad ascoltarle.
E ti, ànima, it piore E tu, anima, piangi
a tocheje. a toccarle.
Përchè ant tut le ore Perché in tutte le ore
le vos ëd le ciòche roman-e le voci delle campane romane
at carësso ‘d bontà ti carezzano di bontà
ma, a l’alba, a të stiro an sle rùpie dla front ma, all’alba, ti stendono sulle rughe della fronte
ël Sign luminos il Segno luminoso
ëd la Cros della Croce
fàit ant l’aria da un vòle composto nell’aria da un volo
ancrosià incrociato
d’ parpajòle di farfalle
argentà argentate
ch’a ven-o a portete, bësbiand, ël messagi d’amor che vengono a portarti, bisbigliando, il
messaggio d’amore
ëd le reuse d’ Nosgnor: delle rose di Nostro Signore:
ëd le reuse dël cel ch’a fiorisso a milion delle rose del cielo che fioriscono a milioni
- dë ‘d la da le pian-e, dal mar e dal mont - - al di là delle piane, dal mare e dal monte -
ant ij giardin profumà dl’orizont. nei giardini profumati dell’orizzonte.
E le vos dle campan-e E le voci delle campane
roman-e romane
at visco un miraco ant ël cheur ti accendono un miracolo nel cuore
ch’at dà la speransa, la fiusa, ‘l boneur. che ti da la speranza, la fiducia, la felicità.
T’ij sente le vos ëd le ciòche roman-e Senti le voci delle campane romane
ch’a prego, ch’a pioro, ch’a rijo, che pregano, che piangono, che ridono,
ch’a taso e a s’arpijo che tacciono e riprendono
pi s-clin-e più squillanti
davsin-e vicine
pi pian-e più smorte
lontan-e? lontane?
Scotije, ò fratel piemontèis. Ascoltale, o fratello piemontese.
E prega e canta con mi E prega e canta con me
- con ij doi brass dëstèis - con le due braccia distese
vèrs l’azur infinì - verso l’azzurro infinito -
për ch’a riva perché giunga
a Nosgnor a Nostro Signore
la fiama ‘d tò cheur la fiamma del tuo cuore
ch’a brusa d’amor che brucia d’amore
për cost paìs ëd boneur per questo paese di felicità
che ti ‘t veule ch’a viva: che tu vuoi che viva:
che ti ‘t veule ch’a viva che tu vuoi che viva
përchè l’é fieul dla toa fòrza, perché è figlio della tua forza,
përchè l’é miola ed toa scòrza, perché è midollo della tua scorza,
përchè l’é sangh perchè è sangue
dël tò sangh, del tuo sangue,
përchè l’é la fior perchè è il fiore
benedìa benedetto
dël tò dolor. del tuo dolore.
Ò piemontèis, O piemontese,
crija urla
crija urla
crija urla
fòrt ël tò amor forte il tuo amore
sle vos matinere dle ciòche d’ Nosgnor. sulle voci mattutine delle campane di Nostro
Signore.
Pasqua, 1942
(Roma andalusa 1947)
*******
Luigi Armando Olivero
Villastellone, 2 11 1909 ~ Roma, 31 7 1996
È lo stesso articolo precedente però pubblicato su altra rivista con una differente chiusa e due poesie inedite.
Gioventura piemontèisa, organo dell'omonima Associazione pubblicato a Torino N° 4 ottobre 2009 pagg. 19 ~ 20
In conclusione due poesie di Olivero che mi risultano ad oggi inedite. Sono entrambe manoscritte autografe e provengono dal Fondo Olivero presso l’AssOlivero di Villastellone, Associazione quest’ultima nata con lo scopo di valorizzare l’opera del suo grande concittadino. La grafia è quella originale di Luigi Olivero senza modifica alcuna. Entrambe le poesie risalgono all’incirca alla metà degli anni ’30.
Ël giarighin
Ti ìt ses un giarighin
candi, inossent
che t’amgrumlisse davsin
a me cheur
e ‘t tramole ‘d sentiment.
Mi l’hai fate una nicia con mia bin,
l’hai ambotila ‘d gòi për tò boneur
e i rijo
e i son content
s’i scoto ch’a dësgrun- i tò dentin
le mandòle salà di me basin.
E quand ch’it raspe j’onge
reusa
e it l’has paura
përchè na pen-a ancreusa
smìa ch’at tortura;
ò giarighin d’ mia vita e d’ me boneur,
mi sento un grop an gola e un tonf al cheur.
Ant la conca ‘d mie man,
për consolete
ël tò facin uman
preuvo a cunette
e am ven ant j’eui n’azur ëd paradis
se tò museto a fa bogé ‘n soris;
e i rijo torna dël mè rije s-clin
se i tò dentin
arpijo a dësgruné
- crocand, sensa pensé -
le mandòle salà di me basin.
Ò cit ferfoi ëd carn, ò maravia
viva d’amor,
che con i tò sospir ëd gelosia
e lë vlu ‘d tò calor
t’has ansopì ‘l dolor
dl’anima mia;
it porterai con mi
për tuta grama strà dla vita mia:
e it lasserai mai pì
né neuit né dì
fin che ‘nt ël mond ai sia
una carëssa e un sofe ‘d poesia.
…Perché
ti ‘t ses un giarighin
candi, inossent,
che t’amgrumlisse davsin
a me cheur
e të më scaudi i seugn dël sentiment.
Oh fé’l dësdeuit su na bochin-a bela…
Oh fé’l dësdeuit su na bochin-a bela…
ch’at fa na gòi… (l’è un rapolin ‘d cerese!)
e pura tant sovens at fa ‘l disperse
‘d neglesse, con n’arietta barivela!
‘Mbrancheje a l’improvis la soa facin-a,
dësverseila andaré ‘n mes ai tò brass.
Tenla reide a la vita, s-ciass ë-s-ciass,
anche s’a sfeudra j’onge – la gatin-a!
Sente, sota i tò làver, coi dentin
ch’a s-cianco, ch’a rifuso ‘l tò basin…
E un cheur! Un cheur ch’a bat precipitos
come ‘d na rondolin-a spaventà:
ël cheur – an fin di cont – dla toa morfela.
Oh fé’l dësdeuit su na bochin-a bela…
(Altro titolo dato da Olivero alla poesia: Vigliacucio)
*********
Voci dialettali, organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali pubblicato a Roma N° 147/12 dicembre 2009 pagg. 20 ~ 22
Lo stesso articolo su Gioventura piemontèisa, organo dell'omonima Associazione pubblicato a Torino N° 1 aprile/giugno 2012 pag. 19
Una poesia inedita (?) di Nino Costa
Nino (Giovanni) Costa (Torino 1886 – 1945) è sicuramente il più noto tra i poeti piemontesi del secolo scorso. Presento qui una sua poesia datata 19 12 1920 con tutta probabilità inedita.
Nel 1920 Costa compone poesie che pubblica sul settimanale torinese Birichin sotto lo pseudonimo di Na Mamina. Una mammina. Finge cioè di essere una fanciulla in dolce attesa e ne racconta vicissitudini e sentimenti. Tra l’altro alla poveretta ne fa capitare di tutti i colori. Lo stratagemma cade quando il direttore del settimanale, Paggio Fernando (Fernando Viale) chiede di conoscere la sventurata. Costa si presenta e al povero direttore quasi manca il fiato. Scoperto il trucco, Costa riunisce le poesie nella raccolta Mamina che viene pubblicata nel 1924 dall’Editore Lattes di Torino. È questa la prima raccolta di poesie del poeta cui seguiranno Sal e peiver Sacerdote Torino 1924, Brassabosch Casanova Torino 1928, Fruda madura SELP Torino 1931, Roba nostra Boccardo Torino 1938, Tempesta Aurora Torino 1946.

Nino Costa
Mamina non contiene tutte le poesie pubblicate su ‘L Birichin con tale pseudonimo. In una accurata ricerca l’Editore torinese Andrea Viglongo con la moglie Giovanna Spagarino ne rintracceranno molte altre che verranno pubblicate nella raccolta Tornand del 1977. Nel 1987 la figlia dell’Editore Viglongo, Franca, pubblica Per conoscere Nino Costa che contiene l’indice dei titoli e dei capoversi di tutte le sue poesie. Così recita il titolo. Di inediti, dal 1987, ne spunteranno altri. Inoltre la raccolta de ‘L Birichin che venne utilizzata, di provenienza Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, era in parte lacunosa causa l’alluvione che ne sconvolse la città.
In ogni caso la poesia in questione non compare nell’indice dei capoversi e la sua provenienza è tale da giustificarne l’inedito (sempre con una certa cautela).
Il manoscritto di Costa appartiene alla ricchissima collezione di carte di Tito Gantesi, al secolo Chiaffredo Tommaso Agostinetti (8 agosto 1857 - 8 marzo 1938). Fu notissimo bibliofilo e ricercatore. Scoprì importanti inediti e collaborò con il suo aiuto alle opere di molti letterati piemontesi. Il poeta Luigi Armando Olivero, Socio Fondatore dell’A.N.PO.S.DI., di cui ho rievocato vita ed opere nello scorso numero della rivista, lo conosce quando questi è ormai avanti con gli anni e si è trasferito proprio nella natia Villastellone di Olivero. I due fraternizzano e Agostinetti promette ad Olivero di lasciargli le sue carte in eredità. Poco tempo dopo muore improvvisamente mentre Olivero è a Parigi. La vedova, senza perder tempo, aliena la quasi totalità delle carte del marito. Ad Olivero riserva una piccola parte di queste.

Tommaso Agostinetti visto dal caricaturista "Carlin" da Armanch piemontèis 1941
Recentemente ho incontrato un collezionista di Margarita di Cuneo, il Sig. Silvio Bonino che, alla morte di Olivero, dagli eredi, ha acquistato la gran parte delle carte e dei libri che si trovavano nell’abitazione che Olivero possedeva sulla collina del Montserrat, in quel di Borgo San Dalmazzo CN, dove trascorreva parte delle vacanze estive.
Proprio nel fondo che Olivero ha ricevuto dalla vedova Agostinetti, la poesia manoscritta da Costa, senza titolo, e firmata Na Mamina (Nino Costa), datata 19 12 1920, é stata ritrovata dal Sig. Silvio Bonino che, gentilmente, ne ha concesso la pubblicazione.
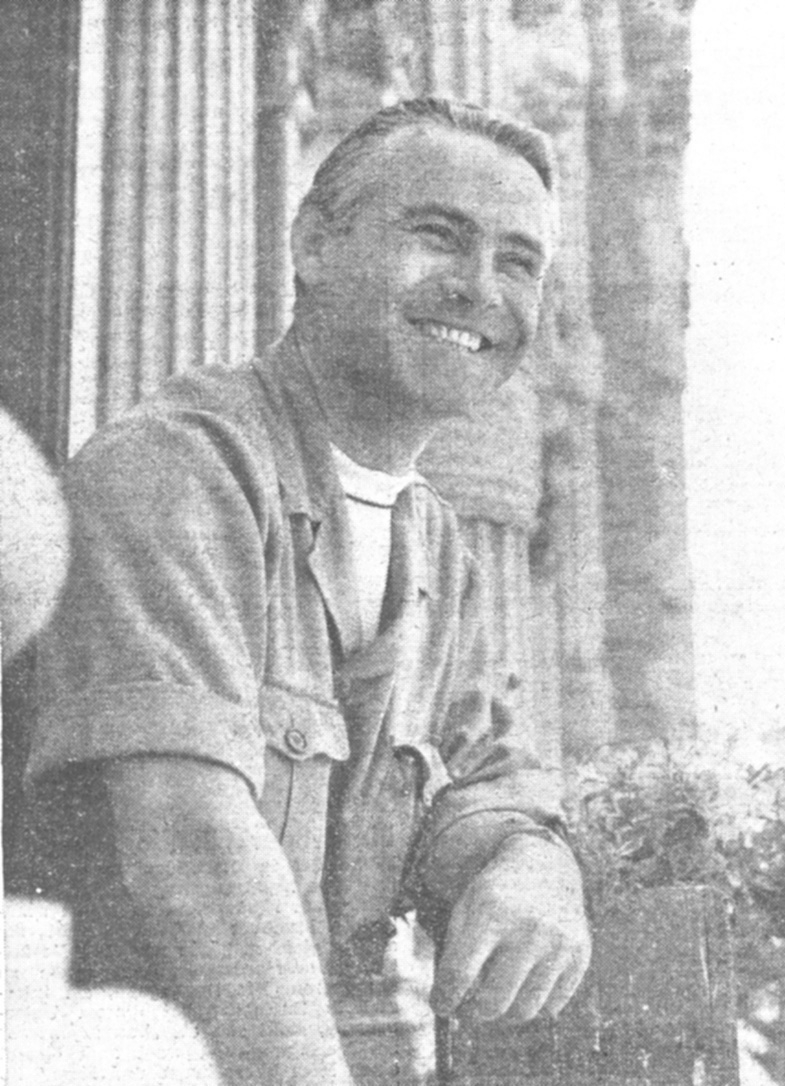
Il poeta Luigi Armando Olivero in una immagine inedita per il pubblico italiano tratta dalla rivista di Dusseldorf Herz dame che nel 1952 ha pubblicato la traduzione tedesca di Adamo ed Eva in America con il titolo Amerika total Plem Plem?
Questa la storia di questo scritto giovanile di Costa che rivede la luce dopo quasi un secolo. È incentrato sul grande poeta, scrittore, politico piemontese Angelo Brofferio (Castelnuovo Calcea AT 6 dicembre 1802 – Locarno 25 maggio 1866) immaginando un ipotetico incontro con la fanciulla impersonata dal Costa.
Alla poesia, che non ha indicato un titolo, unisco una mia traduzione letterale che, ovviamente, non ha alcun intento letterario o poetico, ma solo quello di mettere chiunque in grado di comprenderla.
l’è nen për facessié, parlo ‘n s’ël serio: non è per scherzare, parlo sul serio:
stamatin sôt la leja dle memorie stamane, sotto il viale delle memorie
sôn ambatume ‘nt l’avôcat Brofferio. mi sono imbattuta nell’avvocato Brofferio.
I l’ài fërmalo s-ciet - « Bondisserea (1) L’ho fermato schietto - «Buongiorno (1)
« I rivo adess da Castelneuv Calcea (2) «Arrivo or ora da Castenuovo Calcea (2)
për n’ôcasiôn ch’a l’è ‘n pecà sgairela… per un’occasione che è un peccato sprecare…
A j’è dôì cavajér ch’ai fan la festa…» Ci sono due cavalieri cui fan la festa…»
«Aì fan la festa?!.. Diao… dislo dabôn?» Gli fan la festa?!.. Diavolo… dite sul serio?»
«Ma no, capiòmsse, ai taio pà la testa «Ma no, capiamoci, non gli tagliano la testa
l’è quaich amis, sa bin – ch’ai da ‘l bôcôn» è qualche amico, sa, che gli offre da mangiare»
«Ah! L’è ‘n disné… ma chiel, mônsù Brofferio «Ah! È un pranzo… ma lei, signor Brofferio
ch’a l’à sempre pià ‘n gir tuti ij bindei che ha sempre preso in giro tutte le onoreficenze
adess… a va…» ‘L pôeta am guarda serio adesso… va….» Il poeta mi guarda serio
e peui am fa «Masnà, rasôna mei… e poi mi fa « Bimba, ragiona meglio…..
quand che ‘l Prinsi o lo Stat o ‘l mônd a ônora quando il Principe o lo Stato o il mondo onora
i g ianfôtre, le birbe o ij foi fôtù, i babbei, i furfantelli o gli sciocchi
la man dla Pôesia a s’aôssa ‘nlôra la mano della Poesia s’alza allora
contra le faôsse glorie e ai campa giù. contro le false glorie e le butta giù.
Ma s’it bëstëmie ‘n piassa it preghe al dom (3) Ma se bestemmi in piazza e preghi al duomo (3)
ti tl’as capime e i veui nen dite ‘d pi, mi hai capito e non voglio dirti di più,
la vôs quand ch’a l’è daita a ‘n galantom la parola quando è data ad un galantuomo
viva la vôs! I sôn côntent d’co mi… viva la parola! Son contento anch’io…
e peui sti sì sôn gent dla mia famia e poi queste sono persone della mia famiglia
gent dël me sang: la Musa dël Piemônt persone del mio sangue : la Musa del Piemonte
la nostra bela e frësca pôesia la nostra bella e fresca poesia
quand ch’a l’à vestie a l’a basaje ‘n frônt quando le ha vestite le ha baciate in fronte
un a l’à daje ‘l tôn e l’armonia l’uno ha dato il tono e l’armonia
a le canssôn dla rassa biceriña (4) alle canzoni dei Torinesi (4)
l’aôtr l’à trôvà ‘l filôn dla pôesia l’altro ha trovato il filone della poesia
scôtand parlé sôa cita: Cateriña. ascoltando parlare la sua piccola: Caterina.
A l’è për lon, perché ch’a sôn me fieui È per questo, perchè sono miei figliuoli
Sicur! Ij lo dirai fora d’ij feuj Sicuro! E lo dirò sopra le righe.
Papà Brofferio l’è côntent për lôr!» Papà Brofferio è felice per loro!»
19 12 1920
Na Mamina
(Nino Costa)
(1) Saluto tipico tra persone di pari estrazione sociale.
(2) Castelnuovo Calcea, in provincia di Asti, paese natale di Angelo Brofferio.
(3) Il verso sta ad indicare ipocrisia.
(4) Rassa biceriña soprannome dei Torinesi. Da Bicerin (bicchierino)bevanda tipica servita ancora ai nostri giorni nei bar di Torino a base di latte, cioccolata e caffè.
(5) San Giors noto ristorante, ritrovo degli artisti torinesi, sito nel quartiere di Porta Palazzo, da poco, purtroppo, trasformato in locale cosiddetto etnico.
*********
Voci dialettali, organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali pubblicato a Roma N° 150/15 dicembre 2010 pagg. 21 ~ 23
Piemontèis ancheuj mensile pubblicato a Torino N° 5 maggio 2012 Pagg.10 ~ 11. Qui tradotto in piemontese da Michele Bonavero e con piccole modifiche.
Luigi Armando Olivero (1909-1996)
Gli inizi
Di Luigi Olivero già ho scritto su Voci dialettali, portavoce di questa benemerita Associazione che, nel lontano 1952, contribuì a fondare con Turno Schiavoni di Ancona, Renata Sellani di Senigallia, Giulio Cesare Zenari di Verona, Gino Cucchetti di Venezia, e Alfredo Lucani di Pescara. Dell'ANPOSDI fu a lungo Vicepresidente e direttore delle due riviste che Voci dialettali hanno preceduto: Poesia dialettale (1956-1961) e La fiera dialettale (1970).
Si sa che è sommo poeta in piemontese. È però di più, molto di più. La sua riscoperta meriterà tempo e fatica. Viaggiatore instancabile per le vie del mondo. Corrispondente in pace ed in guerra, dalle dune assolate d'Africa ai campi di battaglia della Spagna insanguinata dalla guerra civile, dai mari in tempesta dell'Egeo ai cieli del mondo. Critico letterario, cinematografico, teatrale, di melodramma, balletti, concerti sinfonici e leggeri. Autore di importanti saggi di costume e romanzi. Traduttore dall'inglese, dal francese, dal tedesco. Direttore di una stazione radio a San Francisco. Autore di commedie per il teatro, la radio, di sceneggiature cinematografiche.
Amicizie importanti, dalla Deledda a Sibilla Aleramo, Da Lorca a Cocteau, da Malreaux a Pound, da Croce al Flora e a lungo potrei continuare.
Oggi ne seguo i primi passi. Luigi Armando Olivero nasce a Villastellone (Torino) il 2 novembre 1909 alle ore 23.30 come dichiara all’anagrafe il padre Antonio di anni 22, di professione fabbro ferraio, attività che cambierà poi aprendo un’officina da ciclista; la mamma è Innocenza Perlino, sarta. Sarà proprio la campagna del suo grosso borgo agricolo natio, fonte di ispirazione per le sue prime composizioni. Il padre, nel periodo della Grande Guerra, è capofabbrica militarizzato alle Officine Bauchiero di Condove (bassa Valle di Susa sulla via del Moncenisio), dove conduce anche la famiglia e dove il piccolo Olivero frequenta parte del primo ciclo scolastico. Secondo ciclo a Carmagnola. Frattanto una grave infermità lo costringe lungamente a letto. Sarà questo un momento decisivo per lui ed il suo avvenire. È la madre che lo fa incontrare, il bimbo malato, costretto all'immobilità, con la poesia. Ma non solo. Olivero è onnivoro. Legge tutto quanto trova, e quando non capisce, con testardaggine rilegge e... rilegge. Infine la Scuola Tecnica a Torino.
Dall'Armanach piemontèis del 1938, estraggo un suo pezzo in cui ci descrive un sabato pomeriggio di lui quindicenne, con altri scavezzacolli suoi pari, lungo le nebbie invernali di Sua Maestà il Po.
D’invern, ël veciòt an pension a sta mej al caud, a l’Osteria dei Pesci Vivi, dove la vsinansa ‘d compare Pò, andurmì sota la cuverta spëssa dla nebia, as fa sente anche pi intima, pì filtrà, trames a l’ass dë baston e lë scart dël bagat, tant ch’a tramola ël bon vinèt piemonteis drinta i bicej verd ch’a sursauto a ògni pugn armà ‘d fiera carta ch’a toca ‘l taulin…
Ma noi giovo, l’oma amprendùa vorèi-je bin a compare Pò ant tut’autra manera.
Scomësse dë studentin ëd quìndes ani, sul Pont Umberto, ël saba dòp disné. Coleta, fra sèt ò eut birichinèt dësfrandà. Sghijada general longh ël senté ch’a comensa con un arch ch’a në smija tramandà da l’Età dla Pera e che anvece a l’è stait fait a bela pòsta për che i cobièt, passandije sota, as sentìjsso’d pi Adamo ed Eva ant ël Paradis Terrestre, ricostruì ant na pelìcola dla Cines.
Giù, tuti, fin-a al prim imbarcadero. Yole, barchëtte ansugnachìe, anvlupà ant ël nebion, con le traversin-e bagnà ch’a smijo ‘d còste scheletrìe d’impossìbii animai antidiluvian sëccà ‘nt la pàuta. Sbalaucié pericolos dë sponde ant un saut ùnich ëd quatr Tarzan masnà ch’a sguisso via, scianchërland la tërlandin-a grisa dla nebia, ant un trabaté ‘d luchèt e ‘d caden-e artirà an tuta furia. A pòca distansa a jë sprona un’autra galera:
- Alé, tigròt dël Mompracem; all’arrembaggio! – a crija, da lì dzora un Sandokan armà ‘d riga milimetrà da disegn, con una man sul pivò dël timon e con la testa auta, ardìa, ch’a pòrta ‘l bareto a l’incontrare con l’ala voltà giù dël cupis.
Anfreidor, angine, mal ai dent, a son i nemii invìsibii ma present, ch’a respiro l’aria istessa che noi respiroma… Ma ché! Gnun-e tëmme!
A rispond un Tremal Naik, da la nòstra barca, pontand una squadra – un dil passà drinta a l’ujét – e fasend part dal prim milim ëd colp arsonant d’archibus, fait con la boca, e diret a la ciurma dla barca ch’an dà la cassa.
Sandokan alla riscossa, Le avventure di Testa di Pietra, I corsari delle Bermude. Salgari, Salgari, Salgari. Cost ël nòstr fium d’invern, i nòstri imbarch dë studentin ëd quìndes ani, dont së slansavo vers l’aventura stërmà ‘nt le nebie còtie tëbbe dl’entusiasmo ch’a smijava an protegijssa, ògni vòlta, dal mal di dent crònich, da l’angina dolorosa, e da l’anfreidor: valet de chambre ëd Madama Polmonite.
D’inverno il vecchietto, pensionato, sta meglio al caldo, all’Osteria dei Pesci Vivi, dove la vicinanza di compare Po, addormentato sotto la coperta spessa della nebbia, si fa sentire anche più intima, più filtrata, tra l’asso di bastoni e lo scarto del Bagatto (Diavolo), tanto che tremola il buon vinello piemontese dentro i bicchieri verdi che soprassaltano ad ogni pugno armato di fiera carta che tocca il tavolino…
Ma noi, giovani, abbiamo appreso a volergli bene a compare Po in tutt’altro modo.
Scommesse di studentelli di quindici anni, sul Ponte Umberto, il sabato dopo pranzo. Colletta tra sette od otto birbantelli scatenati. Scivolata generale lungo il sentiero che inizia con un arco che ci sembra tramandato dall’Età della Pietra e che invece è stato fatto a bella posta perché le coppiette, passandoci sotto, si sentissero di più Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, ricostruito in un film della Cines.
Giù tutti, fino al primo imbarcadero.
Yole, barchette sonnacchiose, avvolte nel nebbione, con le traversine bagnate che sembrano costole scheletrite di animali antidiluviani disseccati nel fango. Dondolare pericoloso di sponde in un unico salto di quattro Tarzan fanciulli che corrono via, lacerando la pellicola grigia della nebbia, in uno squassare di lucchetti e di catene ritirate in gran furia. A poca distanza ci sprona un’altra galera:
- Alè, tigrotti di Mompracem, all’arrembaggio! – grida, da li sopra, un Sandokan armato di riga millimetrata da disegno, con una mano sulla barra del timone e con la testa alta, ardita, che porta il berretto al contrario con la visiera voltata in giù dalla nuca.
Raffreddore, angine, mal di denti, sono i nemici invisibili ma presenti, che respirano la stessa aria che noi respiriamo…
Macchè! Nessuna apprensione!
Risponde un Tremal Naik, dalla nostra barca, puntando una squadra, - un dito infilato dentro l’occhiello – e facendo partire dal primo millimetro risuonanti colpi d’archibugio, fatti con la bocca, e diretti alla ciurma della barca che ci da la caccia.
Sandokan alla riscossa, Le avventure di Testa di Pietra, I corsari delle Bermude. Salgari, Salgari, Salgari. Questo il nostro fiume d’inverno, i nostri imbarchi di studentelli di quindici anni, che si slanciavano verso l’avventura nascosta nelle nebbie morbide e tiepide dell’entusiasmo che sembrava ci proteggesse, ogni volta, dal mal di denti cronico, dall’angina dolorosa, e dal raffreddore: valletto di camera di Madama Polmonite.
Olivero inizia giovanissimo a scrivere poesie in italiano. I primi esempi li ritroviamo su due riviste del 1926: l'orobica Il pensiero e la milanese Giovinezza d'Italia. Una sua piccola raccolta di poesie in italiano è premiata, nello stesso anno, dall'Illustrazione Nazionale di Bologna. Lui stesso ci racconta che avrebbe, con tutta probabilità, come molti suoi pari, continuato per un po' a carduccianeggiare, a dannunzianeggiare, a rapisardeggiare e che poi, deluso, avrebbe, con tutta probabilità, smesso se...
Se non ci fosse stato l'incontro con la poesia piemontese. Nel 1928 si imbatte in un sonetto di Alfredo Nicola pubblicato su Il Pasquino (settimanale umoristico torinese). Olivero ci racconta che fino allora Io non avevo ancora scritto una sola virgola in piemontese. Nella sua poesia ‘L regal ‘d NatalAlfredino manifesta tutti i suoi dubbi nella scelta di un regalo per la fidanzatina, pensando infine di ricorrere ai soliti due etti di diablotin (cialde ricoperte di cioccolato allora ed oggi alla moda). Olivero risponde ad Alfredino con due suoi sonetti, in piemontese, in cui, al posto dei due etti di diablotin, consiglia invece due etti di basin (baci), che sicuramente sarebbero meglio accolti, e poi, se del caso, rafforzati dai due etti di diablotin.
Da questo primo incontro, l'amicizia tra i due poeti. La presentazione al gruppo, allora in formazione, de Ij Brandè, che capitanati da Pinin Pacòt intendono ravvivare la poesia piemontese, allora sul punto di estinzione, se non già del tutto estinta. (Brandè: alari, i due pezzi di ferro che nel camino si utilizzano per tenere viva la fiamma rialzando il legno e permettendo un maggiore afflusso d'aria).
Ora una poesia inedita della metà degli anni trenta facente parte del Fondo Olivero giacente presso l'AssOlivero di Villastellone.
(Mia è la traduzione sia della poesia che dell'articolo. Entrambi non hanno alcuna altra pretesa se non quella di rendere comprensibile il testo al lettore cui sia ostico il piemontese.)
Marta Marta
Ansema, ant la sèira, Insieme, nella sera,
navigavo an boneur viaggiavamo felici
vers colin-e spàlie. verso pallide colline.
La faussìa dla lun-a La falce della luna
durmìa su mè cheur… dormiva sul mio cuore…
As ciamava Marta. Si chiamava Marta.
L’avìa j’euj pien ‘d rosà Aveva gli occhi pieni di rugiada
parèj ‘d chi ch’a seufr; come di chi soffre;
l’avìa ùmid ij làver aveva umide le labbra
parèj ‘d chi ch’a prega; come di chi prega;
la fàcia ‘nvisca ‘d reuse il viso splendente di rose
come chi ch’a veul bin… come chi ama…
La faussìa dla lun-a La falce della luna
durmìa su mè cheur… dormiva sul mio cuore…
Voria esse për chila Vorrei essere per lei
col che gnun l’era stàit: chi nessuno era stato:
la gioventù, la gloria, gioventù, gloria,
l’argioissansa, la vita. tripudio, vita.
Ma son stàit un ilus: Ma sono stato un illuso:
la domora d’na sèira. il trastullo d’una sera.
La faussìa dla lun-a La falce della luna
durmìa su mè cheur… dormiva sul mio cuore…
L’avìa un rije ‘d pèrla Aveva una risata di perla
ch’am balìa ‘nt le ven-e che mi ballava nelle vene
e na boca soav e una bocca soave
con un deuit d’educanda. con un garbo da educanda.
«Come ‘v ciame?» l’hai dije. «Come vi chiamate?» le ho detto.
«Marta» a l’ha rijù pian. «Marta» ha riso piano.
La faussìa dla lun-a La falce della luna
durmìa su mè cheur. dormiva sul mio cuore.
Mesaneuit a sonava Mezzanotte rintoccava
e a l’ha nen dime adiù. e non mi ha detto addio.
L’avìa un grop an gola, Avevo un nodo in gola,
na suitin-a ancreusa un’arsura profonda
‘n anvìa ‘d seugné un desiderio di sognare
un grand lagh ëd parole. un grande lago di parole.
As ciamava Marta. Si chiamava Marta.
Për doe strà diverse Per due differenti strade
l’oma portà ‘nt noi abbiamo portato in noi
una greva tristëssa. una tristezza greve.
L’hai nen vorsùje bin Non ho voluto bene
a gnun’àutra fija: a nessun’altra fanciulla:
mach al nòm ëd silensi solamente al nome del silenzio
mach al nòm ëd Marta... solamente al nome di Marta...
La faussìa dla lun-a La falce della luna
a deurm ’d zora mè cheur. dorme sopra il mio cuore.
Scultura in gesso del giovane Olivero, forse di Giuseppe Macrì.
(Proprietà privata)
********
Piemontèis ancheuj mensile pubblicato a Torino N° 7/8 luglio/agosto 2012 Pagg.10 ~ 11 con traduzione in piemontese di Michele Bonavero.
Luigi Armando Olivero (1909-1996)
Gli inizi ~ Seconda parte
Dopo aver brevemente tracciato l'iniziale cammino di Luigi Olivero dalla natia Villastellone alla ricerca di uno spazio tutto suo in cui esprimersi, riprendo, ampliandolo, il momento forse più importante nella sua vita: quello in cui inizia a scrivere nel suo dialetto che più non abbandonerà durante la sua lunga esistenza.
Ho narrato dell'incontro con la poesia di Alfredo Nicola, Alfredino. Vediamo come questo episodio ce lo racconta Olivero stesso nella prefazione Il Paradiso in technicolor della poesia di Alfredino che circa 25 anni dopo scrive per la raccolta di poesie Nivole dell'amico Nicola, pubblicata nel 1950:
Esiste una predestinazione per le amicizie, come esiste una predestinazione per i matrimoni. Ero un minorenne metà anarchico e metà sognatore, metà per posa e metà per costituzione, quando, venticinque anni or sono, conobbi Alfredo Nicola. Alto, snello, aristocratico, misurato nella parola e nel gesto, di otto anni più adulto di me, era il mio “contrario”. Da almeno due anni, i nostri versi in italiano (firmati Alfredino i suoi, igi ero i miei) apparivano spesso pubblicati, per una curiosa coincidenza, in décauville nelle colonne del Pasquino di Gec e in quelle di un foglietto arancione – il più piccolo – effemeride settimanale, nutrito di pubblicità e di vagìti letterarii, che Alberto Grappini faceva distribuire nelle vie, nei caffè, nei teatri torinesi.
Un giorno fece capolino da quel periodico un sonetto piemontese di Alfredino in cui si raccontavano le perplessità di un innamorato nella scelta di un regalo per la fidanzatina: perplessità tanto perplessa che finiva per scivolare nei soliti «doi etto ’d diablotin».
Interrompo il racconto di Olivero per riprodurre la poesia di Alfredino:
‘L regal ‘d Natal
vôlend acôntentè me pôciôniñ,
l’avìa neñ veuja ‘d fè bruta figura
e ‘d rôbatè ‘n dôi ettô ‘d diablôtiñ…
Anlôra côn ‘na frisa d’añcalura
ì l’ài gatjaie ‘l cheur un mômentiñ
côntent se ‘na parola, anche se scura,
l’aveissa fame – ônesta – da lumin.
Ma côme ‘na côrenta campagniña
ch’a gira sensa fin, vertiginôsa,
sôa lenga l’à ciapame ‘na rôtiña
ch’i l’ài mai vistne uña tant famôsa…
Mi quindi fasend l’erbo ‘mbacucà
‘n dôi ettô ‘d diablôtin sôñ rôbatà!
La parola torna ad Olivero:
Io non avevo ancora scritto una sola virgola in piemontese. Ma quel giorno mi vennero spontanei due sonettini alquanto scapestrati nella forma e nella sostanza, nei quali mi rammaricavo con Alfredino per la sua scelta che io avrei eletto, se si fosse trattato della mia innamorata, in «doi etto ’d basin», i quali certamente sarebbero stati accolti con maggior entusiasmo chemotàttico se non gastronomico, dalla graziosa ricevente: tanto più che gli altri due etti di «diablotin» potevano ugualmente sopraggiungere di rincalzo a completare la festa. Il giornaletto pubblicò i miei sonettini con la dedica, Alfredino li lesse, mi mandò subito una lettera di allegra solidarietà in cioccolatini e baci da regalare alle nostre leggiadre pupe, io lo ricambiai con un’altra lettera gioconda che venne fatta leggere dal destinatario al comune amico Vincenzo Signorini, allora studente in una delle sei o dodici (o diciotto?) facoltà in cui si è poi laureato, il quale ci avvicinò: ci fece conoscere personalmente. Fu così che Alfredino ed io divenimmo amici. E fu così che Alfredino mi indusse alla poesia piemontese, la cui «càmola» mi venne presto innestata nel cervello da Pinin Pacòt a cui egli, a sua volta, mi presentò contemporaneamente ai poeti, allora già uniti in gruppo e collaboratori al Caval ’d Brons, Carlottina Rocco, Renzo Brero, Aldo Daverio, Armando Mottura, Renato Bertolotto e tutta la gaia brigata con la quale si costituì rapidamente la «Compania dij Brandé.
Ecco i due sonetti di Olivero pubblicati su il più piccolo del gennaio 1929:
‘L me regal
I
Ti ‘t ses l’eterno cit ch’a l’à paura
dle faje, dël diaôlot e dël magnin.
Ma ciamô mi!… ‘ndè fe côla figura
‘d regaleje a la sfrincia ii diablôtin!
L’è pà ‘n regal, lô-lì. Cônven-e pura,
‘t l’as propi avù ‘n penssè ‘n po’ miserin.
Ti, ‘nvece, côn dôi etto… d’ancalura
‘t pôdie slanssete e deie… ‘n bel basin.
Chila, spôrsend-te tuta la bôchin-a,
l’avrìa pi nen pôdù mnè la longhina
o dete ‘d gena côn sôa vôs grassiôsa.
E ti, côn n’aria franca e côntegnôsa,
‘t l’avr’a pôdù bësbeje : «O pôciônin,
t’aùguro ‘n bòn Natal côn côst basin!»
II
Un bel basin da mascc, giust e serà
su la sôa bòca frëssca e caprissiôsa,
un ‘d côi basin ch’a sciodô mach d’istà
o ch’a pasiò la fiëtta pì nervôsa;
dilô ti, dilô ti, ch’it l’as cantà
l’ariëtta dla môntagna delissiôsa,
dilô ti, ch’it l’as l’anima armôniôsa
dël poeta gentil an-namôrà:
dilô: l’er-lò nen mei côl bel basoto
ai dôi etto ‘d pastiss ch’it l’as portaje?
l’er-lò nen mei ‘na paròlina bela -
ch’a strensëissa dôi cheur an t’un sôl moto -
che ‘l nastrin vernisà ‘d côle batiaje,
che ‘l dôi etto ‘d pastiss ch’it l’as portaje?
Mentre la poesia di Alfredino è poi stata pubblicata nella raccolta Penombre del 1929 con dedica ad Olivero, i due sonetti in risposta da allora giacciono, non più ripresi, nelle pagine, oramai praticamente introvabili, del giornalino che le ospitò: sono pertanto praticamente inedite per l'odierno lettore.
L'incontro con Ij Brandé, ed in particolare quello con Pinin Pacòt, avverrà, di lì a poco, in un'osteria della collina torinese e schiuderà il rapporto personale un'amicizia difficile ma sincera, fragile ma preziosa con l'altro grande letterato della cultura in piemontese del Novecento che così ci presenta Olivero in un ritratto sulla rivista Ij Brandè N° 151 del 15 dicembre 1952:
E cola seira, për la prima vòlta, mi, i l’hai conossù Vigin Olivé, che as në rivava da soa Vilastlon tapà con un magnìfich paira ‘d braje bianche (antlora ancora ‘d mòda), che mach a vëddje, a preanunsiavo già soa originalità.
Sùbit i soma capisse. E mentre d’antorn a noi as parlava ‘d dialèt e ‘d grafìa, ‘d teatro e ‘d cansonëtte, ‘d Viriglio e ‘d Paggio Fernando, tra ‘d noi, i l’ero sùbit disse ‘d nòm, che, për noi, a l’avìo ‘l son misterios ëd paròle ‘d riconossiment. E i l’avoma parlà sùbit ëd Baudelaire, ‘d Verlaine e ‘d Rimbaud, ëd Leopardi e ‘d Campana, ‘d Rubén Dario e ‘d Mistral. Poeta che i conossìo mach noi, ò che për lo meno i chërdìo d’esse mach noi a conòsse. … Ma antlora i l’ero giovo, e i la pensavo parèj, quand che i soma conossuse, Olivero e mi. E për lòn, an nòm dla poesìa, i soma dventà sùbit amis.
La stessa serata è raccontata anche da Olivero, non anni dopo, ma a tambur battente sulla rivista Recensioni del 15 ottobre 1930 edita a Palermo!
Una «Bagutta» bicerina. Una temibile concorrente della nota osteria milanese sembra stia per aprire le verande nella nostra città, su per l’erta della collina che conduce a Val San Martino. Infatti, se l’osteria meneghina è meritatamente celebre per i suoi premi e per il suo risotto, la piola subalpina pare lo stia diventando per la sua posizione sovrana – terrazza tra gli alberi con veduta di straforo di tutta la città – e per le deliziose tagliatelle condite con fegatini di pollo (in piemontese: pica-tera) che ne fanno la ghiotta specialità.
Sul tramonto del giorno 5 corr. Si sono adunati, proprio su quella terrazza, i componenti del gruppo degli «Amis del dialet» equivalenti ad una parte dei migliori rappresentanti della nostra musa dialettale. Notavit: il poeta Nino Costa, il prof. Onorato Castellino, l’On. Saverio Fino, il comm. Lupi padre putativo del «Gianduja», Luigi Maggi, Giulio, Carlinot (il re della canzone), l’attore Carlo Vandano, Amelotti, Pinot Casalegno; i giovani: Pinin Pacot, Alfredino, A. Soddanino, Mottura ed altri.
Effusioni, brindisi; frizzi a getto continuo di Carlinot (il re della canzone), dizioni di Nino Costa ( «La Côpà» e una delicatissima canzone trovadoresca ancora senza titolo) (La biondina di Val San Martino? n. d. a.), di Maggi, di Giulio. Accordi per una modesta manifestazione mistraliana, progetti per una prossima riedizione autunnale del «Birichin» giornale di sorrisi cari all’animo del nostro popolo e ai ricordi di scapigliatura di tanti suoi poeti. Canzoni.
Ritorno «a riveder le stelle» e le lucciole di strada Val San Martino (o Carlinot, re della cànzone!) lungo i muri dei villini coperti di glicini e d’ombre…
Come si sarà notato, nelle due poesie trascritte, la grafia è ancora quella che utilizzavano scrittori e poeti facenti capo alla rivista della Famija turinèisa 'l caval 'd brôns. La grafia unificata non è ancora stata messa a punto. Lo sarà di lì a poco. Nell’inverno del 1929~1930, a soli vent’anni, Olivero è chiamato a far parte del gruppo di lavoro alla Direzione dell’O. N. D. (Opera Nazionale Dopolavoro) di Torino con Matteo Bartoli, Nino Costa, Alfredo Formica, Ferdinando Neri, Giuseppe Pacotto, Leo Torrero e Andrea Viglongo. Il frutto di questo lavoro, che purtroppo ebbe a disposizione un limitato lasso di tempo, fu presentato da Pinin Pacòt come introduzione alla collezione Scritor Dialetaj Piemontèis di Andrea Viglongo e da allora conosciuto come grafia Pacotto-Viglongo.
Olivero, nel paragrafo La grafìa piemontese a pag.24 della sua raccolta poetica Rondò dle masche, ricorda così l’episodio:
È, infine, doveroso avvertire che questo parziale ritorno alla grafia tradizionale (vale a dire a quella impiegata, ma senza vera e propria unicità né assoluta continuità, nella seconda metà del Settecento e inizio dell’Ottocento) non è merito di un solo scrittore, come da troppo tempo insistono abusivamente alcuni fanatici mitomani pseudofilologi torinesi da osteria di barriera. In realtà questa riadozione venne accordata collegialmente nell’inverno 1929-1930 e poi meglio consolidata negli anni successivi, nel corso di alcune riunioni di studio che ebbero luogo nella sede dell’OND Provinciale di Torino. Riunioni alle quali parteciparono, oltre al Direttore Tecnico per il Folklore della stessa OND avv. Eugenio Rastelli (e poi citiamo in ordine rigorosamente alfabetico, al fine di non deflorare la virginea ipersensibilità delle confraternitùcole pseudoletterarie torinesi devote a questo o a quello scrittore vivo o defunto), Matteo Bartoli, Nino Costa, Alfredo Formica, Ferdinando Neri, Luigi Olivero, Giuseppe Pacotto, Leo Torrero, Andrea Viglongo. Ma, il loro, non fu certo un lavoro massacrante, giacché si limitò a rinunciare ai due segni arbitrarii ô ed ñ, ad introdurre qualche accento grave o acuto, il trattino di separazione tra la n faucale e la vocale che la segue (e che gli antichi usavano indicare con una h intermedia o non indicare affatto) e idem per il suono s-c che nel passato usava contraddistinguere con un apostrofo intermedio oppure trascurarlo del tutto.
Ed ecco che Olivero prende il volo. Poesia (oltre mille componimenti in piemontese), saggi, romanzi, articoli della più varia umanità, commedie, sceneggiature cinematografiche, trasmissioni radiofoniche, recensioni di ogni genere... Oltre 60 anni di scritti che compongono un immenso scrigno che, poco alla volta, almeno spero, andrà studiato, rivalutato e, soprattutto, nuovamente pubblicato per mettere questo patrimonio a disposizione di chi voglia goderne.

Litografia di Orfeo Tamburi da Ël Tòr N° 4 del 15 settembre del 1945
Pubblicato sul sito WEB di Gioventura piemontèisain attesa che possano riprendere le pubblicazioni della rivista omonima. http://www.gioventurapiemonteisa.net/?p=3467
Luigi Armando Olivero ed il "Futurismo"
Corre il 1933 quando Olivero è al Ristorante del Cambio a Torino in compagnia di Filippo Tommaso Marinetti, in piena polemica antipastasciuttara. Pastasciutta che Marinetti considera un piatto passatista, pesante allo stomaco, assolutamente controindicato al superdinamismo della generazione futurista. In pieno ossequio con i suoi dettami, quel giorno, al Cambio, con Olivero, Marinetti si divora un autentico Vesuvio di fumante pastasciutta.
Da questo, e da altri incontri con Marinetti, prenderà le mosse la composizione del futuristico, nell’ideazione poetica e nella composizione grafica, Aereopoema dl’elica piemontèis che lo stesso Marinetti definirà come vibrante di audacissima aeropoesìa, ùnica in tutti i dialetti del mondo, di cui ci occuperemo tra breve.
Ad Albisola, la cittadina della ceramica d’arte, Tullio Mazzotti, figlio del fondatore delle Ceramiche Mazzotti, tuttora attive, che si farà chiamare Tullio d’Albisola, inizia un intenso rapporto con i Futuristi e stringe amicizia con Munari, Marinetti, Fontana e tanti altri che frequentano il suo atelier. Le lettere che gli verranno scritte negli anni dai tanti amici e collaboratori futuristi, saranno poi raccolte e pubblicate in ben quattro volumi.
Oltre che alla ceramica, di cui diviene maestro, si dedica anche alla poesia e compone L’anguria lirica, un lungo poema passionale che verrà pubblicato, come secondo esempio di tale sistema, stampato su fogli di latta. È illustrato da Munari e Diulgheroff con prefazione di Marinetti. L’impressione è della lito-latta Nosenzo di Savona per le Edizioni futuriste di “Poesia” di Roma.
Un giovane studente di architettura, Italo Lorio, autore di novelle e racconti (Fumo negli occhi Montes Torino 1934, Tempo di marcia Montes Torino 1935), è amico e collaboratore di Tullio d’Albisola. Chiede più volte di poter collaborare a le grandi firme di cui, al momento, Olivero è redattore capo e direttore, in assenza di Dino Segre (Pitigrilli) all'estero per motivi politici. Dopo ripetuta insistenza, Lorio ottiene l’incarico. Pubblica una lusinghiera recensione alla nuova fatica di Tullio al quale, con una lettera del 15 gennaio 1935, su carta intestata della rivista, chiede di inviare in regalo una copia de L’anguria lirica a Luigi Olivero. (1)
Il 20 marzo Olivero, che ha ricevuto l’omaggio, così si rivolge a Tullio con una sua lettera:
…ho ricevuto tutto: la stupenda “Anguria” in lito-latta che conservo, come una preziosa rarità editoriale, sul mio scrittoio…
Sempre a proposito dell’Anguria così aveva scritto a Tullio in una precedente del 22 gennaio:
Noi ci siamo conosciuti sulla pista aerea della FIAT il giorno della manifestazione futurista in onore di S. E. Marinetti.
Ma le 5 fette rosso-fuoco dell’ANGURIA LIRICA mi pervengono sul binario luce della poesia comunicando ai miei nervi 5 scosse della sensibilità elettrica che irradia dall’anima del POETA CAMPIONE DI TORINO.
Ancora un aneddoto riguardante Olivero, Marinetti ed il poeta Corrado Govoni (Frazione Tàmara di Copparo FE 1884 – Lido dei Pini Anzio 1965).
Nota l'amicizia di Olivero con Marinetti, altrettanto quella di Marinetti con Govoni, anche quest’ultimo seguace, per alcuni anni, della corrente futurista.
Olivero racconta che, dopo la morte di Marinetti del 2 dicembre 1944, nei primi giorni del gennaio 1946, passeggiando per Roma, in Via del Babuino, entra in una libreria d’occasioni. Qui, uno scaffale polveroso, sopra sette volumi pubblicati da Marinetti, tutti con dedica autografa, più che affettuosa, a Corrado Govoni.
Una delle dediche recita Al grande poeta Corrado Govoni, alla Meravigliosa Primavera della Sua anima. Con affetto. F. T. Marinetti.
La parola ad Olivero:
Noi avoma gnun-e intension ëd fé belessì né l’apologia né la stroncatura ‘d F. T. Marinetti. Soma nen ëd fassios e soma nen ëd critich. Ma an fa dëspiasì – un dëspiasì ch’a confin-a con lë scheur – constaté coma ant l’ànima d’un poeta – ch’a duvrìa esse l’ànima pi sensibila e nòbila ‘d tute le ànime – a peussa formasse tanta cràcia ‘d vigliaccheria da feje arneghé la memoria d’un amis mòrt doe vòlte – fisicament e leterariament – con un gest così trivial come col ëd vende da cartassa inùtil ij so ùltim lìber sensa gnanca avej ël rigoard elementar dë s-ciancheje ‘l prim feuj dova col amis a l’ha pogià la man për ë-scrive la pi sincera, forse, dle soe diciarassion d’amicissia: coma l’è squasi sempre la diciarassion che në scritor a peul ofrije a un cambrada an letteratura quand a compagna, con le pòche paròle scrite an front d’un sò lìber, la sostansa viva dël sò pensé convertìa an carta stampà.
Savoma tuti – e tanti ‘d noi a l’han provà – ij sacrifissi ‘d costi ultimi ani che sovens a l’han obligane a vende le nostre còse pi care për compresse ‘d pan.
Savoma tuti che F. T. Marinetti a l’era fassista, an fasìa ciamé Caffeina d’Europa, a l’avìa definì la guèra sola igiene del mondo, a l’avìa ant chiel una bon-a dòse ‘d ciarlataneria mës-cià con una bon-a dòse d’ingegn auténtich mal impiegà; e ades a l’è, a rason ò a tòrt, universalment dëspresià.
Ma ij difet ëd l’òm e le soe tare politiche, ch’a esistjto già quand ch’a l’era an vita e donca a pudijo esse considerà fin d’antlora da j’amis che ancheuj a lo arnego, a peulo nen e a devo nen giustifiché un gest come col ch’a l’ha fàit Corrado Govoni ades che l’òm a l’è mòrt e, come l’oma già dit, anche leterariament sotorà. Un gest ëd bassa vigliacherìa, ripetoma, paragonàbil al gest ëd cola bestia african-a ch’a pissa an sël cadàver ëd l’òm che na minuta prima a l’era ancora sò padron e ch’a la carëssava tratandla da amija. …
Però… Però la nostra cita aventura libraria a l’è ancora nen finija e ‘l séguit, se an fà rije ‘d cheur, an fà ‘d cò pensé ch’ai sia un destin che sèrte vòlte as divert a vendiché ij mòrt dj’afront ch’ai fan ij viv.
Ancheuj, passand ant una strairòla ‘d Tor di Nona pien-a dë strassé, dë marsé e ‘d feramiù, l’oma vist për tèra, tra na savata rota e un portacandèile armis, un lìber oit e s-cianchërlà ‘d Corrado Govoni: Poesie scelte (1903-1918) / edission Taddei e figli Ferrara. Soma chinasse a sfojatelo, sensa dësfilesse ij goant da le man. La prima pagina a l’era soagnà d’una bela dédica autografa dl’autor a una creatura che chiel a batesava «mia divina ispiratrice».
Una «divina ispiratrice» - viva la soa fàcia ‘d tòla, giuradisna! – ch’a l’ha campà ‘nt la pàuta le poesìe ‘d col poeta che, dëspresiand l’amicissia, a l’è meritasse, a soa vòlta, ‘d vëdse dëspresià, forse, l’amor…
L’oma comprà col lìber ëd Govoni. Soma andài a compré, sùbit dòp, coi sèt lìber ëd Marinetti. E i guernoma tuti eut come un-a dle documentassion pi singolar dla fondamental saloparìa dl’ànima uman-a 1946.
E veniamo all'opera futuristica di Olivero. Nell’autunno del 1950 vince a Parigi, su 65 partecipanti, il Prix de la Chimère di poesia dedicata all’aviazione nell’ambito dell’Esposizione Aerea Internazionale con L’Aereopoema dl’Élica Piemontèisa, che gli vale un premio di 500 mila franchi.
La motivazione del premio è la seguente: La più alta espressione della poesia dei cieli animata dalle ali degli uomini.
L’anonimo estensore sulla rivista Ij Brandé N° 100 del 1 novembre 1950 (Pinin Pacòt?) commenta:
Le pòche paròle ‘d costa notissia a basto nen a dì còsa ch’a sìa sto cit poemèt, sospeis ant un miraco ‘d color e ‘d nuanse a specié dal cel ëd Piemont la reveusa nostalgìa dij paisagi nostran. Ij pòchi ch’a l’han lesulo a lo san, e noi i speroma ‘d vëddlo prest publicà.
Ant costa bela afermassion noi vëdoma un pòch lë specc ëd soa vita d’om e ‘d poeta, con col andi dësgagià e ardì ch’a lo caraterisa, sempre pront a serché l’aventura për cheujne la sostansa lìrica da fonde ant la blëssa dij sò vers. A l’é për costa soa gioventura sempre viva che noi i l’auguroma che, a dispet ëd col sò sfògh epigramàtich, d’autre bele vitòrie a ven-o a conforté soa fatiga e sò ingegn ëd poeta.
Nel 1941 Chionio, recensore letterario dell’Armanach Piemontèis ne annunciava la prossima pubblicazione definendo l’opera:
L’acid tartarich ch’à fa mossè il mòst savurì ëd cost volum bizar…
Guido Mattioli, scrittore, aviatore e direttore della rivista L’aviazione nel numero di gennaio del 1945 a proposito de L’Aereopoema scrive:
Una prova della gagliarda rinascita del Piemonte, la fornisce nel campo spirituale Luigi Olivero con un’opera di poesia, nuova per la concezione e per la forma, che s’impone all’attenzione non solamente piemontese, ma italiana.
Olivero ci racconta che il volume fu stampato dalla casa editrice La Sorgente di Milano e che, pronto per la distribuzione, fu incenerito dalla prima all’ultima delle sue 3.000 copie dal bombardamento su Milano della R.A.F. nella notte tra il 15 ed il 16 febbraio del 1943.
Nel Fondo Olivero di Villastellone ho rintracciato recentemente copia dattiloscritta dallo stesso Olivero de L'aereopoema con molte correzioni e varianti.
Per vedere l’opera stampata bisognerà attendere il 1993 quando Camillo Brero la pubblica a puntate sul suo Piemontèis ancheuj.
La neuva rassa, nella versione dattiloscritta di Olivero, unisce due poesie che in Brero compaiono separate: La neuva rassa e La cilesta anarchia. In questa seconda, Brero, probabilmente, a causa della sua formazione seminaristica, elimina sei versi sostituiti, senza alcuna spiegazione, da una linea punteggiata. Ecco, come conclusione sui rapporti tra Olivero ed il Futurismo, la versione completa della poesia mutilata da Brero: (3)
LA NEUVA RASSA
L'é temp che al mond ai nassa
na neuva rassa
volanta e marinara
ch'ampara
a traversé
dë sfrandon le frontiere;
a scarpisé
le bòje panatere
"passatiste" nostran-e e strangere;
a scracé
su la stòria,
sla bòria,
sle làpide "an memòria",
sul present,
sul passà,
sui monument
vespasian dij colomb dla sità.
L'é temp che al mond ai ven-a
na neuva umanità
con la front ciaira e seren-a,
con un neuv sentiment,
j'euj sincer e rijent,
sensa sòld, sensa cà,
sensa seugn, sensa vissi,
sensa gnun pregiudissi,
ma con na gran richëssa
- la salute e la blëssa -
ma con un gran tesòr
andrinta 'l cheur sarà:
la bontà!
la bontà!
la bontà!
E basta con
le religion,
ij partì,
le nassion,
ij polmon
apassì
'd Mimì,
le filosofìe,
le enciclopedìe,
le crìtiche
stìtiche
e le politiche
sifilìtiche,
ij messaj,
ij giornaj
sbërlacià dai papagaj
con j'ociaj
ch'a meujo 'l bech andrinta ij caramaj!
Basta coi baco 'd minìstr
ch'a l'han fàit un pampist
dël vèrb ëd Gesù Crist!
E basta con la siensa
e con la volontà 'd potensa!
Basta con la moral
ëd Nietzsche
e ‘d Pascal! (Qui si conclude la versione pubblicata da Brero)
(Tra doe cheusse patice
j’è la pi bella moral
e a la scriv la natura
sul messal
rilegà
an pel uman-a reusa e profumà).
Basta con l'impostura (Qui riprende la versione Brero)
e la malinconìa
dla literatura
veiassa plufrìa...
E un po' pi 'd poesìa
e un po' pi 'd poesìa
e un po' pi 'd poesìa
vera, fòrta, sentija (verso aggiunto a mano)
ant ògni creatura!
L'é temp che al mond ai nassa
na neuva rassa
violenta e degordìa
ch'a raspa e a pòrta via
tuta quanta la drùgia
dij sécoj: ch'a fiàira e a s'amugia
an sla tèra
për anfleje la rogna dla siensa e la pest ëd la guera:
la pest ëd la guera
la pest ed la guera
a la fàcia dla tèra!
(1) Quaderni di Tullio d’Albisola Vol. II (Lettere di Italo Lorio) Editrice Liguria 1981
Il primo esempio italiano di Libro di Latta è stato ideato ed illustrato proprio da Tullio d’Albisola. Trattasi di Parole in libertà futuriste tattili termiche olfattive di Filippo Tommaso Marinetti pubblicato a Savona il 4 novembre 1932. Comprende 15 fogli litografati con composizioni coloristiche di Tullio d’Albisola.Tirato in 101 copie dalla Litolatta di Savona di V. Nosenzo.
Anguria lirica di Tullio d’Albisola è stato tirato dalla stessa ditta in 200 copie a Savona nel 1933.
I brani delle lettere di Olivero riportati, sono tratti dall’Archivio “Tullio d’Albisola” di Vittoria ed Esa Mazzotti. In detto archivio sono conservate due lettere ed una cartolina di Olivero a Tullio. Le due lettere su carta intestata de le grandi firme, l’altro scritto su cartolina editoriale de "i vivi", rivista quindicinale d’attualità diretta da Pitigrilli.
(2) Luigi OliveroProponiment dël Tòr “Cigno gentil” con ànima ‘d porsel Ël Tòr N° 12 1946
(3) Luigi Olivero Aereopoema dl’élica piemontèisa Piemontèis ancheuj N° 132 dicembre 1993 – N° 144 gennaio 1995 Torino.
*******
Rivista Marittimepubblicata a Borgo San Dalmazzo CN
N° 43 aprile 2012 pagg. 37 ~ 42
Un poeta borgarino
Calisto Ghibaudo
Calisto Ghibaudo nasce ad Antibes (Costa Azzurra, Francia) nel 1920. Giovanissimo si trasferisce a Borgo San Dalmazzo. Lungo periodo di naja come tenente del 5°, poi del 2° ed infine del 4° Reggimento degli Alpini. Ricordi di guerra che sfoceranno poi nel suo secondo libro di poesia Noi soma Alpin del 1955.

Calisto Ghibaudo (Per gentile concessione archivio famigliare Ghibaudo)
Il suo primo approccio con la poesia è però precedente. Nel bel dialetto di Borgo compone Dal Monserà ai Camorei, una scelta di poesie riguardanti Borgo San Dalmazzo, che pubblica nel 1952 presso l'Istituto Tipografico Bertello di Borgo.
È l'estate del 1954. Sale sotto il santuario del Montserrat, con il piccolo figlio Marco, ad incontrare l'amico poeta Luigi Olivero, cui appunto ha trovato casa, qualche anno prima, alla morte della di lui madre, in una villetta proprio sotto il santuario, villetta che Olivero chiama affettuosamente la sua bicocca. Qui lunghe discussioni ed anche belle passeggiate. Così l'Olivero descrive questi incontri nella lettera che invia a Calisto e che questi utilizzerà quale prefazione al suo nuovo libro di poesie dedicando ad Olivero un intero capitolo:
…e io ti ricambio inadeguatamente offrendoti il sonetto che precede questa letterina e che non è nemmeno tra le mie cose più efficaci. Abbi pazienza. Ognuno dà ciò che ha. Il nostro gesto equivale alla stretta di mano tra poeti: la tua più calorosa, la mia forse meno intensa ma ugualmente cordiale… Olivero preconizza poi l’intervento di qualche super-psicòlogo che definirà lo scambio una concertata puerilità reclamistica richiamando la definizione data dei poeti da Ernesto Renan con l’arguto verso:
«Ce sont des enfants qui se sucent le pouce».
Pollice, indice, medio – chiosa Olivero – anulare o mignolo, in ogni caso le dita sono nostre e ce le succhiamo individualmente o intrecciamo reciprocamente come ci pare.
Olivero prosegue poi ricordando gli inizi in patois della poesia di Ghibaudo e del suo consiglio di addivenire al dialetto …è proprio qui, sul terrazzino di questo mio èremo solitario, dirimpetto alla schiena loricata d’oro della Bisalta, che abbiamo discusso insieme di questi effimeri ma per noi interessanti problemi di strategia letteraria: e che tu hai accolto il mio modesto suggerimento di lasciare il patois per dedicarti al dialetto il quale, a suo modo, è già un idioma: in quanto è codificato da secoli nella sua struttura filologica ed è comprensibile ad un maggior numero di creature che, se non sempre lo scrivono o leggono, lo parlano sin dall’infanzia…
Quindi il ricordo della genesi dell’opera di Ghibaudo …lo avvertii e te lo dissi improvvisamente durante una delle nostre quasi quotidiane «scarpinate» su per i verdi castagneti che popolano, in duplice declivio, le balze a groppa di caimàno sovrastanti il Santuario della Madonna del Montserrat, un giorno in cui mi narravi, liricamente infervorato, le vicende di pace e di guerra che hanno costellato la tua santa naja di Tenente dei 5°, 2°, 4° Reggimenti degli Alpini…Chi ci vide su quella cresta rocciosa, contro lo sfondo del cielo azzurrino - io in tuta olimpionica blu e tu scamiciato, entrambi arruffati e gesticolanti -, poté credere a due pazzi colpiti da insolazione che impegnassero una pericolosa partita di pugilato sull’orlo dell’abisso. Invece, nò. Disegnavamo semplicemente nell’aria l’architettura del piccolo breviario in rima degli Alpini che tu poi hai felicemente costruito: ma facendo di meglio, conferendogli quasi i lineamenti di un’agiografia profana del Santo Alpino: l’Alpino che, infatti, tu scrivi sempre con l’iniziale maiuscola.
Noi soma Alpin! è pubblicato ancora dall'Istituto Tipografico Bertello di Borgo il 31 marzo del 1955. Come consigliato da Olivero, qui la grafia è quella unificata cosiddetta Pacòt-Viglongo. Calisto dedica ad Olivero la sezione del libro dal titolo Dòp-guèra con queste parole:
A LUIGI OLIVERO
Maestro ‘d mas-cia poesìa piemontèisa
ch’a l’ha piantame an man
la Piuma Nèira ‘d mè Capel d’Alpin
e che l’ha dime:
«Nompà ‘d ciaramlé tant
për conteme ij tò ricord ëd naja
scrivije».
E mi, bin ò mal, l’hai scrivuje.
Nella lettera inviata a Calisto, Olivero si scusa della poesia L’Alpin che ritiene poca cosa.
Recentemente, grazie al Signor Silvio Bonino, collezionista di Margarita di Cuneo, sono entrato in possesso della copia di un cartoncino fatto stampare appositamente da Olivero, di cui, purtroppo, non conosco la destinazione. Contiene due poesie di Olivero.
La prima, Paròle an sla pera, era destinata alla raccolta Pomin d'amor che mai vedrà la luce. Olivero riprenderà la poesia, modificandola ed ampliandola notevolmente e la pubblicherà nella sua raccolta Rondò dle masche del 1971 con il nuovo titolo «Stabat Mater» an sla tomba dl'ùltim partisan alpin mòrt ant la Guèra 'd Liberassion.
La seconda è L'Alpin. Versione però alquanto differente da quella anteposta alla sua raccolta da Calisto. Quest'ultima infatti è ad personam, quella dal cartoncino dedicata agli Alpini in generale. Completa l'elegante cartoncino una bella immagine, virata in seppia, di un giovane Alpino. Non ho potuto accertarlo, potrebbe però trattarsi proprio di Calisto.
Olivero ricorderà ancora Calisto e la sua nuova opera in una rubrica fissa Lettere romane che scriveva per il mensile della Famija Turinèisa 'l caval 'd brôns. Nel numero 6, del giugno 1955, per il pubblico piemontese Olivero traccia queste note:
Il libro è una rivelazione portata qui dai partecipanti, subalpini romanizzati, al recente Convegno degli Alpini a Trieste. È tutto scritto in assai comunicativi versi piemontesi e illustrato, meglio che da Salvator Dalì, da quel Beato Angelico del pennello fatto con i fili di paglia d’un fiasco di barbera che è il pittore di Chiasso, ma da vent’anni residente a Roma, Gabriele Cena. Questa ingenua eppure calda rapsodia del canto Alpino, che mancava alla nostra poesia dialettale, ha trovato a Roma un’accoglienza entusiastica. Poi - curiosa, eh! – se n’è arrivata alla Capitale da Cuneo passando per Trieste. Dove pare che l’autore minacciasse di dar fuoco con l’accendisigari alle penne nere degli ex commilitoni se non gliela compravano. Ad ogni modo Noi soma Alpin! sprizza faville dalle vetrine romane. Lo acquistano anche i quiriti, sicuri che si tratti di un vademecum del perfetto alpinista dilettante, per consultarlo nelle loro ardite escursioni estive al Terminillo, a Monte Cavo e a Montecòmpatri. E il giovane ex tenente delle Penne Nere Calisto Ghibaudo da Borgo San Dalmazzo deliba il suo dolce quarto d’ora incartato di celebrità romana: scommetto a cavalcioni - qui dicono a cavacecio - di una montagna di diritti d’autore spuntatagli inaspettatamente sotto le scarpe chiodate, fra la sua Besimauda e il suo Monserrato.
Il figlio del poeta borgarino, Marco, ricorda che il padre, quando lui era piccolo, lo portava a trovare Olivero nella sua casa del Montserrat e qui assisteva a lunghe chiacchierate, davanti ad una buona bottiglia di vino, chiacchierate che spesso sfociavano in accese discussioni. Quando Olivero si infervorava, Marco ricorda che, con la canna (il bastone) che aveva sempre con se, picchiava ripetuti colpi sul tavolo a dare maggiore enfasi alle sue asserzioni. Furono sempre amici, Calisto e Luigi. Una delle poche persone con cui, nonostante le discussioni, non ci furono mai momenti di separazione netta.
Laureato in lettere, il 2 marzo del 1954, nel giorno del suo trentaquattresimo compleanno, dall'Ufficio del Lavoro di Cuneo, dove presta opera in qualità di Funzionario, viene trasferito a dirigere l’Ufficio di Collocamento di Fossano. Questa data segnerà una svolta nella vita di Calisto, la sua «Vita nova» come la definirà il suo caro amico Professor Beppe Manfredi, all'epoca Sindaco di Fossano. Qui conoscerà infatti, in seguito ad una manifestazione teatrale organizzata nella casa di pena, un carcerato, Leandro Balestra, organizzatore dello spettacolo, condannato a 24 anni per omicidio, che si professa però innocente. Il Leandro si manifesta poeta. Tra i due ci sarà un lungo scambio di poesie che durerà fino al ritorno a Cuneo del Ghibaudo l’anno seguente. Il tutto porterà Calisto, qui famigliarmente chiamato Kaly, 35 anni dopo, a pubblicare, derivandone il titolo dal nome del carcere, il suo Santa Catlin-a, opera di non molte pagine, una trentina, parte in prosa, parte in poesia, ricca di sentimento e di un sogno: fare del carcere un luogo di speranza.
Fare del carcere un luogo di speranza... Che sogni! E perché quei sogni degli anni '50 non andassero perduti nell'oblio implacabile dello scorrer del tempo, Ghibaudo ci ha dato in questa sua «Santa Catlin-a» la sua «Vita Nova» giovanile. Così si legge nella bella prefazione di Beppe Manfredi.
Da Santa Catlin-a, pubblicazione non facilmente rintracciabile, estraggo la dedica, una poesia di Kaly a Balestra e l'ultima che Leandro gli invia.
A MARIA
che un felice destino
mi ha affiancato
quale compagna della mia vita,
fulgido esempio d'amore
e di affettuosa e cordiale dedizione
che mi ha sempre insegnato
ad amare la vita,
a credere nella vita,
a soffrire per la vita,
queste pagine che ricordano
le pene dolorose e tormentose
di un infelice ergastolano,
autentico e valido poeta sublimato dal dolore,
con cordiale ed amorevole affetto
DEDICO.
La rondine
Nella casa di Santa Caterina
un infelice veglia e non riposa,
con nostalgia pensa a sua sposa,
sospira un bacio d'una piccolina.
Cuore di padre che vibra d'amore,
che piange nel silenzio della sera
e disperatamente una preghiera
invoca per lenir suo dolore.
Torna domani Santa Benedetta:
il compleanno di sua Graziella...
Potersi tramutar in rondinella,
poter volare verso chi l'aspetta...
Raggiungere così sua nidiata
con una seta dai ricami d'oro
stringere tra le braccia quel tesoro,
e... ritornare poi nella serata
al luogo di sventura e di dolore
tra le pareti fredde della cella
con un bel bacio suo di Graziella,
un bacio solo che rallegra il cuore.
Inutilmente arriva il compleanno
che la bimbetta non festeggerà;
per festeggiarlo vuol suo papà,
e lo rimanda ancora d'un altr'anno.
E l'infelice nel cuore dispera
quando vede una rondine alla grata;
l'osserva... Poi con ansia disperata
a fior di labbra dice una preghiera
e l'accarezza come una bambina,
dolcemente. La rondine ha capito,
risponde generosa a quell'invito
e... frrr... frrr... lascia Santa Caterina;
e volando garrisce con ardore
portando seco nella notte oscura
l'augurio d'un papà nella sventura
un bacio profumato tutto amore.
È giunta ormai la cara rondinella.
Lieve col becco batte alla vetrata,
una finestra s'apre alla chiamata
cip cip... cip cip..., sorride la Graziella.
Nella casa di Santa Caterina
un infelice dorme e si riposa:
gli appar nel sonno il volto della sposa
nel sogno l'accarezza una bambina.
Calisto Ghibaudo
La mia pena è un fiore
Libera rondinella,
che tra le grate in pianto arrugginite,
lieta ti scorgo nell'azzurro in volo,
fermati un poco qui a Santa Catlin-a
e fatti a me vicina; non temere:
son buono come te, che se sovrana
nel ciel, sul mare e sulla terra in fiore,
che in mille giri vai così lontana,
con compagne di volo;
fermati un poco, ascolta la mia voce:
porto una grossa croce,
acuta spina a me trafigge il core!
Sono innocente e indarno
ho protestato in pianto, o rondinella;
gli uomini, tu sapessi, quanti errori
senza voler, van commettendo ognora;
e c'è chi piange e implora nel suo duolo,
piange, ma spera, ché nel Cielo crede;
errar non può Colui, che è onnisciente.
Quanti anni di dolor! Solo la Fede,
che ha posto in core mamma
l'anima sorregge in loco infido;
ma pur credendo grido,
o rondinella a te: sono innocente!
Sul viale un uomo ucciso:
è un soldato! E la Giustizia indaga...
Ma chi l'uccise?... Passano dei mesi...
E infine arrestan me; nessun m'accusa
ed al processo chiusa io mi vedo
di libertà la porta: condannato!
Ventiquattro anni... E babbo che ben sente
l'ingiusto verbo al figlio pronunciato,
al duol non regge e muore;
e penso alla mia mamma...
O rondinella, sai: «Sono innocente!».
«Humanum est errare»...
Se la condanna è ingiusta al Cielo guardo;
un candelabro ardente è la mia pena,
di luce che non muta il suo brillare
innanzi ad un Altare, ed è una fiamma
viva su d'un avello in Cimitero,
fra tante croci e lampade d'amore:
il mio dolore è simbolo del cero
su quella tomba amata,
in cui c'è il palpitar d'un cuore ardente
pel figlio ch'è innocente...
Su quella tomba la mia pena è un fiore!
Leandro Balestra
Quasi in contemporanea l'ultima raccolta poetica di Calisto Ghibaudo, ancora una volta dedicata al suo Borgo San Dalmazzo: Gent dël Borgh del 1988. Poco ancora e Calisto, che ora abita a Boves, ci lascia, è il 1992.
Nel settembre del 2007, a Borgo, mi sono recato a trovare il figlio di Calisto, Marco. Mi ha accolto con tanta gentilezza raccontandomi dell'amicizia del padre con Olivero, l'altro poeta di cui, da anni, mi occupo. Ci siamo lasciati con la promessa di ritrovarci per continuare un dialogo. Stretto nella mano portavo con me Santa Catlin-a, dono prezioso che mi ha consegnato Marco prima che ci lasciassimo. Pochi mesi passano e mi giunge notizia della sua morte prematura.
Ciao Calisto... Ciao Marco...

Calisto Ghibaudo (Archivio famigliare Ghibaudo)
Bibliografia:
Dal Monserà ai Camorei (Scelta di poesie piemontesi riguardanti Borgo San Dalmazzo nel dialetto borgarino). Istituto Grafico Bertello, Borgo San Dalmazzo, 1952.
Noi soma Alpin (Scelta di poesie piemontesi riguardanti gli Alpini in guerra). Istituto Grafico Bertello, Borgo San Dalmazzo, 30 marzo 1955. Gent dël Borgh (Poesie piemontesi su Borgo San Dalmazzo). Amministrazione Comunale Borgo San Dalmazzo, 1988.
Santa Catlin-a (Dialogo rimato tra due poeti: uno libero l’altro carcerato). Edizioni Gianfranco Martini, Borgo San Dalmazzo, 5 dicembre 1989.
Nota: alcuni brani sono tratti dal mio pezzo Luigi Armando Olivero poeta al Montserrat di Borgo San Dalmazzo pubblicato su questa stessa rivista Marittime N° 34 dell'aprile 2009.
Piemontèas ancheuj Anno XXX N° 11 - novembre 2012
Luigi Armando Olivero ed il «Futurismo»
A cor ël 1933 quand che Olivero a l’é al Ristorant dël Cambi a Turin an companìa ’d Filippo Tommaso Marinetti, an pien-a polemica contra la pastassùita. Pastassùita che Marinetti a considera un piatto passatista, pesante allo stomaco, assolutamente controindicato al superdinamismo della generazione futurista.
An pien-a osservansa con ij sò prinsipi, col di, al Cambi, con Olivero, Marinetti as divora un autentico Vesuvio di fumante pastasciutta.
Da cost, e da d’àutri ancontr con Marinetti, a pijerà l’andi la composission dël futurìstich, ant l’ideassion poetica e ’nt la composission gràfica, Aereopoema dl’elica piemontèis che lë stess Marinetti a definirà coma vibrant ëd audacissima aeropoesìa, ùnica in tutti i dialetti del mondo, ëd la qual i na parleroma fra pòch.
An Albisòla, la sitadin-a dla siràmica d’art, Tullio Mazzotti, fieul dël fondator ëd le «Ceramiche Mazzotti», ancora ancheuj ative, che as farà ciamé Tullio d’Albisòla, a ancamin-a un rapòrt ës-ciass con ij Futurista e a strenz amicissia con Munari, Marinetti, Fontana e tanti d’àutri ch’a frequento sò atelier. Le litre ch’a jë scrivran ant j’ani ij tanti amis futurista, a saran peui cujùe e publicà an bin quatr volum.
Dzorpì che a la siràmica, ëd la qual a dventa un magìster, as dedica ’dcò a la poesìa e a compon «L’anguria lirica», un longh poema passional ch’a
vnirà publicà, coma scond esempi ’d col sistema, stampà su feuj ëd tòla. A l’é anlustrà da Munari e Diulgheroff con la prefassion ëd Marinetti. L’impression a l’é dla «Lito-latta Nosenzo» ëd Savon-a për j’Edission futuriste ’d «Poesia» ëd Roma.
Un giovo student d’architetura, Italo Lorio, autor ëd conte e dë stòrie (Fumo negli occhi Montes Torino 1934, Tempo di marcia Montes Torino 1935), a l’é amis e colaborator ëd Tullio d’Albisòla. A ciama diverse vire ’d podèj colaboré a «le grandi firme» ëd le quaj, a col moment, Olivero a l’é redator cap e diretor, an assensa ’d Dino Segre (Pitigrilli) ch’a l’é fòra d’Italia për motiv polìtich.
Dòp ëd n’insistensa arpetùa, Lorio a oten l’incàrich. A pùblica na recension soagnà dla neuva fatiga ’d Tullio al qual, con na litra dij 15 gené dël 1935, sla carta antëstà dl’arvista, a ciama ’d mandé a Luigi Olivero, coma cadò, na còpia dl’«Anguria lirica»1.
Ai 20 ëd mars Olivero, ch’a l’ha arseivù l’omagi, parèj as rivòlgg a Tullio con na soa litra:
«…ho ricevuto tutto: la stupenda “Anguria” in lito-latta che conservo, come una preziosa rarità editoriale, sul mio scrittoio…»
Sèmper a propòsit ëd l’«Anguria» parèj a l’avìa scrivù a Tullio ’nt na soa litra dij 22 ëd gené:
«Noi ci siamo conosciuti sulla pista aerea della FIAT il giorno della manifestazione futurista in onore di S. E. Marinetti.
Ma le 5 fette rosso-fuoco dell’ANGURIA LIRICA mi pervengono sul binario luce della poesia comunicando ai miei nervi 5 scosse della sensibilità elettrica che irradia dall’anima del POETA CAMPIONE DI TORINO».
Ancora n’anecdòt rësguardant Olivero, Marinetti e ’l poeta Corrado Govoni(Frazione Tàmara di Copparo FE 1884 – Lido dei Pini Anzio 1965).
Conossùa l’amicissia fra Olivero e Marinetti, autërtant cola ’d Marinetti con Govoni, ëdcò cost ùltim un dissépol, për quàich ani, ëd la corent futurista.
Olivero a conta che, dòp ëd la mòrt ëd Marinetti dël 2 dë dzèmber 1944, ant ij prim di ’d gené dël 1946, spassëggiand për Roma, an contrà dël Babuin, a intra ’nt na librerìa dj’ocasion. Ambelessì, na stagera pien-a ’d póer, e dzora set volum publicà da Marinetti, tuti con la dédica ’d soa man, pì che grinosa, a Corrado Govoni.
Un-a dle dédiche a dis parèj: «Al grande poeta Corrado Govoni, alla Meravigliosa Primavera della Sua anima. Con affetto. F. T. Marinetti».
La paròla a Olivero:
«Noi avoma gnun-e intension ëd fé belessì né l’apologia né la stroncatura ’d F. T. Marinetti. Soma nen ëd fassios e soma nen ëd critich. Ma an fa dëspiasì – un dëspiasì ch’a confin-a con lë scheur – constaté coma ant l’ànima d’un poeta – ch’a duvrìa esse l’ànima pi sensibila e nòbila ’d tute le ànime – a peussa formasse tanta cràcia ’d vigliaccheria da feje arneghé la memoria d’un amis mòrt doe vòlte – fisicament e leterariament – con un gest così trivial come col ëd vende da cartassa inùtil ij so ùltim lìber sensa gnanca avej ël rigoard elementar dë s-ciancheje ’l prim feuj dova col amis a l’ha pogià la man për ë-scrive la pi sincera, forse, dle soe diciarassion d’amicissia: coma l’è squasi sempre la diciarassion che në scritor a peul ofrije a un cambrada an letteratura quand a compagna, con le pòche paròle scrite an front d’un sò lìber, la sostansa viva dël sò pensé convertìa an carta stampà.
Savoma tuti – e tanti ’d noi a l’han provà – ij sacrifissi ’d costi ultimi ani che sovens a l’han obligane a vende le nostre còse pi care për compresse ’d pan.
Savoma tuti che F. T. Marinetti a l’era fassista, an fasìa ciamé Caffeina d’Europa, a l’avìa definì la guèra sola igiene del mondo, a l’avìa ant chiel una bon-a dòse ’d ciarlataneria mës-cià con una bon-a dòse d’ingegn auténtich mal impiegà; e ades a l’è, a rason ò a tòrt, universalment dëspresià.
Ma ij difet ëd l’òm e le soe tare politiche, ch’a esistjo già quand ch’a l’era an vita e donca a pudijo esse considerà fin d’antlora da j’amis che ancheuj a lo arnego, a peulo nen e a devo nen giustifiché un gest come col ch’a l’ha fàit Corrado Govoni ades che l’òm a l’è mòrt e, come l’oma già dit, anche leterariament sotorà. Un gest ëd bassa vigliacherìa, ripetoma, paragonàbil al gest ëd cola bestia african-a ch’a pissa an sël cadàver ëd l’òm che na minuta prima a l’era ancora sò padron e ch’a la carëssava tratandla da amija. …
Però… Però la nostra cita aventura libraria a l’è ancora nen finija e ’l séguit, se an fà rije ’d cheur, an fà ’d cò pensé ch’ai sia un destin che sèrte vòlte as divert a vendiché ij mòrt dj’afront ch’ai fan ij viv.
Ancheuj, passand ant una strairòla ’d Tor di Nona pien-a dë strassé, dë marsé e ’d feramiù, l’oma vist për tèra, tra na savata rota e un portacandèile armis, un lìber oit e s-cianchërlà ’d Corrado Govoni: Poesie scelte (1903-1918) / edission Taddei e figli Ferrara. Soma chinasse a sfojatelo, sensa dësfilesse ij goant da le man. La prima pagina a l’era soagnà d’una bela dédica autografa dl’autor a una creatura che chiel a batesava «mia divina ispiratrice».
Una «divina ispiratrice» - viva la soa fàcia ’d tòla, giuradisna! – ch’a l’ha campà ’nt la pàuta le poesìe ’d col poeta che, dëspresiand l’amicissia, a l’è meritasse, a soa vòlta, ’d vëdse dëspresià, forse, l’amor…
L’oma comprà col lìber ëd Govoni. Soma andài a compré, sùbit dòp, coi sèt lìber ëd Marinetti. E i guernoma tuti eut come un-a dle documentassion pi singolar dla fondamental saloparìa dl’ànima uman-a 1946». (2)
E i vnoma donca a l’euvra futuristica d’Olivero. Ant l’otogn dël 1950 a vagna a Paris, su 65 partessipant, ël «Prix de la Chimère» ëd poesìa dedicà a l’aviassion ant l’àmbit ëd l’Esposission Aerea Antërnassional con «L’Aereopoema dl’Élica Piemontèisa», ch’a-j pòrta un premi ’d 500 mila franch.
La motivassion dël premi a l’é costa-sì:
«La più alta espressione della poesia dei cieli animata dalle ali degli uomini».
L’anònim scritor an sl’arvista «Ij Brandé» N° 100 dël 1 novèmber 1950 (Pinin Pacòt?) a comenta parèj:
«Le pòche paròle ’d costa notissia a basto nen a dì còsa ch’a sìa sto cit poemèt, sospeis ant un miraco ’d color e ’d nuanse a specié dal cel ëd Piemont la reveusa nostalgìa dij paisagi nostran. Ij pòchi ch’a l’han lesulo a lo san, e noi i speroma ’d vëddlo prest publicà.
Ant costa bela afermassion noi vëdoma un pòch lë specc ëd soa vita d’om e ’d poeta, con col andi dësgagià e ardì ch’a lo caraterisa, sempre pront a serché l’aventura për cheujne la sostansa lìrica da fonde ant la blëssa dij sò vers. A l’é për costa soa gioventura sempre viva che noi i l’auguroma che, a dispet ëd col sò sfògh epigramàtich, d’autre bele vitòrie a ven-o a conforté soa fatiga e sò ingegn ëd poeta».
Ant ël 1941 Chionio, recensor leterari dl’«Armanach Piemontèis» a dasìa l’anonsi ’d na publicassion avsin-a definiend parèj l’euvra:
«L’acid tartarich ch’à fa mossè il mòst savurì ëd cost volum bizar…»
Guido Mattioli, scritor, aviator e diretor ëd l’arvista «L’aviazione» ant ël nùmer ëd gené dël 1945 a propòsit ëd «Aeropoema» a scriv:
«Una prova della gagliarda rinascita del Piemonte, la fornisce nel campo spirituale Luigi Olivero con un’opera di poesia, nuova per la concezione e per la forma, che s’impone all’attenzione non solamente piemontese, ma italiana».
Olivero an conta che ’l volum a l’era stàit stampà da la ca editris La Sorgente ’d Milan e che, pront për la distribussion, a l’era stàit brusà, da la prima a l’ùltima dle soe 3.000 còpie, dal bombardament su Milan da part ëd la R.A.F. ant la neuit tra ’l 15 e ’l 16 fërvé dël 1943.
Ant ël «Fondo Olivero» ëd Vilastlon i l’hai artrovà da pòch na còpia scrita a màchina da Olivero midem ëd «L’aeropoema» con vàire coression e variant.
Për vëdde l’euvra stampà a ventrà speté ’l 1993 quand che Camillo Brero a lo publica a pontà sël sò «Piemontèis Ancheuj».
«La neuva rassa», ant la version ëscrita a màchina da Olivero, a gionta doe poesìe che ’nt la publicassion ëd Brero a son separà: «La neuva rassa» e «La cilesta anarchia». An costa sconda, Brero, miraco, a càusa ’d soa formassion rivà dal seminari o përchè ij temp a j’ero forse nen mur për dé a le stampe certi concet na frisa «gajard», a gava ses vers ch’a son sostituì, sensa gnun-a spiegassion, da na linia a puntin.
I smon-o ambelessì, coma conclusion dij rapòrt fra Olivero e ’l Futurism, la version integral e completa dle poesìe dont i l’hai dit anans3.
LA NEUVA RASSA
L’é temp che al mond ai nassa
na neuva rassa
volanta e marinara
ch’ampara
a traversé
dë sfrandon le frontiere;
a scarpisé
le bòje panatere
«passatiste» nostran-e e strangere;
a scracé
su la stòria,
sla bòria,
sle làpide «an memòria»,
sul present,
sul passà,
sui monument
vespasian dij colomb dla sità.
L’é temp che al mond ai ven-a
na neuva umanità
con la front ciaira e seren-a,
con un neuv sentiment,
j’euj sincer e rijent,
sensa sòld, sensa cà,
sensa seugn, sensa vissi,
sensa gnun pregiudissi,
ma con na gran richëssa
- la salute e la blëssa -
ma con un gran tesòr
andrinta ’l cheur sarà:
la bontà!
la bontà!
la bontà!
E basta con
le religion,
ij partì,
le nassion,
ij polmon
apassì
’d Mimì,
le filosofìe,
le enciclopedìe,
le crìtiche
stìtiche
e le politiche
sifilìtiche,
ij messaj,
ij giornaj
sbërlacià dai papagaj
con j’ociaj
ch’a meujo ’l bech andrinta ij caramaj!
Basta coi baco ’d minìstr
ch’a l’han fàit un pampist
dël vèrb ëd Gesù Crist!
E basta con la siensa
e con la volontà ’d potensa!
Basta con la moral
ëd Nietzsche
e ’d Pascal! (Sì a finiss la version publicà da Brero)
(Tra doe cheusse patice
j’è la pi bella moral
e a la scriv la natura
sul messal
rilegà
an pel uman-a reusa e profumà).
Basta con l'impostura (Sì a arpija la version Brero)
e la malinconìa
dla literatura
veiassa plufrìa...
E un po’ pi ’d poesìa
e un po’ pi ’d poesìa
e un po’ pi ’d poesìa
vera, fòrta, sentija (vers giuntà a man)
ant ògni creatura!
L’é temp che al mond ai nassa
na neuva rassa
violenta e degordìa
ch’a raspa e a pòrta via
tuta quanta la drùgia
dij sécoj: ch’a fiàira e a s’amugia
an sla tèra
për anfleje la rogna dla siensa e la pest ëd la guera:
la pest ëd la guera
la pest ed la guera
a la fàcia dla tèra!
N O T E
1) Quaderni di Tullio d’Albisola Vol. II (Lettere di Italo Lorio) Editrice Liguria 1981
Ël prim esempi italian ëd «Libro di Latta» a l’é stàit ideà e anlustrà pròpi da Tullio d’albisòla. As trata ’d «Parole in libertà futuriste tattili termiche olfattive» ëd Filippo Tommaso Marinetti pubblicà a Savon-a ai 4 ëd novèmber dël 1932. A comprend 15 feuj litografà con ëd composission colorìstiche ’d Tullio d’Albisòla. Tirà an 101 còpie da la «Litolatta» ëd Savon-a ’d V. Nosenzo.
«Anguria lirica» ëd Tullio d’Albisòla a l’é stàit tirà da la midema dita an 200 còpie a Savon-a ’nt ël 1933.
Ij tòch ëd la litre d’Olivero che sì a son arportà a ven-o da l’archivi «Tullio d’Albisola» di Vittoria ed Esa Mazzotti. An cost archivi a son guernà doe litre e na cartolin-a d’Olivero spedìe a Tullio. le doe litre su carta antëstà ’d «le grandi firme», l’àutr scrit su cartolin-a editorial ëd l’altro «i vivi», rivista quindicinale d’attualità diretta da Pitigrilli.
2) Luigi OliveroProponiment dël Tòr “Cigno gentil” con ànima ‘d porsel Ël Tòr N° 12 1946
3) Luigi Olivero Aereopoema dl’élica piemontèisa Piemontèis Ancheuj N° 132 dicembre 1993 – N° 144 gennaio 1995 Torino.
Ij Brandé Antologìa 'd poesìa e pròsa piemontèisa 2013
LUIGI ARMANDO OLIVERO SCRITOR ËD SAGG E ’D ROMANZ
Luigi Olivero, durant soa longa esistensa, a scriv un nùmer bondos ëd sagg e ’d romanz, la pì part coma ùnich autor, quaidun an colaborassion con d’àutri. Për ij motiv, ij pì divers, mach tre a vniran publicà.
Babilonia stellata a l’é sò prim sagg a vëdde la lus da l’editor Ceschina ’d Milan, ant ël 1941. An pòch temp a van esaurìe tre edission. Cola ch’a fà quatr, a la qual a colabora Ezra Pound (1), a l’é dël 1943. Sèmper con l’ausili d’Ezra Pound a l’avrìa dovù passé sota ai tòrcc ëd la stampa n’edission ch’a fasìa sinch, sòn tutun a l’era nen capità për l’avansé dj’aveniment gropà a la guèra. Babilonia stellata a l’ha avù ’dcò n’edission alman-a che, con la tradussion ëd Johan von Leers (2), a surtìa con l’editor Runge a Berlin ant ël 1944 con ël tìtol ëd Babylon unter Davidsternen und Zuchthausstreifen (Leteralment Babilonia sotto stelle di Davide e strisce di galera).
Babilonia stellata a l’ha na difusion motobin granda, belavans ch’a sia publicà an temp ëd guèra, e a vend senten-e ’d mijara ’d còpie.
Cost sagg a ven, ancora ancheuj, arciamà an senten-e ’d sit ëd l’aragnà (WEB); vàire ’d costi a l’han disponibilità, e a vendo, ëd còpie dël lìber; tanti d’àutri a na analiso, për diversi but, ij contenù. An particolar sò prim capìtol, I pups, a eufr l’angagg për arciamesse a lìber e sit ch’a s’anteresso a la crìtica dël cine. Për esempi, dël 1991 ël càpitol ëd Guido Fink All american boys, pijà da Hollywood in Europa a cura ’d David W. Ellwood e Piero Brunetta con l’edission ëd La Casa Usher. N’àutr sagg ch’a s’òcupa ’d Babilonia stellata a l’é publicà ’nt ël 2000 da Dario Reteuna, Cinema di carta – Storia fotografica del cinema italiano, Editriss Falsopiano.
Tutun a son doe j’euvre d’Olivero che ’d pì a ancontro ij favor ëd le popolassion ch’a parlo inglèis.
Ant ël 1945 a seurt, për ij caràter ëd l’Editor Donatello De Luigi ’d Roma, Turchia senza harem che a l’ha soa tradussion an inglèis, Turkey without Harems, a euvra dlë scritor Ivy Warren e a l’é publicà, con na vesta soagnà, da McDonald & Co ’d Londra ’nt ël 1952. Cost sagg, ancora motobin atual al di d’ancheuj, a pija l’andi dai longh sogiorn d’Olivero an Turchia, al temp ëd soa modernisassion portà anans da Kemal Ataturk.
Quand ch’a ven ëstampà la tradussion an inglèis, an Italia ’l lìber d’Olivero a l’ha già tirà 950.000 copie, na gifra strasordinaria për l’época ch’a l’é butà an comersi. Ël lìber a l’é ancora bastansa comun ëdcò ancheuj sia sël mërcà dl’antiquarià an Italia che su col ëstrangé, ant l’edission inglèisa.
J’arferiment a Turchia senza harem a son bondos an l’aragnà (WEB) ëdcò ’nt ij sit an lenga àraba. Për fé n’esempi i citoma che, ant ël 2004, la Prinsipëssa Nadine Sultana D'Osman Han (fija ’d Selim Han IV e anvoda dël sultan otoman ch’a fà 34, Abdul Hamid II) a ten an conferensa a l’IQSA (International Quajar Studies Association) sël tema: Harem: Perception & Reality of Life In Ottoman and Qajar Courts. La Prinsipëssa Nadine Sultana a arpòrta, an orìginal, ëd longh tòch dël sagg d’Olivero anans ai quaj a buta coste righe:
Sometimes misconceptions about the harem took novel and unexpected turns — as exemplified by the comments of Luigi Olivero, an Italian visitor to the Turkish reams — when one learns of the prejudices of the Western observers themselves in their attempt to make sense of what they see in this foreign yet fascinating institution of the harem. (Dle vire, a propòsit ëd l’harem, as artreuvo d’idèje sbalià ’nt ij romanz e ’d relassion ëd viagi nen ëspetà – coma ch’a lo dimostro ij coment ëd Luigi Olivero, un visitator italian ai règn turch – quand ch’i amprendoma ’d pregiudissi dj’osservator ocidentaj midem ant sò tentativ ëd dé un sens a lòn ch’a vëddo an costa situassion forëstera e ancora anciarmanta dl’Harem).
E a la fin a comenta:
This assessment is both interesting and revealing, in that it differs from the many others who either treat the harem with disdain or with misplaced fascination. Here we have a strange mix of approbation and accommodation combined with an exaggerated Western notion that the definition of the word "harem" means the uncontested male superiority enjoyed by the Orient and the East.
While individual rulers may have indeed dealt arbitrarily with some occupants of their harems and while some may have had visions of themselves as ‘queen bees’ of their hive, the realities of the actual harems, particularly those of the Ottomans that are the subject of my lecture were quite different from the positive and negative fantasies of the outside observer. (Costa valutassion a l’é sia anteressanta che arvelatris, da già ch’a l’é diferenta da cole ’d tanti àutri ch’e a trato l’harem con dëspresia o con anciarm fòra pòst. Ambelessì i l’oma na dròla mës-ciura d’aprovassion e d’apògg combinà con un concet ocidental esagerà, për ël qual la definission ëd la paròla «harem» a veul significhé la superiorità nen contrastà për ij mas-cc ëd la qual a gòd l’Orient.
Mentre che quàich sovran a peulo për dabon avèj tratà con arbitri quaidun-a dle abitante dij sò harem e mentre d’àutri a peulo ess-se sentù come «le regin-e dj’avije» ant sò buss, le realtà dj’harem d’adess, an particolar coj ëd j’otoman ch’a son l’oget ëd mia conferensa, a son ëstàit motobin divers da le fantasìe positive o negative për un ch’a varda da fòra).
Ant ël 1946 l’Atlantica editriss ëd Roma a pùblica ’l romanz Adamo ed Eva in America – Alla vigilia del secondo diluvio universale. Ëdcò costa euvra a l’ha soa tradussion an inglèis për cont dël midem Ivy Warren: Adam and Eve in America, MacDonald & Co, Londra 1951. Dël 1952 a l’é la tradussion an alman për mérit d’Otto Muller: America total Plem Plem? (America totalmente sempliciotta, o ingenua, o pazza?) ch’a l’é vëdusse seurte a pontà sl’arvista Herz Dame ’d Düsseldorf.
L’assion a pija l’andi ai 13 ëd mars 1940 ansima a un aereo a quatr motor ëd l’Imperial Airways ch’a fà rota da Paris a Londra. An coj di l’aereo a l’é l’ùnich mojen për traversé ’l Canal ëd la Manica. A son ferm ij ferry-boat e ij piròscaf për colpa dl’asar dij sotmarin alman che, caland giù dal Mar dël Nòrd, a blòco ’l Pass ëd Calais. Olivero, a l’aeropòrt parisin ëd Le Bourget, a monta sl’aereo che tuti ij di a colega ’l continent europengh con l’Inghiltera. A-i son mach 4 sole përson-e ansima: n’ufissial inglèis con un brass angissà, un monsù ansian con la bombëtta, uciaj d’òr, la mosca e ’l pissèt baross a pont d’esclamassion virà al contrari, na tòta assè bionda, motobin ëslansà, tant eleganta, tant bela, con j’euj celest.
Un proverbi parisin assè galant a dis che quand une anglaise se mette á être belle, elle n’en finit plus. Cola tòta a rapresentava la giustificassion viventa ’d col proverbi. Olivero as seta dë ’dnans a chila con ël bijèt da vìsita convensional d’un inchin. Con dispet d’Olivero, ch’a l’é pen-a setasse, la fija as aussa, a bësbija Aho, I’m sorry. I have forgotten some thing (Ch’a më scusa i l’hai dësmentià quaicòs) e a cala da l’aereo lassand un lìber duvert a marché sò pòst. L’aereo a part sensa che la bela passegera a torna ansima.
Ël lìber, lassà sensa deje pèis dë ’dnans a lë sconsolà Olivero, che già a gustava an antìcip n’aventura piasosa, a l’é sensa frontispissi nì d’àutre indicassion dël tìtol o dl’autor. Olivero a lo pija, a ancamin-a a leslo, sùbit con indiferensa, peui sèmper con n’interesse pì grand. A ved ch’as trata nen d’un romanz, ma ’d n’ancesta romansà sla vita feminin-a merican-a. Rivà an Inghiltera a scriv a Robert Vaucher, segretari dl’ Association de la Presse Étrangère a Paris. Gnun editor fransèis a smija ch’a l’abia an catàlogh col lìber lì. D’artorn a Paris a fà d’àutre arserche fra ij libré ch’a conòss e colega fransèis, ma sensa arsultà. A sta mira a decid ëd publiché col lìber a sò nòm e con un sò tìtol.
A la fin dël frontispissi inissial a scriv:
Sul frontespizio di questo libro sprovvisto di carta d’identità figura oggi il mio nome e un titolo mio. Ma non intendo compiere un rapimento di proprietà letteraria aggravata da usurpazione di paternità.
Non sono un kidnappeer. Baby Lindbergh non l’ho rapito io. Se un giorno ritroverò il vero genitore di questo trovatello che oggi adotto amorevolmente, sarò ben lieto di restituirglielo trattenendomi per ricordo, il berrettino fantaisiste del titolo e la giacchetta leggiera (sic) della traduzione italiana: i due soli indumenti miei di cui è vestita la sua graziosa creatura.
Olivero definiss cost sò travaj: ancesta romansà ’d vita feminin-a merican-a. Për na soa descrission bin ëspantià, as peul vëdde ’l sagg ëd Vincenzo Giacomuzzi publicà an sj’At dël Convegn d’Alba dël 2007.
A la data dla publicassion ëd l’edission inglèisa, an Italia a l’ha già vendù bin 635.000 còpie.
A la mòda dël Manzoni, a l’é nen l’ùnica vira che Olivero a presenta na soa euvra coma s’a fussa stàita artrovà për cas. Parèj a l’avìa già fàit ant ël 1929, sël Mont Pirchirian, dacant a la Sacra ’d S. Michel, a pich sla Val ëd Susa e le Ciuse, andoa che Carlomagno, ant ël 773 a l’avìa agirà e batù ij Longobard ëd Desiderio. Ambelessì a compon la Romanza dle romanze dël sàut dla Bel’Àuda d’an cò dla Sagra ’d San Michel fasend rivé cost componiment: Dësgifrà ’nt na veja bërgamin-a trovà da un pëscador drinta un’arsela gòtica ’d pera scurpìa, antamà ’nt la riva dë Lagh cit dë Vian-a.
Ëdcò Adamo ed Eva in America a l’é present sël mercà antiquari sia italian che internassional, bele se an quantità pì ridota rispet ai doi volum presentà anans.
E spendoma adess doe paròle sj’àutri travaj d’Olivero ch’a l’avrìo dovù esse publicà, e quaidun destinà espress ai letor ëd lenga ingleisa.
Gli Stakhanovisti dell’amore - Stakhanovists of Love (Ritratti e profili)
Museo delle statue di cera - The Wax Museum (Ritratti e profili)
Volti in cornici di nàcchere (Ritratti e profili)
Costi tre volum ëd ritrat – vàire dij quaj presentà an colaborassion a quatr man con Angelo Nizza (3) ant la serie Trapanazioni del cranio publicà ’nt ël 1938-1939 da diverse arviste coma la napolitan-a Belvedere – a l’avìo nen vist la lus an quant Olivero midem an conta che, për colpa dj’aveniment ëd guèra, a j’ero nen podusse publiché sùbit e, a guèra finìa, tanti dij përsonagi a l’avìo perdù soa atualità.
Ant ël 1942 Charlotte Harrer a publica Japanische Skizzen. Olivero as na procura na còpia e a decid ëd cudine n’edission an inglèis e ’dcò, apress, con tuta probabilità, un-a an italian. A veul ëdcò gionteje quaicòs ëd sò, sla leteratura e sla poesìa giaponèisa. Charlotte Harrer a l’é la fija d’un conossù geològh, meteorològh e esplorator alman, Alfred Lothar Wegener (1880-1930), autor, fra j’àutre còse, ëd la teorìa sla deriva dij continent. Ant ël 1938 a l’ha sposà Heinrich Harrer (1912-2006), nasista convint e famos alpinista austriach, prim scalator ëd la muraja nòrd ëd l’Eiger, autor dël lìber Sette anni nel Tibet ant ël qual a conta soa permanensa an Tibet dal 1944 al 1951, dòp ëd soa evasion e scapada da un camp ëd concemtrament ingleis an India. Da cost lìber a l’é peui stàit gavà, ant ël 1997, la pelìcola 7 anni in Tibet ëd Jean-Jacques Annaud, con la partessipassion ëd l’ator merican Brad Pitt.
Olivero a pija ’d contat con la Harrer e già a pronta ’l tìtol dël neuv lìber: Japanese Sketches. The Land of God in evening Dress. Un tìtol ch’a l’é adat al caràter dël nòstr. Chiel a sugeriss ëdcò d’àutri doi vocàboj al pòst ëd Dress: in Pijama o in Tight. (La còpia dël lìber ëd la Harrer ch’a l’era an possess d’Olivero a l’é adess ant la colession ëd monsù Silvio Bonino ’d Margarita (CN). Ambelelì Olivero a l’ha cancelà ’l tìtol dël frontispissi con na riga a piuma butandje al pòst, scrivend con un crajon ross, col dzordit, giontand peui a màchina sò nòm sota a col ëd la Harrer).
La passion e lë studi për la poesìa giaponèisa a l’era stàit anciavà ’nt la ment d’Olivero da l’amis Ezra Pound con ëd longhe ciaciarade e scambi ’d litre. An propòsit Olivero a scriv an comentand la poesìa Trionf ëd le reuse dij samuraj sl’Armanach Viglongo dël 1982:
Fu il mio compianto amico Ezra Pound (1885-1972, stabilitosi a Rapallo dal 1925 al 1945 e poi dal 1958 al 1972 a Tirolo di Merano e a Venezia ov’è sepolto) a iniziarmi alla conoscenza – debbo onestamente precisare rimastami tutt’altro che specialistica e scientifica – di questo (Go Kyogoku) ed altri antichi poeti giapponesi dei quali, comunque, più per curiosità letteraria che altro, ho tradotto in piemontese parecchie Sedoka, bussoku-sekitai (o poesia del piede di Budda), tanke, haikai o haiku e imayo, schemi progenitori, taluni da oltre un millennio, della moderna omeopatica poesia occidentale esistenzialista. Versioni, naturalmente, eseguite sulle trasposizioni grafico-alfabetiche occidentali degli originali ideogrammi orientali, sotto l’illuminata assistenza dell’impareggiabile, enciclopedico, poliglotta, fosforescente poeta americano.
Belavans, për colpa dël pressipité dj’aveniment ëd guèra, ël proget a andrà nen anans, gavand-ne parèj ël piasì ’d lese j’angavign oliverian sla poesìa e leteratura giaponèisa.
Son a l’é lòn ch’a l’é stàit scrit anans ëd ven-e an possess d’un cartegi fra Olivero e soa agent londinèisa Jasmine Chatterton. Nen ëd gròsse novità, ma ’d precisassion e conferme. Ant na litra dij 29 dë stèmber 1951 chiel a scriv a soa agent:
Di questi giorni sono riuscito a recuperare un libro esauritissimo e di cui dispongo di tutti i diritti editoriali:libro che avevo scritto prima della guerra in collaborazione con una collega bavarese e pubblicato nel 1942 solo in lingua tedesca a Berlino. È un coloritissimo reportage sul Giappone moderno. Non politico. Abbiamo già provveduto ad attualizzarlo. Si intitola "Japanische Skizzen" (titolo che può essere modificato così:"Il Paese di Dio in tight, Schizzi Giapponesi, 1952. Quando la potrà interessare, me lo comunichi e io le spedirò l'unica copia dell'edizione tedesca che possiedo.
Ant la litra ch’a ven apress, sèmper mandà a Jasmine Chatterton ai 2 d’otóber 1951:
Le spedisco a parte, in plico raccomandato, l'unica copia che mi rimane di THE LAND OF GOD IN EVENING DRESS (o IN PIJAMA, come suona meglio in inglese) che venne pubblicato nel 1942 solo in tedesco: tiratura 350.000. Edizione esauritissima. Il Verlag Karl Curtius di Berlino che lo pubblicò non esiste più. L'opera è quindi liberissima compresa la copertina a colori e le belle fotografie intercalate nel testo e la mia coautrice Dr Charlotte Harrer mi ha delegato a trattare direttamente, considerandosi da me rappresentata per qualsiasi contratto di riproduzione all'estero sia in tedesco che in altra lingua.
Ai 14 ëd novèmber 1951 Jasmine Chatterton a scriv parèj a Olivero:
Dear Mr Olivero
I am returning to you herewith JAPANISCHE SKIZZEN. I showed it to Messrs Macdonald but they say that until they know what the sales on ADAM and TURKEY are likely to be it would be usless to consider a third book...
As na farà peui gnente.
Mr Cupido, cittadino del mondo N. 1 ~ Mr Cupid World Citizen N° 1
Cost a l’é un romanz umorìstich scrit an colaborassion con Vittorio Guerriero; vardoma-sì coma ch’a lo descriv Olivero midem ant la litra d’acompagnament dël pachèt con andrinta ’l manoscrit mandà a soa agent inglèisa:
È il più brillante, fortunato, dinamico tandem a grande successo di scrittori umoristi che abbia oggi l'Italia: e questo primo libro scritto da essi in collaborazione è stato definito da un autorevolissimo critico:
una calorosa stretta di mano del Satyricon di Petronio con The Vanity Fair del Tackeray, una scintillante denuncia - scritta con un inchiostro distillato festosamente dai sette colori dell'iride del riso - di tutte le viziose fatuità che esprime ancora la contemporanea High Life internazionale in un mondo sanguinosamente piagato da gravi tragedie sociali e politiche .
Vittorio Guerriero, nato ad Avellino il 4 aprile 1898 da padre napoletano e da madre romagnola, ha vissuto, fino a tre anni or sono, a Parigi. Corrispondente di grandi quotidiani italiani, ha pubblicato, in collaborazione con Maurice Dekobra Le rire dans le soleil, antologia dei moderni umoristi italiani. Tra i fondatori - con l'Accademico d'Italia Massimo Bontempelli, Ramòn Gòmez de la Serna, James Joyce, Georg Kaiser, Pierre Mac Orlan - nel 1926 del movimento letterario europeo "900" e dell'interessantissima e ormai rarissima rivista d'avanguardia, stampata a Roma in lingua francese, che s'intitolò ad esso.
Ant la litra d’acompagnament a-i é un ritrat d’Olivero midem e, ant në scond feuj, la tradussion dël tut an inglèis.
Për ël romans scrit a quatr man Mr Cupid, un editor merican a j’eufr 100 sterlin-e (as capiss da dividse an tre, Olivero, Guerriero e l’agensia) për ij drit ant j’USA e sensa gnun-a provision. Olivero a scriv a soa agent londinèisa:
È veramente troppo poco: sebbene un "businessman" americano sia quasi sempre un bolscevico democratico, bisogna fargli presente che Lei, il mio coautore e io non siamo deportati nei campi di lavoro della Siberia. Acconsento a 150 sterline. Ma non un penny di meno ...
Parèj ël romanz a vëdrà nen la lus.
Vita segreta degli animali (Titolo mio, a quattro mani con Maria Nencioli)
A l’é n’àutr proget a quatr man d’Olivero dla prima dël 1950. A dovrìa tratesse ’d na serie ’d racont sla vita dle bestie scrit an tandem con Maria Nencioli dla qual Olivero an dà un curriculum savurì:
Maria Nencioli, 2 novembre 1914, scrittrice, giornalista, musicista compositrice e scultrice. Si è diplomata in pianoforte nel 1932 al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Allo stesso Conservatorio ha studiato composizione coi Maestri Frazzi e Dalla Piccola. Ha studiato scultura con Vermetti e Griselli fiorentini. Ha esposto a Livorno nel 1935 alla Mostra degli Artisti e a Firenze (Artigianato fiorentino) nel 1938 con vendita di suoi bassorilievi.
Cacciatrice e pescatrice appassionata. Ha dedicato la sua giovinezza, fin dall'adolescenza, allo studio della vita segreta degli animali. Entrata nel giornalismo nel 1938 con Giovanni Ansaldo attuale direttore del "Risorgimento". Ha collaborato ai più importanti quotidiani italiani come "La Gazzetta del Popolo", "Il Messaggero", "Il Giornale d'Italia", "La Tribuna", "Espresso", "Il Popolo", "Il Giornale della Sera". È stata l'unica donna che, nominata corrispondente per la Marina 1941-1943, ha potuto assistere e descrivere le fasi più cruente del recente conflitto sia a bordo di unità operanti da battaglia e da scorta convogli, sia dislocata presso le principali basi dell'Africa Settentrionale. È livornese, quindi di sangue marinaro. Ha navigato tutto il globo terracqueo sia a bordo di navi da pesca (baleniere norvegesi) sia a bordo di navi di linea delle principali Compagnie Armatoriali italiane e straniere. Conosce quindi genti e paesi d'ogni latitudine, dall'equatore alle acque polari.
È una donna sportiva: campionessa centometrista di nuoto, appassionata di vela, equitazione, automobilismo da corsa, pilota d'aviazione sotto l'egida di Italo Balbo, ciclismo, motociclismo.
Allieva del famoso schermitore Nedo Nadi ex campione mondiale.
Ha in preparazione un libro sulla gente di mare dei diversi paesi.
Ansema al curriculum a-i è na litra scrita a man da la midema Nencioli:
Roma 27 aprile 1950
Delego con la presente dichiarazione il collega ed amico Dr Luigi Olivero a trattare e a concludere alle condizioni che egli riterrà le migliori l'edizione sia italiana che straniera del volume scritto in collaborazione e consistente in circa 15 racconti sulla vita degli animali.
Questo volume è ancora senza titolo e il collega Olivero ha piena facoltà di creare il titolo stesso, quello di ogni singolo racconto e quello delle diverse parti che comporranno il volume, oltre a una introduzione che egli stesso scriverà.
Maria Nencioli
I finisso elencand ancora doe euvre dle quaj, belavans, a tut ancheuj i l’hai nen ëd neuve se nen mach ël tìtol:
Il paese di Buffalo Bill: L'America per tutti e per nessuno - Buffalo Bill's Country: America for All and for None (Sagg)
Spagna 1950 - Flamenco in Red and Yellow (Sagg a quatr man con Renato Giani).
*********************************
Piemontèis ancheuj Anno XXXI ~ N° 1 - 2 - 3 ~ gennaio - febbraio - marzo 2013
Luigi Armando Olivero e 'l fassism
Lesend, ant ij mèis pen-a passà, ij contribù che l’amis Giovanni Delfino a l’ha smonume për la publicassion su cost giornal e sl’Armanach dij Brandé 2013 (ch’a l’é surtì pen-a anans ëd Natal ma ch’i peule ancora caté giutand a ten-e anvisca la fiama dël Piemont) a l’é vnume a la ment na domand che miraco a son fasse ’dcò d’àutri: «Col ch’a l’é stàit ël rapòrt ël Luigi Olivero con ël regim ch’a l’ha meprisà l’Italia ’nt j’ani ’d soa vita, dzorpì dla soa permanensa a Roma e dël travaj coma scritor e giornalista?». Costa question, girà al dotor Delfino, a l’ha butà an moviment soa veuja sensa fin ëd fé conòsse ’d pì e mej cost Grand ëd nòstra leteratura.
Gnanca da dilo che le rispòste ch’a l’ha mandame a son n’enciclopedìa d’informassion documentà con la pontoalità d’un pistin e l’orgheuj d’un giust.
A më smija pì che interessant condivide con ij nòstri letor cost patrimòni che miraco për tròp temp a l’é restà stërmà ’nt ij papé, da già che la tratassion a l’é na frisa longa, ma sòn për esse ’l pì completa possìbil. Se peui a-i sarà da gionté d’àutre còse i lo faroma con piasì, sèmper për dé dapress al midem but ëd l’informassion e dla documentassion.
Coma sèmper a l’é doveros arcordé che nòstr giornal a l’è duvert al debat ch’a podrìa ven-e fòra, bin intèis sensa intré an gnun dëscors polìtich ëd qualsëssìa banda o color. L’informassion ëstòrica a dev monté ansima a mica posission ëd part e esse, për tut lòn ch’as peul fè, obietiva e nen partianta.
Michele Bonavero
Luigi Armando Olivero e ’l Fassism
28 otóber 1922: Marcia su Roma
30 otóber 1922: Vittorio Emanuele III a dà a Mussolini l’incàrich ëd formé ’l neuv govern. A l’é la nassita dij vint’ani dël fassism ch’as sarerà peui ’nt la neuit fra ij 24 e ij 25 ëd luj dël 1943, prima con ël vot ch’a gava la fiusa dël Gran Consèj dël Fassism vers Mussolini e apress con l’intervent ëd Vittorio Emanuele III ch’a lo licensia e a lo fà aresté dadend parèj l’andi al cròl ëd tuta l’organuisassion fassista.
Luigi Armando Olivero ’nt ël 1922 a l’ha pen-a finì la classe ch’a fà ses dël cicl elementare (Lej Casati dël 1859 ch’a istituìa ij quatr ani d’istrussion elementare ch’a saran peui slongà a ses con le Lej Orlando dël 1904) e a l’ha anandiasse a frequenté la Scòla Técnica ch’a dura tre ani (sèmper ëscond a la Lej Casati; costa a dasìa l’intrada a l’Istituto Técnich ëd tre ani. La lej Gentile, ant ël 1928, a përmëtrà pì nen ël passagi a n’àutr cicl sucessiv dë scòle).
Andé a fé n’indàgin an sl’evolussion ëd j’idèje polìtiche ’d Luigi Olivero a l’é nen ëd sicur l’angagg ch’i son pijame ’nt l’anviaré la compilassion dël sagg ch’i son an camin ch’i pòrto anans an sla vita e sj’euvre ëd cost grand përsonagi. Tutun diverse vire, ant ël cors ëd j’arserche, i son ambatume ’nt sò scrit e sò giudissi ch’a manifesto, an particolar ant j’ani ch’a n’avzin-o a la Sconda Guèra Mondial, e ’nt prim ëd costa-sì, d’amirassion për ël cap dël Fassism, Mussolini, e për j’idèja da chiel professà..
Se coste idèje a sio stàite esprimùe për sclinta convinsion o për pura conveniensa (podèj travajé an manera libera an Italia, scrive e publiché lìber e artìcoj, viagé sensa antrap për ël mond), sòn a l’é tut da dimostré. I tirerai nen donca ’d conclusion, ma i buterai a disposission dël letor ëd coste pàgine la pì granda part ëd lòn che, fin-a a ancheuj, i son riussì a artrové su cost tema.
Ant ël 1926, finìe le Scòle Técniche e dòp d’un curt incàrich coma impiegà a la Comun-a ’d soa sità, Vila Stlon, (coma ch’a diciarerà chiel midem a la vìsita militar ai 9 ëd novèmber dël 1928, quand ch’a vnirà arformà për anchilosi articolare coxo femorale destra e ipertrofia grave arto omonimo) (1) Olivero a s’ancamin-a a la cariera da giornalista coma publicista. (I lo troveroma ’nt la lista dij giornalista a parte da l’Annuario del 1937-1938). (2)
Sèmper ant ël 1926 a ancamin-o a comparì ’d soe crònache teatraj da Vila Stlon e pais ëd j’anviron su La rassegna filodrammatica, boletin d’informassion teatral ëd l’Opera Nazionale Dopolavoro istituìa dal Fassism. Ant cost midem perìod a manda soe poesìe an italian a la milanèisa Giovinezza d’Italia e a l’oròbich Il pensiero, ai quaj a manda ’dcò d’artìcoj leterari. A colabora ’dcò, con ëd poesìe e dë scrit, a La farfalla dl’editor Nerbini ’d Firense. Quasi al temp midem a s’anandia a scrive ’d crònache sportive për ij giornaj turinèis Stampa sportiva e Stampa Sera.
Da j’inissi dj’ani ’30 a ancamin-a na longa serie ’d viagi, an particolar an Algerìa, Maròch, Tunisìa e Spagna che a produvran ëd bondose crònache publicà da Stampa Sera e da d’àutri giornaj. A part parèj ëdcò a colaboré con le grandi firme, l’arvista ch’a pùblica conte e racont, ideà e direta da Dino Segre, visadì Pitigrilli. A dà soa colaborassion ëdcò a la’arvista binela Il dramma. Ëd le grandi firme, an assensa ’d Pitigrilli, a na fà fin-a ’l sostitù coma cap-redator e diretor. Ambelessì a vnirà licensià ’d crèp për ij sò arpetù ritard an sl’orari. A farà na càusa ’d travaj con l’arvista che, an part, a la perderà. (3)
A s’anandia la Guèra Civil an Ëspagna. Olivero a l’é redator, për Il lavoro fascista ’d Roma, ëd le notissie che a ven-o da j’invià an Ëspagna. A ten chiel midem daré a j’aveniment a Ëspagna fasend soens ëd viagi. Ël giornal a pùblica doi sò tòch interessant dij quaj i n’arpòrto quàich part:
Ai 4 ëd mars dël 1939, an la pàgina ch’a fà quatr as ved:
Catalogna di ieri e di oggi. Gastronomia di “Barcelona la gorda”. Come mangiavano i capi rossi mentre il popolo moriva di fame
BARCELLONA marzo - Sulla «carretera» che si dipana a spirali paurose lungo i fianchi scoscesi dei Monti iberici, un giovane legionario padovano dai muscoli d’acciaio e dallo sguardo acuto di vedetta marina, mi portava due settimane or sono su un camion militare verso Barcellona. Lungo i fianchi della strada interrotta di ponti «volados» dalla dinamite dei rossi in fuga, sfilavano come in una pellicola tragicamente paradossale, paesi distrutti, fortificazioni smantellate, cittadine scardinate, stritolate dalla furia dei bombardamenti. Lungo il ciglio della «carretera», sullo sfondo di un paesaggio arso, emergente da una terra arrossata e arida che pareva non conoscere altro concime che quello della dinamite, passavano teorie di soldati in ritorno. Bandiere lacere. Volti virilmente belli rigati dal sudore della marcia. Polverone a nuvoli si alzava dietro ai muli e ai carriaggi, avvolgeva i ferri contorti delle automobili sconquassate, gli scheletri arrugginiti e frantumati delle batterie, ogni sorta di materiale bellico fuori uso.
Di quando in quando, tra le macerie dei casolari, sorgevano bivacchi di famiglie profughe che sostavano nel cammino intrapreso a piccole faticosissime tappe verso un «pueblo» che non avrebbero più ritrovato, verso una casa che fu un nido famigliare e che forse lo avrebbero ritrovato un ammasso inerte di rovine. In uno di questi bivacchi scorgemmo una signora vestita di nero: sui ventott’anni, un volto pallido, bellissimo, in cui due occhi bruni dilatati parevano illuminare di una luce femminilmente vivida e personale tutto il corpo meraviglioso. La signora parlava con un soldato marocchino e aveva nella sua mano destra aperta un oggetto che sfavillava sotto il sole: un orologio d’oro. Anche il soldato africano aveva una mano tesa e in essa si vedeva una scatola di carne: ma egli teneva un’altra mano aperta, con la palma sollevata verticalmente a fermare il gesto della signora.
Comprendemmo. Il soldato di Franco dava quel che aveva, ma non voleva ricompense.
La nostra macchina passò avvolgendo in una cortina di polvere la istantanea commovente che la retina della nostra memoria ha ritenuto impressa.
In un piccolo borgo, in cui ci fermammo per rinnovare l’acqua bollente del radiatore, un uomo anziano, ossuto, emaciato, raccoglieva in ginocchio qualcosa sul selciato della strada. Selciato scavato di buche, cosparso di immondizie e solcato da piccoli rivoli di acqua sporca. Osservai. L’uomo, con una mano raccoglieva frettolosamente dei semi gialli, li passava con un gesto rapido ma accurato contro i pantaloni e li riponeva, piano, nell’altra mano stretta a pugno. Erano dei garbànzos, dei ceci che qualche camion della sussistenza militare aveva lasciato cadere rimbalzando su una buca della strada accidentata.
Queste due scene non sono che due superstiti istantanee di ciò che era la Catalogna nei giorni dell’avanzata delle truppe nazionali…
Ai 26 ëd mars dël 1939, an tersa pàgina vardé sì:
Eroismo silenzioso. Un Ospedale da Campo legionario.
Lo “stato di servizio” del 031
L’Ospedale da Campo 031 che ho visitato a Masnou, a una trentina di chilometri da Barcellona, è un ospedale che ha percorso coraggiosamente la sua carriera di perfezione sanitaria con uno stato di servizio che si presenta interessantissimo appunto perché è partito originariamente dalla trincea.
Si è costituito sul fronte di Malaga, a Loja, passando quindi a Cordoba. Ha vissuto le giornate sanguinose di Guadalajara. Si è spostato a Valladolid per ripartire verso Sobròn, Quintanilla, Torme. Se a Malaga funzionò regolarmente con 222 feriti, sul fronte di Santander, a Santelices, ospitò stupendamente circa mille feriti. Si spostò a Vega de Pas alleggerito dei due terzi del suo prezioso fardello umano: combattenti guariti che ritornano al fronte, convalescenti che ripiegano sulla retrovia, pochi i gravissimi inviati all’interno, pochissimi i deceduti.
Si stabilisce ad Arcanti. Passa a Matillas, nuovamente su Guadalajara. Si sposta ad Armiñon. E sfreccia sul fronte d’Aragona e dell’Ebro. Le tappe si susseguono veloci: Calamocha, Muñiesa, Alcañiz, Gandesa. Le operazioni militari segnano un ritmo di avanzata e l’Ospedale da Campo s’intona a questo ritmo. S’impianta a Teruel e successivamente a Navarrete, Calamoesa, Garriòn. E sopraggiunge, sul fronte di Catalogna a coadiuvare l’ospedale 071. Grañena de las Garrigas, Juneda, Pobla de Claramunt, Badalona. E finalmente a Masnou, dove l’ho trovato (con circa 3500 feriti all’attivo) in una bella e spaziosa sede che era ancora un mese fa adibita ad ospedale dei rossi. … In poco più di un mese, come abbiamo enunciato, circa 2500 feriti sono stati curati nel 031. Fra questi feriti, 150 nemici.
Questa cifra – raggiunta in poco più di un mese di permanenza posta in rapporto con quella del personale sanitario rappresentato unicamente da 9 ufficiali, 49 tra sottufficiali e truppe, 2 crocerossine – afferma meglio di ogni verboso panegirico che soltanto il sentimento purissimo di compiere una missione può sorreggere i nostri medici legionari nell’adempimento di tanto superlavoro.
Tuttavia, malgrado queste dimostrazioni, il Corpo di Sanità Legionaria continua e continuerà ad essere il Corpo più silenzioso di questa guerra. Mentre rilevo queste virtù … è un coro di voci che esprimono una frase sola, quella che fa cadere il mio taccuino precipitosamente nella tasca:
- Non lodateci. Siamo tutti qui per compiere il nostro dovere di soldati e di fascisti. Non pubblicate i nostri nomi. Non vogliamo encomi.
Ed il farmacista, più sfottente di tutti, aggiunge:
- Se li stamperete … vi inviteremo alla nostra mensa e vi offriremo delle polpette di stricnina con un bicchiere di sublimato.
E il Cappellano, padre Tranquillo di nome e di indole, conclude la gaia diffida ammonendomi con un sorriso: - E io non vi assolverò.
Gli occhi delle sorelle infermiere
Nel patio dell’Ospedale, sotto l’arcata rettangolare che lo delimita, le due Crocerossine accendono le candele all’altare che il buon Cappellano ha elevato, sullo sfondo della nostra bandiera formante un riquadro contornato di alloro, fin dal primo giorno dell’ingresso in Masnou.
Su quest’oasi di pace e di dolore sembra che tutte le stelle del cielo di Catalogna veglino come occhi di sorelle infermiere curve nella notte, amorevolmente, sull’ansito dei feriti.
La collina alla sommità della quale si eleva l’edificio del 031 è tutta una luminaria di tranquille luci casalinghe.
Dalla strada sottostante di Masnou, lungo il mare, ci raggiunge attutita dal frangersi delle onde l’eco del rombo dei motori delle nostre colonne Legionarie che si spostano verso il fronte di Madrid.
Fra qualche giorno l’Ospedale da Campo 031 le seguirà, con la sua coraggiosa bandiera, con il suo drappello di valorosi sanitari, tenaci e silenziosi eroi in bianco che vegliano sulla vita preziosa dei nostri legionari.
Concludo questa prima parte con una poesia che a tutt'oggi mi risulta inedita. L'originale è tra le carte di Olivero conservate presso l'AssOlivero di Villastellone. Non ha data ma, come si evince dal testo, è stata composta negli anni della guerra o al termine della stessa.
Gloria ’d Savoja
Òh sota l’eui dël sol d’or luminos
pudei esse cangià ‘nt na preus ëd fior
sla colin-a ‘d Superga: e seurbe ij pior
dij re ‘d Savoja con ij brass an cros!
Re ‘d nostra rassa, a pioro e pioreran
sle tombe ‘d brasa dle nostre sità.
Bej sivalié vestì ‘d fer dël passà,
për un cit re ij grandi re spariran.
Sprofonderan ant un gran lagh ëd sangh
sangh dël Piemont con le ven-e tajà.
Gloria ‘d Savoja – ‘d neuv secoj – strossà
da le man fòle d’un vej sensa sangh…
N O T E
1 Foglio di leva di Olivero Luigi Armando. Carmagnola 28 ottobre 1928 dichiarato renitente alla leva. 9 novembre 1928 riformato con la seguente diagnosi anchilosi articolare coxo femorale destra e ipertrofia grave arto omonimo a firma del Commissario di leva G. Agati.
Dallo stesso foglio di leva riporto i seguenti dati:
Statura: m. 1,62 - Torace: m. 0.77 - Capelli: Castani - Naso: Arrice (sic) - Mento: Giusto - Occhi: Castani - Colorito: Roseo - Dentatura: Sana - Segni particolari: Nessuno - Professione: Impiegato - Sa leggere? Si - Sa scrivere? Si.
(Archivio di Stato di Torino, Via Piave. Liste di leva circ. di Torino classe 1909, vol. 761; riformati circ. di Torino, vol. 773)
Nella quarta edizione di Babilonia stellata, pubblicato il 10 giugno 1943, scriverà di pesare 58 chilogrammi.
2 Annuario della stampa italiana a cura del sindacato fascista dei giornalisti 1937 - 1938 XV - XVI Zanichelli editore Bologna
3 Stampa Sera dij 19 magg dël 1937, pàg.5 Una vertenza in tema di contratto giornalistico
Prima part, a continua.
Traduzione di Michele Bonavero
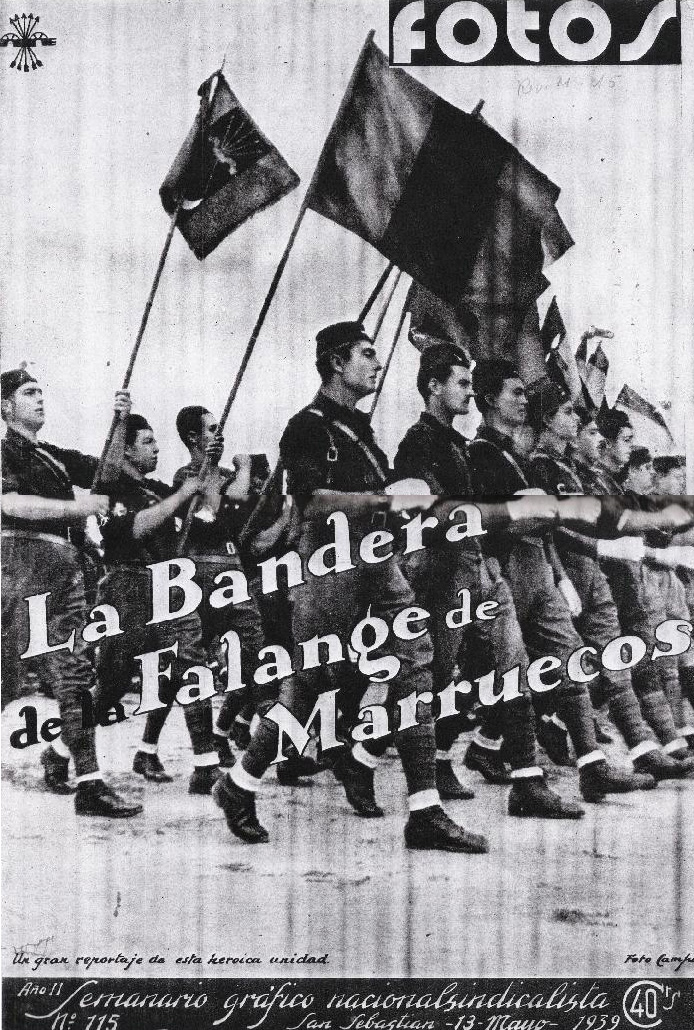
Copertina della rivista FOTOS N° 115 del 1939, della quale, con l'altra rivista spagnola MARCA, Oliveroera corrispondente
Luigi Armando Olivero e ’l Fassism
(sconda Pontà)
La prima pcita nòta polìtica esprimùa da Olivero i la treuvo tutun an sl’Armanach Piemontèis dël 1937 con l’artìcol Masnà ’d Nino Autelli.
Olivero a descriv l’ànim dobi ’d Nino Autelli, da na banda pì che sensìbil autor ëd Masnà, da l’àutra... a l’è un cheur dru e sislà ‘d corage come na medaja al valor militar. A l’è che Nino Autelli a l’ha vorsù esse volontare an A. O. e ant cost moment a ‘s treuva ancora an tèra d’Africa a protege i sorch signà dal destin imperial dla nostra rassa paisan-a e gueriera.
Su Nino Autelli, autor ëd doi volumèt delissios ’d fàule e conte an piemontèis, Pan ’d coa e Masnà, che Olivero a considerava il più grande poeta in prosa del Piemonte, i artornerai apress.
Ant ël 1939 a s’anandia na colaborassion a quatr man con l’amis giornalista, comediograf ëd sucess, Angelo Nizza (Con Riccardo Morbelli autor ëd la famosa trasmission a la radio I quattro Moschettieri). A s’inaugura parèj la serie d’artìcoj ch’a vniran publicà su vàire giornaj e arviste dal tìtol general Trapanazioni del cranio ant ij quaj a vniran butà an ridicol diversi përsonagi dl’época coma Grata Garbo, Filippo Tommaso Marinetti, Ciang-kai-scek, Roosvelt e tanti d’àutri ancora.
Sla fassëtta dë spedission dël n° 26, 10 stèmber 1939, ëd l’arvista napolitan-a Belvedere, ch’a publicava costi artìcoj, as les: Al fascista Luigi Olivero Via Arcivescovado, 7 Torino.
Na granda part ëd lòn ch’a manifestava Olivero an camp polìtich, as treuva ’nt ël sagg dël 1941 Babilonia stellata e, dzortut, ant soa edission ch’a fà quatr, motobin ëslargà, dël 1943. Ël sagg a l’é na frësca violenta contra ’l costum, la polìtica, la manera ’d vive merican, ai quaj as gionta l’Inghiltèra da la qual, a sò dì, a ven-o fòra. Le lobby d’ebreo a son butà al prim pòst ant la lista dij maj ch’a craso la Mérica. A la lòta alman-a për la pura rassa arian-a, ancolpà da j’USA ’d rassism, a ven contrapòst ël rassism USA contra ij nèir, antlora sì liberà, ma tnù su un pian motobin pì bass dël rest ëd la popolassion (pòst da setesse arservà al fond dij mojen pùblich, scòle aspress, intrada malfé se nen impossìbil ai pòst ëd comand an tuti ij setor e via fòrt).
Për la preparassion ëd sò sagg, an particolar an vista ’d n’edission ch’a fasa sinch (cola ch’a fà quatr a l’é dël 10 giugn 1943) as serv an manera bondosa dl’amicissia con Ezra Pound, ch’a-j furniss tant material an particolar an sle polìtiche monedarie merican-e che Pound a trovava motobin ësbalià, fasend na soa teorìa al contrari su n’ideologìa econòmica-polìtica ch’a jë smijava ’d vëdde ancarnà ’nt le dutrin-e fassiste dl’época. (Le velin-e ’d quàich litra mandà da Pound a Olivero a esisto ’nt ël fond dedicà a Ezra Pound pres ëd la Yale University ëd New Haven ant ël Connecticut, ëd le quaj, mersì a l’angagg e a la costansa dël Prof. Giuseppe Goria, i l’hai podù avèjne còpia).
L’amicissia con Pound a l’era manifestasse ’nt j’ancontr che ij doi a l’avìo avù ’nt j’ani passà da Pound an Italia (dal 1925 al 1945), andoa che chiel, për tant temp, a l’ha vivù a Rapallo. An cost period Pound a l’ha colaborà, con scrit e trasmission radio, direte an manera particolar vers la Mérica dël Nòrd, con ël regim fassista. Dòp ëd l’eut dë stèmber dël 1943, ël tombé dël Fassism, la përzonìa ’d Mussolini a L’Aquila e soa liberassion da part ëd j’alman, la fondassion ëd la Repùblica ’d Salò, a costa chiel a aderiss pì che lest continuand con soe trasmission a la radio e con j’artìcoj a favor dël regim. A vnirà arestà a la fin ëd la guèra dai partigian, consëgnà ai Merican ch’a lo tenran për tre mèis sarà ’nt na gabia postà fòra, ant un camp ëd përzonìa ’nt j’anviron ëd Pisa, ëd neuit sota la lus ëd potent rifletor. An cost clima a nassrà, miraco, soa pì bela archeujta poetica I canti pisani. Trasferì ’nt jë Stat Unì a ven acusà ’d tradiment e sarà ’nt l’ospidal federal criminal St.Elizabeths ëd Washington fin-a al 1958. An seguit a le proteste, sia nassionaj che antërnassionaj, a ven butà an libertà, ma afidà a la guerna ’d soa fomna. Col ann midem chiel a torna an Italia andoa ch’a resterà fin-a a la mòrt.
An cost àmbit d’amicissie a j’intra la tradussion ëd l’euvra Babilonia stellata, da part ëd Johan von Leers, che a seurt a Berlin da l’editor Runge con ël tìtol Babylon unter Davisternen und Zuchthausstreifen. Ël Leers a l’era stàit diverse vire an Italia ’nt ij prim ani quaranta, ancontrand Olivero an vàire ocasion. Finìa la guèra, sota fàuss nòm, a l’avìa ancora passà sinch ani a Roma, apress a l’era andàita an Argentin-a e, definitivament dòp an Egit. Olivero a fà nen arferiment an gnun dij sò scrit a costa tradussion, miraco artenùa scòmoda, da già che Leers a l’era stàit amis e protet da Joseph Goebbels e Heinrich Himmler e grand sostenidor ëd le teorìe sla rassa dël nassism, sostenidor ëdcò dla lòta contra j’ebreo e inventor ëd na teorìa për rende la rassa arian-a pì pura për mojen ëd la procreassion.
E i vëdoma adess quàich ës-cianchèt ëd Babilonia stellata. Ël travaj d’Olivero a l’é anticipà da la premëssa, sì sota arportà, che as treuva mach ant le prime tre edission, gavà vià però an cola ch’a fà quatr:
«È un non senso che un popolo
folle disponga delle più grandi
ricchezze del mondo, poiché ciò
significa dare delle armi in mano
ad un pazzo.»
«Kokumin Shimbum»
giornale nazionalista giapponese
Vers la fin dël capitol ch’a fà sinch, Olivero a precisa mej ël pensé dël giornal giaponèis che, ant l’otogn dël 1940, ant un artìcol ëd fond, a s’òcupa dl’ategiament ëd la Mérica ’nt ij rësguard dij problema dl’Asia Oriental e dël Pacifich. Dòp dël pensé arportà coma premëssa, ambelessì Olivero a gionta cost àutr tòch pijà da col giornal:
Voler convincere i pazzi con mezzi diplomatici è un tentativo inutile.
Il popolo giapponese è pronto a qualsiasi sacrificio per portare la sua potenza terrestre, navale ed aerea, al livello di quella americana.
Ël lìber, publicà ’nt ël 1941, a mostra, an particolar ant l’ùltim capitol, col ch’a fà dódes, na granda acrimònia ’nt ij confront ëd jë Stat Unì e dj’Ebreo, vantand nopà na granda amirassion për Mussolini. I arpòrto a cas quàich tòch significativ, ël prim, butà da Olivero, a l’é pijà da l’Almanacco Purgativo 1914 édit da l’arvista Lacerba, fondà e direta da S.E. Giovanni Papini:
Stati Uniti
Forma di governo – Repubblica imperialista
Abitanti – Miliardari, ragazze emancipate in cerca di mariti blasonati, cow-boys, linciatori, negri, inventori, clowns,
Prodotti – Cake-walk °, petrolio, grattacieli, macchine da scrivere, scarpe walk-over, esploratori, pellirosse.
Carattere nazionale – Orgoglio plutocratico, ignoranza e reclamismo.
Capitale – New York e Chicago.
° Musica afro-americana del sud degli Stati Uniti.
A seguita donca Olivero:
Repubblica imperialista! Orgoglio plutocratico! Ignoranza e reclamismo!
Questi tre colpi di bisturi sono di 27 anni fa: sotto la rossiccia epidermide dell’Uncle Sam, esistevano già le malattie vaso-circolatorie che sono esplose tutte all’evidenza clinica sotto l’inesorabile incisione inferta, con destrezza chirurgica impareggiabile e con tempestività meravigliosa, dal discorso del Duce del 23 febbraio 1941:
Una illusione e una menzogna stanno alle basi dell’interventismo americano.
L’illusione che gli Stati Uniti siano ancora una democrazia, mentre sono di fatto una oligarchia politico-finanziaria dominata dall’ebraismo attraverso una forma personale di dittatura: la menzogna che le potenze dell’Asse vogliano attaccare, dopo la Gran Bretagna, l’America.
Oligarchia ebraica.
Con quell’irresistibile invadenza che è la caratteristica della loro razza, gli ebrei si sono impadroniti di quasi tutti i posti di comando della politica e dell’economia americane.
I fatti, in questi due ultimi anni, si sono appunto modificati. Ma in peggio. Gli ebrei, in America, si sono raddoppiati di numero. Tutti i profughi più danarosi, sloggiati da quei sordidi mercati delle pulci e dello strozzinaggio che erano i ghetti di Berlino, Varsavia, Praga, Amsterdam, Bucarest, Madrid, Parigi, Belgrado, Atene, hanno avuto via libera nel paradiso dei dòllari dagli angeli guardiani dell’immigrazione che stazionano in permanenza nell’isola fatidica di Ellis Island definita da qualcuno «la porta della terra promessa che, oggi, per numerosi indesiderabili, è divenuta l’uscita dal paradiso».
Gli ebrei non sono degli indesiderabili, in America. No. Sono in casa propria. Sono nel paradiso terrestre popolato di alberi vestiti di foglie in cartamoneta e illuminato da miriadi di stelline in dòllari oro. Se la Palestina è la loro terra d’origine, l’America è la loro terra di elezione.
Il popolo americano non conta. Non è che uno strumento nelle mani dell’oligarchia semita. Come il popolo indù, il quale non è altro che uno strumento nelle mani dell’oligarchia britannica.
E l’oligarchia britannica e quella americana nascono da un unico ceppo: l’ebraismo.
America e Inghilterra, concubine di un solo padrone: il giudeo.
I penso ch’a peussa basté. Coma ch’i l’hai dit, bon-a part ëd l’ùltim capitol a l’é ’d cost tenor e a dòvra ’dcò ’d frase dël giornalista Amerigo Ruggiero (sensibilissimo sismografo della vita americana) e ’d Teodor Dreiser.
Cost a l’é un frut convint dël pensé oliverian o na gàbola për podèj publiché Babilonia stellata ’nt ël bel mes dël regim fassista?
L’anvija
Mòrd ant la polpa che veuj vëde ‘l gius
bagné i tò làver e lustrete i dent!
L’hai un cheur da masnà ch’a l’è content
d’ògni tò gest: ànche s’it mange un prus.
Na splùa galupa at passa ant j’euj rijent
e tut me sangh a l’ha come un sarus
d’amor për còl licor fresch ch’a lo ancioca:
perché ti ‘t morde un prus parei ‘d mia boca!
Inedita. Fondo Olivero Villastellone. Anni '30
Fin ël la sconda pontà, a continua.
Traduzione di Michele Bonavero
Luigi Armando Olivero e ’l Fassism
(TERSA e ùltima Pontà)
Luigi Armando Olivero a colabora fin-a dal 1943 (coma ch’a l’ha già scrit Olivero midem chiel a l’era stàit arformà a la vìsita ’d leva) con ël 1m Grup Alpin Val Casotto in qualità di patriota alle formazioni partigiane piemontesi. Elemento di primo piano nell’attività clandestina e di collegamento tra il Piemonte e la zona occupata.
A Roma a giuta për evité la fusiliassion ëd l’Avocat e musicista Carlo Emanuele Croce, e a riess, ai 19 ëd mars dël 1945, a intré ’nt le tant mal arnomà përzon ëd la Gestapo ’d via Tasso 155, con l’arzigh ëd soa incolumità, për anformé ’l Croce che amis e parent a son su soe pianà sugeriendje parèj l’ategiament da pijé durant j’anterogatòri ’nt ij confront dij sò colaborator ancora a pé lìber. Ël midem Croce a gionterà: …conservo la più schietta, profonda ed amichevole riconoscenza per il tempestivo intervento dell’amico Olivero che mi ha salvato dall’eccidio dei 320. (Fosse Ardeatine)
Ël colonel Alessandro Fossi, Comandant dël Grup Militar Clandestin omònim a gionta: …il giornalista Luigi Olivero ha dato la sua particolare collaborazione all’attività del nostro Gruppo Militare Clandestino.
Coste neuve a son pijà da doi document guernà pres ëd l’AssOlivero ’d Vilastlon. An nòta a l’é arportà la trascrission completa.
A guèra pen-a finìa, pres ëd l’editor Donatello de Luigi ’d Roma, chiel a publica, a l’inissi dël 1945, ël sagg Turchia senza harem. A le pàgine 118 e 119 i lesoma costi pensé d’Olivero ch’a rësguardo ’l cap dël Fassism.
Se Mussolini, invece di rivelarsi in politica estera un garçonnet frénétique, succube della nefasta influenza del teppichfresser (o morditore di tappeti, come gli irriverenti berlinesi definiscono l’epilettico Hitler), fosse stato un uomo di governo riflessivo e calmo come un pascià, avrebbe adottato, di fronte al conflitto universale, l’atteggiamento della neutralità utilitaria mantenuto impassibilmente, durante quattro anni e mezzo, dal Presidente Ineonu e oggi l’Italia non sarebbe un Paese materialmente e moralmente distrutto.
Un giorno - come accade oggi alla Turchia - l’Italia non si sarebbe potuta esimere dall’entrare in guerra a fianco di una delle due parti belligeranti. È ovvio che la tecnica temporeggiatrice, in tempo di guerra universale, non si può protrarre all’infinito. Ma, quel giorno, l’Italia si sarebbe trovata inevitabilmente a fianco dell’imminente vincitore, con un esercito organizzato, un morale nazionale intatto, un prestigio politico aumentato: tre elementi tali da rendere il suo concorso bellico validissimo e da affermarlo idoneo a pretendere la stima e la riconoscenza dei suoi alleati anche a pace vittoriosa conclusa.
La parte soccombente non avrebbe avuto ragioni plausibili per lagnarsi di lei: perché, in sostanza, quella parte aveva, - fino al giorno dell’inizio della propria disfatta – acquistato la neutralità dell’Italia per proprio tornaconto e con l’obbiettivo di trasformarla in belligeranza al momento opportuno, non appena, cioè, la sorte delle armi le si fosse dichiarata decisamente favorevole nel quadro generale della guerra e il concorso di quella potenza di riserva le fosse tornato utile per affrettare la propria vittoria. Avrebbe agito, in definitiva, né più né meno, come agisce attualmente la parte avviata al successo.
In un mondo di vincitori e di vinti - gli uni indeboliti dall’immane sforzo bellico compiuto, gli altri prostrati e probabilmente annientati dalla sconfitta -, l’ultimo partecipante al conflitto avrebbe avuto il privilegio su tutti gli altri partecipanti di conservare le proprie forze immuni da ogni usura e in grado di incutere rispetto, anche fisico, allo stesso alleato vincitore: sul quale, inoltre, avrebbe potuto contare molti punti di vantaggio nella immediata ripresa della competizione pacifica sul terreno economico internazionale del dopoguerra.
Il lettore italiano di molti scrupoli può trovare semplicemente affaristico e spregiudicato il mio ragionamento. Ma, in politica, la spregiudicatezza e l’affarismo costituiscono le due molle propulsive al balzo verso il successo. Non è con il supremo disinteresse e con l’onestà ideale che si guidano i destini di un popolo. E l’Italia, che con Macchiavelli, ha insegnato teoricamente al mondo, fin dall’epoca del Risorgimento, l’arte spregiudicata di ghermire il successo in politica, nella realtà ha sempre lasciato che altri mettessero in pratica i suoi insegnamenti.
Strano fenomeno di super-intelligente lazzaronismo atavico, quello fornito dal popolo italiano attraverso i secoli della sua disgraziata storia tutta rintronante di tragici, formidabili mea culpa!
Ma a l’era nen costa pròpi l’idèja ’d Mussolini al moment ëd l’intrada an guèra? Churchill a l’avìa dit a cost propòsit: credette di entrare in guerra negli ultimi cinque minuti, invece era il primo quarto d'ora!
A la fin dël 1947 Olivero a torna a Nino Autelli con l’arcòrd publicà an sl’ùltim nùmer surtì, un nùmer dobi 31-32, ëd soa arvista Ël Tòr. Paròle frapà për l’amis massà an manera crudela për soe idèje polìtiche ’nt le quaj a l’avìa chërdù e che mai a l’avìa tradì. I na arpòrto quàich tòch.
La gramissia uman-a a l’é granda, ma la vigliacheria a l’é in-mensa. Nino Autelli, poeta e prosator piemontèis - "ël pi fòrt prosator dla nòstra leteratura ’d tuti ij temp" a l’ha definilo Nino Costa, esplorator d’un mond ëd pura poesìa "dova a la savù aussese për la prima vòlta ant la stòria dla prôsa piemontèisa" e sorela pi cita, ma sorela, "dij Contes dël Perrault, dle Kinder und Hausmarchen dij Grimm e dle Prose d'Armana 'd Mistral" a son stait proclamà Chiel e la Soa euvra da un àutr poeta e studios piemontèis, pi sentimental an sla carta che ’nt la realtà, dël qual parleroma pi anans - (Nota: Pinin Pacòt); Nino Autelli, autor ëd coi doi diamant leterare, batesà Pan d' coa e Masnà, ch’as romperan mai con ël passé dël temp përchè a son doe ciadeuvre faite pi con ël sangh lirich cristalisà che nen con d’inciòstr e pi ancastrà ’nt la pera che nen tramandà ’n sël papé; Nino Autelli a l’é mòrt a Spinëtta Marengo (Alessandria) ant le sman-e dl’insuression del 1945 (ël 18 magg, a quatr e un quart dla matin) con ël còrp ë-squarsà ’d ferije orende, dòp tré ore tormentose d’un’agonia, da s-ciancheje ’l cheur fin-a al médich e al prèive ch’a lo assistijo, durant la qual a l’ha nen avù che ’d paròle ’d dosseur për Soa cita Paola, d’amor e ’d riconossensa për Soa tant cara sposa Maria, ’d bin squasi religiosa për Soa Mama adorà, e ’d përdon... L’ùltim Sò arsaj a l’é stait un pensé fiorì dla lus purissima dël përdon për ij fieuj sconossù, vestì ’d bonèt, dë s-ciarpe e ’d folar ross, che, an bòt ëd cola neuit midema a son sautà giù da un’automòbil ch’a l’era fërmasse a l’improvista dë ’dnans a Soa cà, a son intrà dë sfrandon, con ij "mitra" spianà, ant Soa stansa da let, e, insensibij ai crij d’angossa e dë sparm ëd Soa cita creatura e ’d Soe dòne, a l'’han intimaje ’d seurte ant la contrà, nèira ’d silensi, dova, prôpi an sla seuja ’d Soa cà, a l’han sparaje adòss una svantajà ’d mitraja, lassandlo slongà ’nt un lagh ed sangh (ore 1.15)....
Volontare come soldà sempi an Africa Oriental. Ël 23 novèmber 1940, a realisa Sò bel seugn d’amor sposand cola creatura ’d bontà, maestra come Chiel, ch’a l'avrà mai finì ’d pioré tute soe làcrime sla Soa tomba. Dòp apen-a doi mèis ëd matrimòne, ant ël gené 1941. a l’é arciamà, come sempi soldà ’d sanità, e destinà al treno ospedal N. 3 ch’a trasportava ij nòstri ferì da la Russia....
Quand a l’é naje Soa masnajin-a Paola (4 otober 1941), Chiel as trovava a Kolosvàr, Transilvania, ant un dij Sò viagi numeros ëd mission dla Cros Rossa. Congedà mes malavi dòpo squasi doi ani ’d cola vita ’d continua dedission a le soferense dij soldà, a ritorna a Soa scòla. Ant ël novèmber 1944, a ven torna arciamà sota j’arme e a resta an servissi, an Alessandria, fin-a al 25 avril dël 1945. A l’avìa la cossiensa tranquila. A savija d’avèj faje ’d bin a tanti e ’d mal a gnun...
Ël dì ’d Soa mòrt - òh la virtù ’d divinassion dij poeta! col dì a smiava ch’a sentèissa la man frèida dla mòrt passeje ’d nans a la front! - a l’avìa scrit costi pensé ’n sël feujet d’un Sò "notes":
«Il mio cuore piange in silenzio per le sorti della nostra terra. Voi no, voi non avete nessun dolore. Vi sento ridere, vi sento cantare per le strade. A voi nulla importa della nostra terra e avete vent’anni, giovani del mio paese. Voi non sapete che odiare. Il mio cuore è invece pieno d’amore per la nostra terra, per le nostre case, per voi... Voi non sapete come è bello anche morire per questo amore».
Pòvr Nino! A l’han vorsù vëde ant Chiel nen autr che un òm d’un color polìtich sganfà da la sponga ’d j’aveniment. A l’han mach vorsù s-ciairé, sota Soa bela front, un’idèja polìtica ormai brusà da ij slussi dla tempesta: un’idèja ant la qual a l’avìa chërdù fin-a a l’ùltim moment, con tuta sincera onestà sla Soa ànima càndia, përchè ant col’idèja - giusta ò sbaglià ch’a fussa - per Chiel a s’identificavo la legalità, l’onor, la difèisa dla Patria... Ant l’eror ò ant la vrità ch’a fussa, 46 milion d’àutri italian a l’avio chërdù, fin-a a pòchi mèis prima ’d Chiel, ant lòn che Chiel a chërdìa ancora: e un campionare ’d coi 46 milion ëd maometan passà, da l'alba al tramont, da la religion dël fez totalitare a cola del Borsalin democràtich, a l’ha chërdù ’d pudèilo giudiché come un dij pòchi ch’a l’avìo sbaglià a dann ëd tuti... e ’d masselo...
Për un miscredent sensa pi gnun-e ilusion - come chi ch’a scriv coste righe - viz-a-vi dla polìtica e dl’ànima uman-a, la fin ëd Nino Autelli a l’é la milionesima e una ripreuva dl’oceanica pàuta dë stupidità ’nt la qual a sbaciassa fin-a a la ponta dij cavèj costa pòvra rassa ’d sùmie bastarde ch’a s’ambardo ambissiosament dij titoi d’animai rasonévoi a ’d rè dla Creassion. Nino Autelli a l’era un-a dle raire ecession - rapresentà dai Sant, da j’Eròi, dai Poeta – ’d costa grisa furigada sensa fin ëd sùmìe mate a sanglan-e ch’a compon-o l’umanità....
E smonoma serenament, con la facia al sol, cost omagi a Nino Autelli; ... a Soa santa memòria, a Soa ànima bela, coragiosa e viva: pi viva che mai, ant noi, dë ’d sà da j’ombre sensa color ëd la mòrt dova Sò còrp a l’ha trovà finalment la pas dòp un’esistensa inchieta, come la nòstra, fija onesta dl’aventura e dl’azard.
Cost ëscrit d’Olivero a l’é mach na part ëd l’arcòrd dedicà a Nino Autelli. Chi a vorèissa leslo an soa completëssa a peul trové l’archeujta dl’arvista Ël Tòr a la Biblioteca Civica ’d Turin. A peul ëdcò ciamene còpia a mia adressa email. A sarà mia pressa ’d mandela al pì prest.
Olivero a sara sò scrit con costa nòta:
La fin ëd Nino Autelli, come l’oma documentala an sle testimonianse dij Sò familiar e dla gent ëd Sò paìs, a l'é staita bin pi tràgica ’d coma l’oma descrivula ant ij trè sonèt che publicoma, an Soa memòria, ant la pagina 10 e che l'oma scrit quand che conossìjo ancora nen tuta la vrità an tuti ij sò afros particolar.
La poesìa dont Olivero a fà mension a l’é A Nino Autelli rilesend Masnà, che i trovreve a la fin ëd cost tòch.
Apress a-i ven ancora la stupenda Mëssa paisan-a Cantà da na mare d’un pòvr soldà mòrt an guèra.
Ant j’ani pì davsin cost episòdi a l’é ancora stàit contà ’nt ël capitol La fiaba di Nino, ant la part ch’a fà quatr ëd Sconosciuto 1945 ëd Giampaolo Pansa, Sperling & Kupfer, Milan 2005.
Da l’arcòrd dedicà a Nino Autelli, ant jë scrit d’Olivero ch’i l’hai podù artrové, i l’hai nen trovà che doi pcit arferiment al periòd fassista. Olivero as lamenta ’d nen avèj podù publiché ij sò travaj. Ant ël 1933 a compon Ël rodon, destinà a l’Armanach Piemontèis dël 1936, la censura preventiva fassista d’antlona a na impedis la publicassion. Al prim d’otóber dël 1937 a compon ël dyptykos ëd sonèt Soa tenebrosa maestà la neuja ch’a peul nen publiché.. ant l’ann ëd soa nàssita 1937 e gnanca ant j’àutri sèt ane apress, përchè cola soa invocassion conclusiva “Òh torna, Libertà”etc. a l’avrìa nen sertament propissiame ’l cadò d’un basin an front da la censura polìtica d’antlora.
Nen tant temp fa Gianfranco De Turris, na vira colaborator ëd Julius Evola e ancheuj curator ëd soe euvre, ch’a scrivìa, coma Olivero, sla roman-a L’Italia che scrive, antlo sostnùa da l’Onorevol Ernesto de Marzio dël MSI, a l’ha contà dij sò ràr ancontr con Olivero pròpi ’nt la redassion ëd l’arvista. Chiel a buta Olivero tra ij giornalista gropà al fassism, arciclà coma profession, ma ch’a giravo e a j’ero sostnù ’nt j’anviron inteletuaj ëd la Drita (notissia costa ch’a l’ha furnime ’l Prof. Giuseppe Goria ch’a l’ha avù l’ocasion ëd parlé an përson-a con De Turris).
Coma ch’i l’avìa enuncià a l’inissi ’d cost ëscrit, sò but a l’é nen ëd sicur col ëd tirene fòra ’d giudissi. A l’é mach col ëd buté a disposission al letor ëd materiaj për ëd riflession utij. Dë scrit d’Olivero da dëscheurve a-i na j’é ancora motobin. D’àutr a podrìa ven-e a la lus për përmëtte la composission d’un quàder pì ampi sl’evolussion ëd sò pensé polìtich.
A Nino Autelli rilesend «Masnà»
Voici le temps des ASSASSINS.
Rimbaud
Con le doe man unije a leturil
reso tò liber, Nino, dle «Masnà»
parèj d’un missalin anluminà.
E an tuti i nerv l’hai un frisson sutil.
A l’alba dla toa vita ’t l’has cantà
j’ànime sempie come smens d’avril
ch’a viro ant l’aria, e, con un vòl gentil,
calo an tèra a visché ’d fior profumà.
Le bele fàule dle virtù paisan-e
e ’l «pan ’d coa» d’una candeur ëd lait
a l’ero al mond toe sole gòj uman-e.
Dë vlu ’d reusa tò cheur a l’era fait.
E a l’han strompatlo, ’d neuit, ëd man nostran-e
con na bala ’d fusil tirà a l’avait.
Sla seuja dla toa cà j’era l’invit
dla canson dla toa sposa ch’a spartìa
sla tàula ’l pan ëd la toa poesìa...
E ’t ses mòrt sensa un crij parèj d’un cit.
N’ombra a lassava ’nt l’ombra sò delit
ëd fassion da la guèra anvelenìa.
Na stèila visca an cel. L’ombra a sparìa...
E ’t ses mòrt sensa un crij parèj d’un cit.
Le feuje rosse d’un garòfo scrit
j’ero le màcie ’d sangh dla toa ferìa...
E ’t ses mòrt sensa un crij parèj d’un cit.
Con ij brass largh, con lë sguard fiss e drít
t’has vist në slussi su n’arcà fiorìa...
E ’t ses mòrt sensa un crij parèj d’un cit.
T’avìe chërdù ’nt la Patria e ’nt la bontà
dla toa gent ëd campagna, ànima pura.
Da j’ambe giàune a j’isbe ’d tèra scura
ël sign ross dla toa cros t’avìe portà.
An front al lìber, con la toa scritura
còtia come j’ariss ëd le masnà,
t’avìe scritme l’ofèrta: «A ti, ancërmà
’d n’anciarm midem ëd seugn e d’aventura».
Për nòst seugn d’aventura it ses cascà...
E mi leso tò lìber inossent
travèrs un vel ëd làcrime d’argent.
Tant che, ’nt la neuit, doe man ansangonà
- Nino, ’d tò sangh! - am calo ’d nans a j’euj
e as saro al còl d’na Mare sensa fieuj.
Roma, 2 agost 1947
NÒTA
Trascrission integral ëd doi document autenticà originaj ch’a son an possess ëd l’AssOlivero, Leja G.B. Gennero, 5 – 10029 Vilastlon (TO)
Il sottoscritto in qualità di Comandante di Banda (1° Gruppo Alpino Valcasotto), Comandante del 1° Settore Divisione Comando Formazioni Giustizia e Libertà e di Capo di Stato Maggiore della 2^ Divisione Alpina dichiara quanto segue:
il giornalista Dr. LUIGI OLIVERO abitante a Roma – Via Condotti, 6 ha collaborato attivamente sin dal 1943 in qualità di patriota alle formazioni partigiane piemontesi.
Elemento di primo piano nell’attività clandestina e di collegamento tra il Piemonte e la zona occupata.
IL COMANDANTE
(Dr.Carlo Ruvi di San Mauro)
Io sottoscritto Colonn. Alessandro Fossi, capo del Gruppo Militare Clandestino omonimo, dichiaro di aver ricevuto in data 7 giugno 1944 dall’Avvocato Carlo Emanuele Croce la comunicazione qui sotto riportata per esteso, il contenuto della quale ho potuto accertare rispondere a perfetta verità:
“Molto volentieri dichiaro che il giornalista Luigi Olivero si è molto efficacemente adoperato con immediata azione per la mia scarcerazione da via Tasso 155, riuscendo tra l’altro con pericolo della sua stessa incolumità a penetrare il 19 marzo 1944, con abile sotterfugio, nei locali delle stesse carceri politiche della Gestapo ed a farmi pervenire nella cella n. 25 piano quarto, riservato ai destinati alla fucilazione, la comunicazione che gli amici e la famiglia erano sulle mie tracce. Comunicazione che mi è oltremodo servita per l’atteggiamento che ho poi potuto assumere durante gli interrogatori e nei confronti dei miei collaboratori rimasti a piede libero.
Di quanto sopra ho fatto regolare comunicazione inviando copia della presente ai dirigenti della organizzazione politica e personalmente conservo la più schietta, profonda ed amichevole riconoscenza per il tempestivo intervento dell’amico Olivero che mi ha salvato dall’eccidio dei 320.
In piena fede.
In aggiunta dichiaro che il giornalista Luigi Olivero ha dato la sua particolare collaborazione alle attività del nostro Gruppo Militare Clandestino.
Il Ten. Colonnello Capo Gruppo
(Alessandro Fossi)
Roma, 15 giugno 1944
(Firma dël Colonel Fossi autenticà con Strument dël Nodar Trapanese Vincenzo fu Giuseppe Roma, 7 novèmber 1944)
Traduzione di Michele Bonavero
Voci dialettali Anno LXI N° 157/22~159/24 Aprile~Dicembre 2013
Luigi Armando Olivero dal 1940 al 1945
Incontri con
Ezra Pound, Johan von Leers, Charlotte Harrer, Emanuele Croce
Parte prima
Della vita e delle opere di Luigi Olivero ho già scritto su questa Rivista. In questo nuovo pezzo alcune notizie poco note o del tutto sconosciute sulla sua opera e sulle sue amicizie nel periodo che, dal crepuscolo del fascismo, si avvia alla ritrovata democrazia.
Negli anni trenta Olivero ha viaggiato moltissimo, cinque continenti, diciotto paesi. Ha intessuto relazioni e stretto amicizie mentre, per il suo lavoro di corrispondente, invia articoli a decine di riviste e giornali, sia italiani che esteri. Nel 1931, e poi in anni seguenti, è negli Stati Uniti. Qui collabora al The Italian Daily News di San Francisco e dirige anche una stazione radiofonica destinata al pubblico di lingua italiana, la K.D.I.A. sempre a San Francisco. Da questi soggiorni prende l’avvio il suo primo saggio: Babilonia stellata che vedrà la luce nel 1941 presso l’editore Ceschina di Milano.
Babilonia stellata è un volume che, in poco più di 250 pagine, mette a nudo gli aspetti poco edificanti della gioventù americana d’ante guerra. Prende l’avvio dall’articolo Trapanazioni del cranio: I cari genitori di Hollywood, che Olivero ha scritto in collaborazione con Angelo Nizza (1) e pubblicato il 3 settembre del 1939 sulla rivista napoletana Belvedere. Questo scritto è utilizzato in gran parte per il primo capitolo Pups: lo smodato utilizzo che viene fatto dai genitori a danno dei cosiddetti bimbi prodigio quali Jackie Coogan, Shirley Temple, Deanna Durbin e tanti altri. (2) Il saggio passa poi ad analizzare lo smodato utilizzo della droga, l’amore libero, la prostituzione, il racket dell’amore…
Questa sua opera prima incontra un grande successo. Due edizioni esaurite in pochissimo tempo. Una terza è in libreria nel giugno del 1941.
Nei suoi viaggi londinesi Olivero ha incontrato e stretto cordiale amicizia con Ezra Pound. Rapporti che proseguono con visite a Rapallo (qui Pound vive dal 1925) o a Roma dove Olivero ormai si è stabilmente trasferito. Lavora infatti all’EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) con trasmissioni di sue commedie scritte appositamente per la radio e con programmi per l’estero. Qui a Roma, per motivi di propaganda radiofonica, si trova spesso anche Pound. I due rafforzano quindi i loro legami ed insieme mettono mano a quella che sarà la quarta edizione di Babilonia stellata. Pound da i suoi consigli, in particolare rivolti alla politica economica americana. La nuova edizione uscirà nel giugno del 1943 aumentata di ben cinque capitoli e di oltre cento pagine.
Il pensiero di Pound è rintracciabilissimo in particolare nei capitoli che riguardano politica, economia e religione.
Non basta, Olivero ha in mente una ulteriore quinta edizione. Recentemente, nel corso di una ricerca bibliografica, mi sono imbattuto in un fondo appartenuto ad Ezra Pound giacente presso la Yale University nel Connecticut. In questo fondo sono presenti tre lettere siglate Olivero. Grazie alla collaborazione del Prof. Giuseppe Goria, cui avevo passato la notizia e che pazientemente ha intessuto i rapporti con la Yale, sono venuto in possesso delle copie delle tre lettere che erano di Pound e dirette ad Olivero. Nei tre dattiloscritti (in un italiano approssimativo e con numerosissime correzioni autografe) Pound, che dimostra di conoscere benissimo la quarta edizione di Babilonia stellata, segnala errori ad Olivero e aggiunge notizie. Inoltre tutta una lettera è da utilizzarsi come post-fazione della nuova stesura dell’opera. Purtroppo questo lavoro non avrà seguito causa il precipitare degli eventi bellici. (3)
Della prima edizione di Babilonia stellata, viene pubblicata anche un’edizione tedesca.
DiBabylon unter Davidsternen und Zuchthausstreifen (letteralmente Babilonia sotto stelle di Davide e strisce di galera) è traduttore Johan von Leers (25 gennaio 1902 Vietlübbe, Germania – 5 marzo 1965 Cairo Egitto). Membro attivo del partito nazista, amico e protetto da Joseph Goebbels, professore all’Università di Jena, padrone di sei lingue (inglese, spagnolo, olandese, francese, giapponese e italiano) fu sostenitore delle teorie razziali e legato a Heirich Himmler. Suo scopo liberare la Germania dall’imperialismo giudaico-cristiano. Fu anche autore, con altri, di un piano per sviluppare la razza ariana per mezzo della procreazione. Fu uno dei più radicali propagandisti dell’antisemitismo nel Terzo Reich. Tra il 1940 ed il 1945 fu spesso a Roma dove probabilmente conobbe e strinse amicizia con Olivero. Finita la guerra visse in incognito in Italia fino al 1950, quindi in Argentina e dal 1955 al Cairo dove abbracciò la religione di Maometto prendendo il nome di Mustafà Ben Alì e Omar Amin. Ha finanziato una edizione araba dei Protocolli dei Saggi di Sion e organizzato in Egitto trasmissioni radio antisemite e di incoraggiamento al risorgere dei movimenti neo-nazisti in varie lingue. Fu amico del mufti Haj Amin Al-Husseini che diede così il suo benvenuto a von Leers: ”Vi ringraziamo di prendere parte alla battaglia contro le forze del Male incarnate dagli ebrei del mondo intiero.”
Il libro. Uscito nel periodo più buio per la Germania, ebbe scarsa diffusione, forse buona parte delle copie andarono anche distrutte dai continui bombardamenti. Si trova con difficoltà anche nelle biblioteche tedesche, pur essendo presente, ad esempio, nella Berliner Stadtbibliothek. Nella traduzione di von Leers, il libro di Olivero appare nel 1947 in una lista di libri all’indice della DDR: Liste der auszusondernden Literatur. Erster Nachtrag nach dem Stand vom 1 Germany (Territory under Allied occupation 1945-1953 Russian Zone) Deutsche Werwaltung für Volksbildung 1947, 179 pag Zentralverlag. Babylon unter Davidsternen und Zuchthausstreifen. È accompagnato dalla frase: “Auch alle fremdsprachigen ausgaben verboten”. (È proibita anche la pubblicazione in tutte le lingue straniere)
Rimanendo in ambito germanico, nel 1942 viene pubblicato il saggio di Charlotte Harrer Japanische Skizzen. Olivero se ne procura una copia e decide di curarne un’edizione inglese ed anche, in seguito, con tutta probabilità, una italiana. Vuole però aggiungervi qualche cosa di suo, sulla letteratura e sulla poesia giapponese. Charlotte Harrer è la figlia di un noto geologo, metereologo ed esploratore tedesco Alfred Lothar Wegener (1880-1930), autore, tra l’altro, della teoria sulla deriva dei continenti. Nel 1938 ha sposato Heinrich Harrer (1912-2006), nazista convinto e noto alpinista austriaco, primo scalatore della parete nord dell’Eiger, autore di Sette anni nel Tibet in cui racconta la sua permanenza in Tibet dal 1944 al 1951 dopo la sua avventurosa fuga da un campo di concentramento inglese in India. Dal libro è stato tratto il film 7 anni in Tibet (1997) di Jean-Jacques Annaud con l’interpretazione di Brad Pitt.Olivero prende contatti con la Harrer e già predispone il nuovo titolo del libro: Japanese Sketches. The Land of God in evening Dress. Titolo del tutto consono al Nostro. Suggerisce anche due altri vocaboli al posto di Dress: in Pijama o in Tight. (La copia del libro della Harrer appartenuta ad Olivero è nella collezione del Sig. Silvio Bonino di Margarita CN. Olivero ha qui cancellato il titolo del frontespizio con un tratto di penna sostituendolo, scritto a matita rossa, con quello riportato più sopra, aggiungendo poi, dattilografato, il suo nome sotto quello della Harrer.)
La passione e lo studio per la poesia giapponese era stato inculcato in Olivero dall’amico Ezra Pound in lunghe conversazioni e scambi di lettere. Così in proposito scrive Olivero in commento alla poesia Trionf dle reuse dij samurai sull’Almanacco Viglongo del 1982:
Fu il mio compianto amico Ezra Pound (1885-1972, stabilitosi a Rapallo dal 1925 al 1945 e poi dal 1958 al 1972 a Tirolo di Merano e a Venezia ov’è sepolto) a iniziarmi alla conoscenza – debbo onestamente precisare rimastami tutt’altro che specialistica e scientifica – di questo (Go Kyogoku) ed altri antichi poeti giapponesi dei quali, comunque, più per curiosità letteraria che altro, ho tradotto in piemontese parecchie Sedoka, bussoku-sekitai (o poesia del piede di Budda), tanke, haikai o haiku e imayo, schemi progenitori, taluni da oltre un millennio, della moderna omeopatica poesia occidentale esistenzialista. Versioni, naturalmente, eseguite sulle trasposizioni grafico-alfabetiche occidentali degli originali ideogrammi orientali, sotto l’illuminata assistenza dell’impareggiabile, enciclopedico, poliglotta, fosforescente poeta americano.
Purtroppo, anche in questo caso, causa la guerra, che per l’Italia stava diventando sempre più catastrofica, il progetto non avrà seguito, privandoci perciò del piacere delle elucubrazioni oliveriane sulla poesia e letteratura giapponese.
Olivero ha preso definitivamente residenza a Roma, in via Condotti, 9 il giorno 11 dicembre del 1942. Non è chiaro se la sua venuta a Roma sia stata condizionata dall'apertura dell'atelier romano della futura moglie Felicina Viscardi, detta Cinci, erede di una nota ed affermata pellicceria di alta moda di Torino e sorella della moglie del poeta ed amico di Olivero Renato Bertolotto: 1'impressione è che le loro orbite si siano evolute in modo autonomo, attratte dalle rispettive esigenze professionali, verso la Città Eterna, e che poi lì, forti della pregressa conoscenza e frequentazione torinese, grazie alla comune amicizia, i loro destini si siano intrecciati fino al matrimonio, che contraggono a Roma il 16 maggio 1943.
Anche Cinci Viscardi, accostandosi all'attività poetica del marito, è poetessa in piemontese, pur se la sua ispirazione non è tale da condurla ad esiti importanti; è inoltre autrice di numerosi articoli sia sulla rivista del marito Ël Tòr, che su numerose altre pubblicazioni quali Armanach piemontèis, Il Cavour, Cuneo provincia granda, Notiziario della Famija Piemontèisa di Roma. Su varie riviste pubblica anche sue opere fotografiche.
Riporto, qui di seguito, due poesie, ad oggi, inedite di Luigi Armando Olivero del periodo 1935 – 1940. Tutte e due manoscritte, appartenenti al Fondo Olivero presso l’AssOlivero in Via Gentileschi, 1 10029 Villastellone TO.
Le traduzioni sono mie e non hanno alcun intento se non quello di rendere comprensibili le opere anche a chi non conosca il piemontese.
L’anvija Il desiderio
Mòrd ant la polpa che veuj vëde ‘l gius Mordi nella polpa che voglio vederne il succo
bagné i tò lavèr e lustreite i dent! bagnare le tue labbra e lucidarti i denti!
L’hai un cheur da masnà ch’a l’è content Ho un cuore da fanciullo ch’è felice
d’ogni tò gest: ànche s’it mange un prus. d’ogni tuo gesto: anche se mangi una pera.
Na splùa galupa at passa ant j’euj rijent Una ghiotta scintilla ti passa per gli occhi ridenti
e tut me sangh a l’ha come un sarus e tutto il mio sangue ha come un brivido
d’amor për còl licor fresch ch’a lo ancioca: d’amore per quel fresco liquore che l’ubriaca:
perché ti ‘t morde un prus parei ‘d mia boca! perché mordi una pera come fosse mia bocca!
Gloria ’d Savoja Gloria di Savoia
Òh sota l’eui dël sol d’or luminos Oh, sotto gli occhi del sole d’oro splendente
pudei esse cangià ‘nt na preus ëd fior poter essere mutato in una striscia di terra fiorita
sla colin-a ‘d Superga: e seurbe ij pior sulla collina di Superga e raccogliere i pianti
dij re ‘d Savoja con ij brass an cros! dei re di Savoia con le nraccia in croce!
Re ‘d nostra rassa, a pioro e pioreran I re della nostra razza, piangono e piangeranno
sle tombe ‘d brasa dle nostre sità. sulle tombe di brace delle nostre città.
Bej sivalié vestì ‘d fer dël passà, Bei cavalieri vestiti di ferro del passato,
për un cit re ij grandi re spariran. per un piccolo re i grandi re spariranno.
Sprofonderan ant un gran lagh ëd sangh Sprofonderanno in un grande lago di sangue
sangh dël Piemont con le ven-e tajà. sangue del Piemonte con le vene mozzate.
Gloria ‘d Savoja – ‘d neuv secoj – strossà Gloria di Savoia - di nove secoli - strozzata
da le man fòle d’un vej sensa sangh… dalle mani folli di un vecchio senza sangue...
Fondo Olivero Villastellone
N O T E
(1) Angelo Nizza (Torino 1905 – Roma 1961) Commediografo e giornalista. In coppia con Riccardo Morbelli la lunga serie radiofonica di grandissimo successo I quattro moschettieri. Con Luigi Olivero la serie di stroncature alla vigilia della seconda guerra mondiale su personaggi d’attualità dal titolo generale Trapanazioni del cranio uscite nel 1939 sulla napoletana rivista Belvedere.
(2) Jackie Coogan l’interprete de Il monello 1921 di Charlie Chaplin;
Shirley Temple apparsa in decine di film negli anni trenta Il piccolocolonnello, Ricciolid’oro 1935, Capitan Gennaio 1936, Heidi 1937, Rondine senza nido 1938, La piccola principessa 1939;
Deanna Durbin Tre ragazze in gamba crescono 1939.
(3) Ezra Weston Loomis Pound (Hailey, Idaho 30 ottobre 1885 – Venezia 1 novembre 1972). Poeta e critico americano vissuto per lo più in Europa, ed in gran parte in Italia a Rapallo, Tirolo di Merano e Venezia. Fu uno dei protagonisti del modernismo e fu forza trainante di movimenti quali l’imagismo e il vorticismo. Dal 1941 al 1943 realizzò trasmissioni per la radio italiana in cui difendeva il fascismo e accusava angloamericani e banche ebraiche di aver voluto la guerra. Queste trasmissioni gli valsero da parte del governo americano l’accusa di tradimento. Durante la Repubblica Sociale Italiana (ottobre 1943 – aprile 1945) continuò la sua attività giornalistica in cui ribadiva la sua solidarietà al fascismo. Il 3 maggio del 1945 fu arrestato da partigiani italiani e consegnato a militari U.S.A. che lo rinchiusero in un campo di prigionia e rieducazione a Metàto presso Pisa. Per circa tre settimane fu costretto in una gabbia di ferro posta all’aperto, al sole di giorno e alla luce accecante dei riflettori la notte. A fine novembre fu trasferito a Washington per il processo. Gli fu diagnosticata un’infermità mentale e fu recluso fino al 1958 nell’ospedale federale criminale St. Elizabeths di Washington. Il governo americano lasciò poi cadere l’imputazione di tradimento e sotto tutela e custodia della moglie riacquistò la libertà il 18 aprile del 1958. Rientrò in Italia a luglio sulla Cristoforo Colombo.
Bibliografia essenziale
A lume spento poesie 1908, A Quinzaine for this Yule poesie 1908, Personae poesie 1909, Exultations poesie 1910, Provença poesie 1910, The Spirit of Romance saggi 1910, Canzoni poesie 1911, Rispostes of Ezra Pound poesie 1912, The fourth Canto poesie 1919, Le Testament opera musicale 1923, A Draft of the Cantos 17-27 poesie 1928, A Draft of XXX Cantos poesie 1933, Cavalcanti opera musicale 1933, Homage to Sextus Propertius poesie 1934, Cantos LII-LXXI poesie 1940, The pisan Cantos poesie 1948 (Canti pisani 74-84 1953), Seventy Cantos poesie 1950, Section Rock-Drill 85-95 de los Cantares poesie 1956, Thrones 96-109 poesie 1959, The Cantos 1-109 poesie 1964, Drafts and Fragments: Cantos CX-CXVII poesie 1968.
Luigi Armando Olivero dal 1940 al 1945
Incontri con
Ezra Pound, Johan von Leers, Charlotte Harrer, Emanuele Croce
Parte seconda
Olivero, fino dal 1943, collabora con il 1° Gruppo Alpino Val Casotto in qualità di patriota alle formazioni partigiane piemontesi. Elemento di primo piano nell’attività clandestina e di collegamento tra il Piemonte e la zona occupata.
A Roma aiuta ad evitare la fucilazione dell’Avvocato Carlo Emanuele Croce, e riesce, il 19 marzo del 1944, ad entrare nelle famigerate carceri della Gestapo di Via Tasso 155, a rischio della sua incolumità, per informare il Croce che amici e famiglia sono sulle sue tracce suggerendogli così l’atteggiamento da assumere durante gli interrogatori nei confronti dei suoi collaboratori a piede libero. Croce aggiunge …conservo la più schietta, profonda ed amichevole riconoscenza per il tempestivo intervento dell’amico Olivero che mi ha salvato dall’eccidio dei 320. (Fosse Ardeatine)
Il Colonnello Alessandro Fossi, Comandante del Gruppo Militare Clandestino omonimo aggiunge: …il giornalista Luigi Olivero ha dato la sua particolare collaborazione all’attività del nostro Gruppo Militare Clandestino. (4)
Fino al 4 giugno del 1944 Roma è occupata dall’esercito tedesco. Olivero, in questo periodo, è critico cinematografico per il Messaggero. Decine e decine sono le sue recensioni che vengono pubblicate nei primi sei mesi dell’anno. Non solo film, anche resoconti di opere teatrali, opere liriche, balletti, concerti sinfonici.
L’undici di aprile compare il pezzo dedicato a Addio amore del 1943 di Gianni Francolini, interpretato da Clara Calamai, Roldano Lupi e Jacqueline Laurent e tratto da due romanzi di Matilde Serao, Addio amore e Castigo; ne stralcio questo brano in perfetto stile oliveriano:
Clara Calamai si destreggia con perizia in una parte considerevolmente ambigua. Ma perché, Donna Clara, vi ostinate a esibire i vertiginosi dècolletée dei tempi sostanziosi anche dopo che vi siete così razionalmente svitaminizzata?
Sembra impossibile che Roma, in quei giorni, manifestasse una così grande vitalità artistica. Una pagina intera del Messaggero è giornalmente dedicata agli spettacoli. Un centinaio di cinematografi, decine e decine di teatri con spettacoli i più vari!
In una domenica d’inverno, verso la fine del 1944, nella Roma brulicante degli eserciti alleati occupanti, Olivero è ospite nella biblioteca di un patrizio romano con Gabriellino d’Annunzio, figlio secondogenito di Gabriele, Peppino Garibaldi, nipote di Giuseppe, ed altri convenuti. Accanto al camino parla agli astanti della sua Torino ancora e sempre più martoriata dalla tremenda guerra aerea. Si scaglia poi violentemente contro Roma che definisce decrepita Taide intossicata dalla libidine immonda di tutte le conquiste e di tutte le rese… arce di tutte le retoriche… brulicante di ciceroni e professori, scatenando così le ire dagli ospiti che solo a stento verranno represse con l’intervento di Gabriellino e della consorte dell’ospite patrizio. La succosa ricostruzione di questa giornata, in una lettera di Gabriellino ad Olivero, verrà utilizzata da quest’ultimo quale prefazione alla sua prima raccolta di poesie in piemontese, Roma Andalusa, che verrà pubblicata nel 1947 dall’Editore Calandri di Moretta (CN) che, per essere ben preciso, sotto Moretta aggiunge a grandi caratteri Piemonte.
Il 14 di luglio del 1945 segna una tappa importante nella vicenda umana di Olivero. Una vicenda umana, da un lato ricca di soddisfazioni, dall’altra di polemiche che porteranno a incomprensioni, rancori, inimicizie. È la data della pubblicazione del primo numero de Ël Tòr Arvista libera dij Piemontèis. La rivista, quindicinale, si differenzia in modo notevole dalle altre dell’epoca, vuoi per la stampa a quattro colori, per l’impaginazione ancora sensibile alla frequentazione futuristica oliveriana, per l’illustrazione cui collaborano grandi artisti dello stampo di Gabriele Cena, Giuseppe Macrì, Orfeo Tamburi e tanti altri, ma in particolare per le collaborazioni letterarie e poetiche di tutto rispetto. Per questioni economiche ha vita breve, il 1945 ed il 1946 più un ultimo numero, isolato, sul finire del 1947. In tutto 32 uscite ricchissime di scritti e poesie di Olivero, ma anche di tante delle più belle penne dell’epoca. La rivista è stata definita da Benedetto Croce “La più bella rivista folkloristica italiana a respiro europeo.”
Sulle parole di Croce concludo questo intervento volto ad illustrare alcuni episodi, poco o nulla conosciuti, della vita di questo nostro grande poeta, scrittore, giornalista.
Riporto, qui di seguito, una poesia, ad oggi, inedita di Luigi Armando Olivero del periodo 1935 – 1940. È manoscritta e appartiene al Fondo Olivero presso l’AssOlivero in Via Gentileschi, 1 10029 Villastellone TO.
La traduzioni è mia e non ha alcun intento se non quello di renderla comprensibile anche a chi non conosca il piemontese.
Mè cheur a l’è na reusa rossa Il mio cuore è una rosa rossa
Mè cheur Il mio cuore
a l’è na reusa rossa è una rosa rossa
ch’a profuma ‘d boneur che profuma di felicità
e la soa porpra a mossa e la sua porpora spumeggia
bëschìa da un’ongia rossa: scalfita da un’unghia rossa:
l’ongia rossa ‘d toa man l’unghia rossa della tua mano
ch’a la sgraffigna pian. che lo graffia piano.
Mè cheur Il mio cuore
(reusa rossa fiorija), (rosa rossa fiorita),
s’anrubin-a ‘d boneur s’arrossa di felicità
se l’ujon d’un’avija se il pungiglione d’un’ape
lo fora ‘d gelosìa: lo perfora di gelosia:
la gelosìa dl’amor la gelosia dell’amore
l’è la spin-a ‘d na fior. è la spina d’un fiore.
Mè cheur Il mio cuore
a l’é na reusa rossa è una rosa rossa
ch’a tëm nen ël maleur che non teme la sventura
ch’a resist a l’angossa che regge all’angoscia
versand, a gossa a gossa, versando, goccia a goccia,
‘d lacrime profumà lacrime profumate
sui tòrt che il mond ai fa. sui torti che il mondo gli fa.
Mè cheur. Mio cuore.
Fondo Olivero Villastellone
N O T A
(4) Note tratte da due documenti autenticati originali in possesso dell’AssOlivero Via Gentileschi, 1 10029 Villastellone (TO); documenti che trascrivo integralmente.
Il sottoscritto in qualità di Comandante di Banda (1° Gruppo Alpino Valcasotto), Comandante del 1° Settore Divisione Comando Formazioni Giustizia e Libertà e di Capo di Stato Maggiore della 2^ Divisione Alpina dichiara quanto segue:
il giornalista Dr. LUIGI OLIVERO abitante a Roma – Via Condotti, 6 ha collaborato attivamente sin dal 1943 in qualità di patriota alle formazioni partigiane piemontesi.
Elemento di primo piano nell’attività clandestina e di collegamento tra il Piemonte e la zona occupata.
IL COMANDANTE
(Dr.Carlo Ruvi di San Mauro)
Io sottoscritto Colonn. Alessandro Fossi, capo del Gruppo Militare Clandestino omonimo, dichiaro di aver ricevuto in data 7 giugno 1944 dall’Avvocato Carlo Emanuele Croce la comunicazione qui sotto riportata per esteso, il contenuto della quale ho potuto accertare rispondere a perfetta verità:
“Molto volentieri dichiaro che il giornalista Luigi Olivero si è molto efficacemente adoperato con immediata azione per la mia scarcerazione da via Tasso 155, riuscendo tra l’altro con pericolo della sua stessa incolumità a penetrare il 19 marzo 1944, con abile sotterfugio, nei locali delle stesse carceri politiche della Gestapo ed a farmi pervenire nella cella n. 25 piano quarto, riservato ai destinati alla fucilazione, la comunicazione che gli amici e la famiglia erano sulle mie tracce. Comunicazione che mi è oltremodo servita per l’atteggiamento che ho poi potuto assumere durante gli interrogatori e nei confronti dei miei collaboratori rimasti a piede libero.
Di quanto sopra ho fatto regolare comunicazione inviando copia della presente ai dirigenti della organizzazione politica e personalmente conservo la più schietta, profonda ed amichevole riconoscenza per il tempestivo intervento dell’amico Olivero che mi ha salvato dall’eccidio dei 320.
In piena fede.
In aggiunta dichiaro che il giornalista Luigi Olivero ha dato la sua particolare collaborazione alle attività del nostro Gruppo Militare Clandestino.
Il Ten. Colonnello Capo Gruppo
(Alessandro Fossi)
Roma, 15 giugno 1945
(Firma del Colonnello Fossi autenticata con Atto Notarile Notaio Trapanese Vincenzo fu Giuseppe Roma, 7 novembre 1944)
Carlo Emanuele Croce, valente musicista oltre che avvocato, ha messo in musica la poesia di Luigi Olivero ‘L cocolino d’oro pubblicata nella “Colan-a Musical dij Brandé” Vol. 12, 1943.
In carcere in seguito all’attentato contro le forze tedesche occupanti Roma, compiuto in Via Rasella il 23 marzo 1944. Il 24 marzo 1944 i 320 reclusi furono messi a morte alle Fosse Ardeatine.
Piemontèis ancheuj, Ann 32 N° 2 fërvé 2014
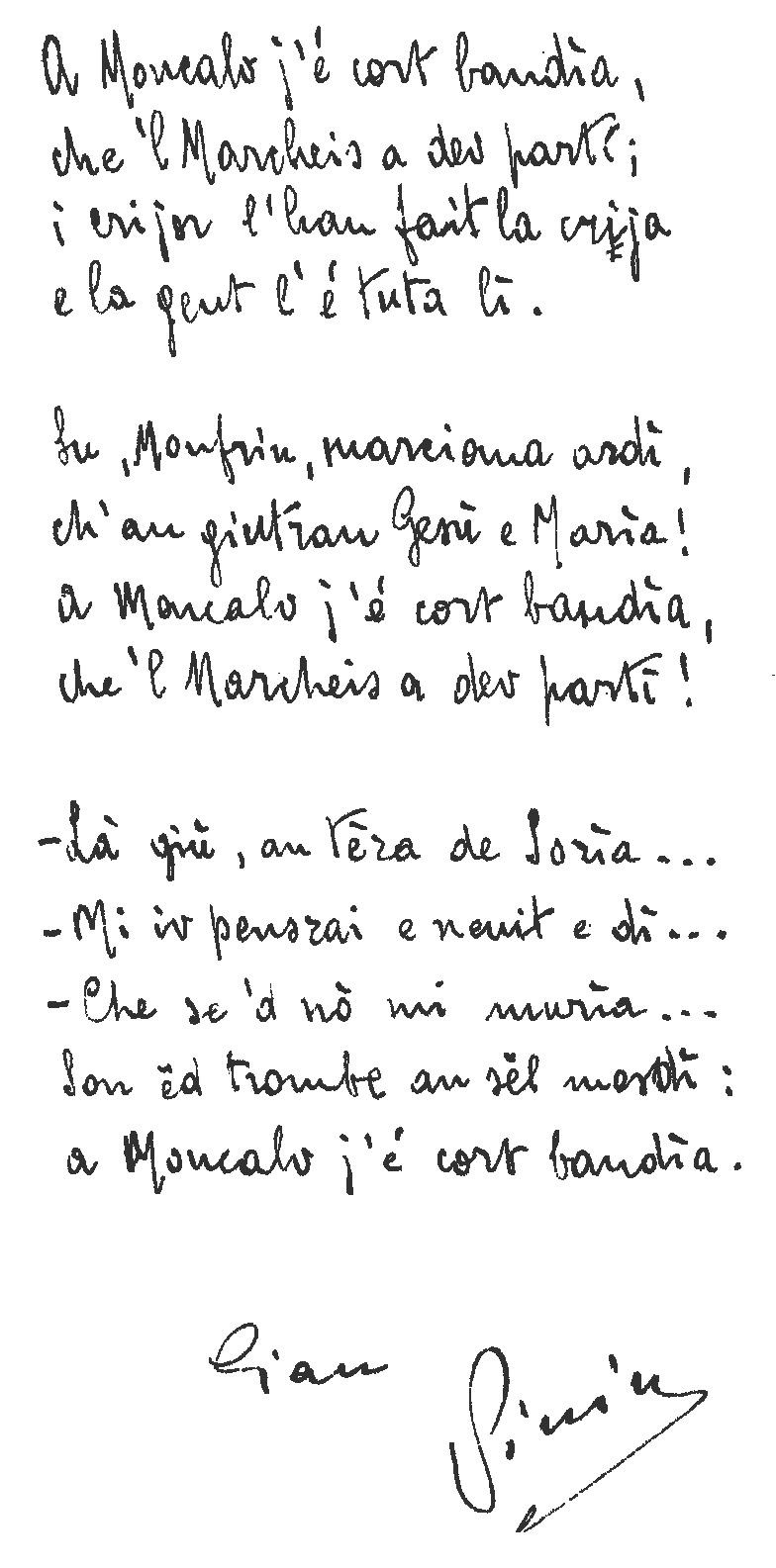

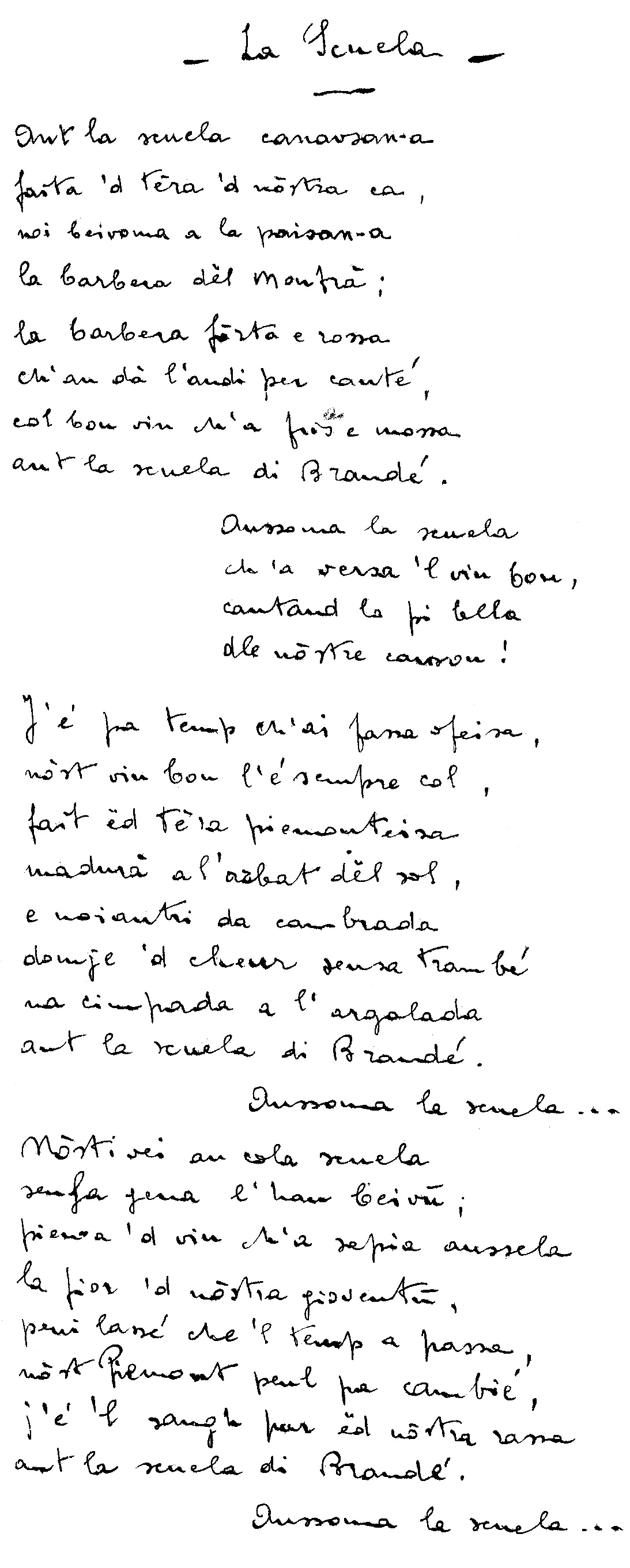
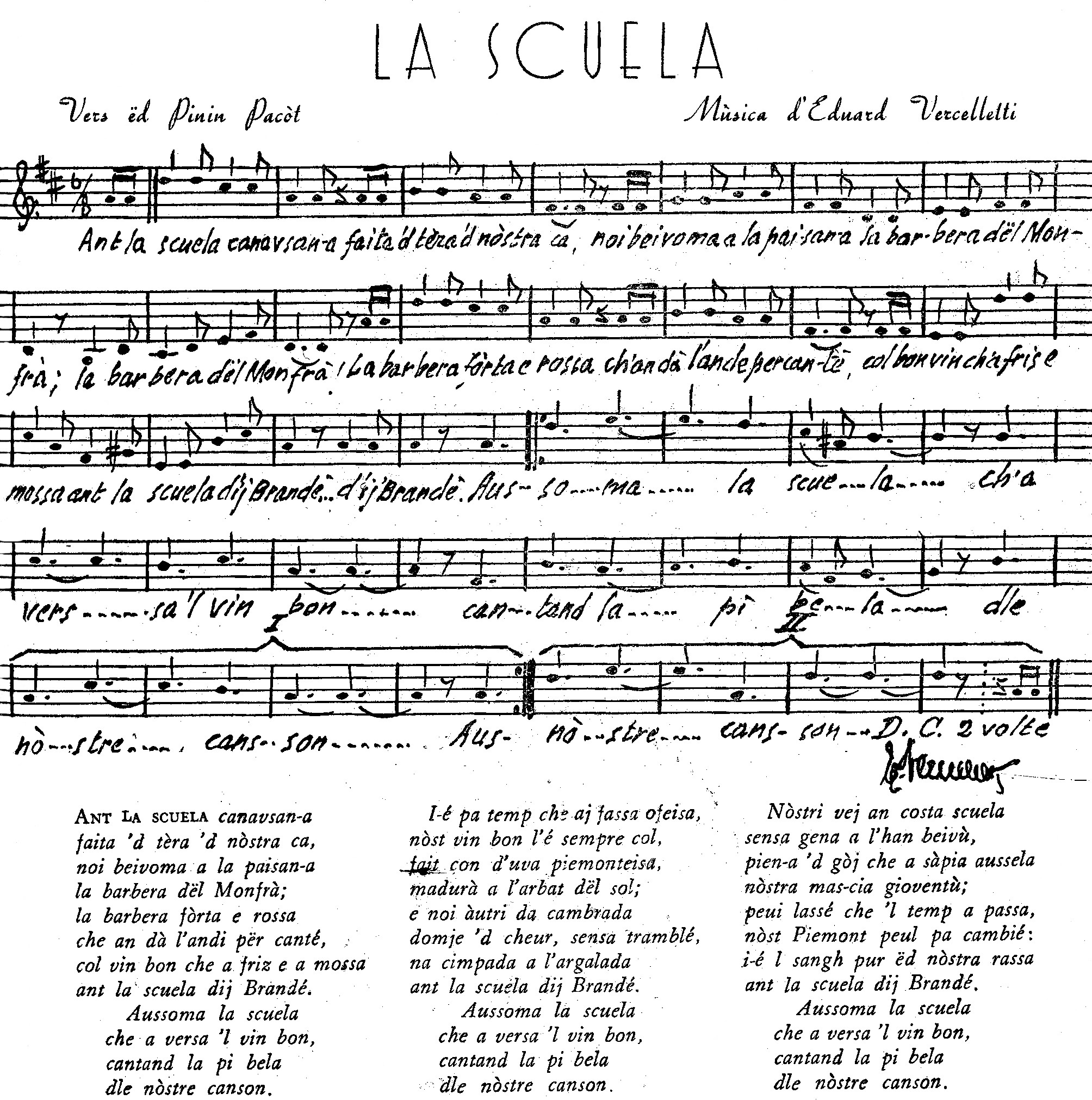
Voci dialettali 2010
ALDA MERINI
Giovanni Delfino
“…quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita.”
Alda Merini, La pazza della porta accanto. Mondadori, Milano 1996
1) Introduzione
2) La vita
3) Le opere
4) Tre poesie
5) La critica (prossimo numero di Voci dialettali)
6) Sergio Maria Gilardino: La poesia (prossimo numero di Voci dialettali)
7) Sei poesie (prossimo numero di Voci dialettali)
8) Aforismi (prossimo numero di Voci dialettali)
1) Introduzione
Qualche giorno avanti il Natale 2009, mi telefona il Presidente Mimmo Staltari chiedendomi un ricordo del Socio Onorario dell’ANPOSDI Alda Merini, che ci ha lasciato il primo novembre dello scorso anno. Lusingato da un lato, preoccupato, addirittura impaurito dall’altro. Il motivo? Non uno solamente. In primo luogo, fino a poco più di un mese prima, il nome Alda Merini per me era quale Carneade. Ne ho sentito parlare la prima volta dai telegiornali che annunciavano la dipartita di uno dei più grandi poeti contemporanei, addirittura in odore di Premio Nobel per la Letteratura. Inoltre non mi sono mai occupato di poesia se non scolasticamente con quei lunghissimi componimenti che allora, elementari, medie e liceo, ci facevano mandare a memoria. In quei momenti con grande disappunto. Oggi molte mi tornano alla mente non più odiate. Anzi, amate. Altri poeti ho poi letto negli anni per mio diletto personale, senza però alcun approfondimento. Solo da una quindicina d’anni mi dedico alla poesia non in lingua. Quella ligure, la mia terra natia, quella piemontese, mia terra d’adozione. In particolare, e per caso fortuito, mi sono dedicato, e tuttora mi dedico, alla poesia di Luigi Armando Olivero, poeta piemontese di Villastellone (Torino), Socio Fondatore dell’ANPOSDI, cui ho dedicato alcuni articoli, uno anche su Voci dialettali, e del quale sto portando a termine una vasta bio-bibliografia. E allora? Mimmo ha insistito, mi sono lasciato convincere. Quando assumo un compito amo portarlo avanti con la massima serietà e l’impegno di cui sono capace. Innanzitutto un piccolo sondaggio tra amici e conoscenti. Mi consolo: è un Carneade quasi per tutti. Anche un caro amico e noto critico letterario mi confessa con candore, non senza malcelata vergogna, di non aver mai letto alcuna sua poesia.
Comincio a documentarmi. Mi impressiona innanzitutto l’enorme mole dei suoi scritti. Poi la sua vita. Lunga, controversa, segnata ad intervalli da ricoveri in cliniche per malattie mentali, probabilmente per sindrome bipolare, di cui soffrirono grandi della storia letteraria quali Fitzgerald. Byron, Baudelaire e altri ancora. Mi viene da accostarla a Dino Campana, a Sibilla Aleramo, alias Rina Faccio da Alessandria, al loro burrascoso rapporto nel periodo in cui il poeta era ricoverato a Marradi nel 1915. Di questo tormentato amore, basato anche su reciproci insulti e percosse, ricordo il recente film del 2002 Un viaggio chiamato amore interpretato da Laura Morante e Stefano Accorsi per la regia di Michele Placido.
Tento ora di avvicinarmi all’avventura terrena di Alda Merini passando per la sua vita e le sue opere.
Di una segnalazione mi corre l’obbligo. La biografia che segue deve molto ai due saggi di Maria Corti (Milano 1915 – 2002. Scrittrice, filologa, semiologa, critica letteraria) pubblicati come introduzione alle raccolte presso Einaudi Vuoto d’amore Torino 1991, e Fiore di poesia Torino 1998. Ampie saccheggiature da entrambi i saggi sono presenti alla voce Alda Merini sul WEB sito di Wikipedia. Altre notizie ho desunto dall’autobiografia della Merini dettata alla giornalista Cristiana Ceci.
2) La vita
Nasce a Milano in Via Mangone a Porta Genova il 21 di marzo del 1931 Sono nata il ventuno a primavera/ ma non sapevo che nascere folle/ aprire le zolle/ potesse scatenare tempesta/ questo suo scritto Maria Corti incastonerà sul piatto di Vuoto d’amore nel 1991 per Einaudi . La famiglia è di condizioni modeste, padre impiegato e madre casalinga. Ha una sorella maggiore d’età. Nel 1943 la famiglia subisce i pesanti bombardamenti della RAF. Alda e la mamma, incinta, sono in un rifugio sotterraneo. Sotto le bombe la bimba aiuta la mamma a far venire alla luce il fratellino. Ritornati all’aperto la casa non esiste più. Alda, mamma e il piccolino si rifugiano presso una zia tra le risaie di Vercelli. Alda farà anche la mondina. Papà e sorella rimangono a Milano dove tutti si ritroveranno finita la guerra. Rare volte fratello e sorella ritroviamo nelle sue poesie, però ricordati quasi non appartenessero alla sua vita, con distacco, senza amore.
Frequenta l’istituto professionale Laura Solera Mantegazza, ma vorrebbe adire al Liceo Manzoni. Non viene però ammessa, e, quasi un paradosso, per non essere riuscita a superare la prova d’Italiano.
Dimostra però anche altri interessi, in particolare per lo studio del pianoforte cui si avvicina con grande amore ed con discreti risultati.
Perviene giovanissima alla poesia. A quindici anni l’incontro, favorito dall’amica Silvana Rovelli, cugina di Ada Negri, con Giacinto Spagnoletti. (Taranto, 8 febbraio 1920 – Roma, 15 giugno 2003. Critico letterario, poeta e romanziere. Di se ebbe a dire A volte poesia era per me il prestarmi alla vita, alla gente analfabeta che non sapeva esprimersi: diventavo la sua penna o la sua voce.)
Spagnoletti, che ne ha intuito il talento, la guida. Non solo, la pubblica nella sua edizione della notissima Antologia della poesia italiana contemporanea edita da Vallecchi nel 1946, poi più volte ristampata fino alla definitiva edizione di Guanda del 1950 dove appunto appaiono due poesie della Merini Il gobbo e Luce. Oltre alle poesie di Alda troviamo anche le prime prove di Pier Paolo Pasolini. Di questa antologia, un’edizione scolastica ridotta, ha avuto sicuramente il merito di avvicinare alla poesia moderna molti giovani che altrimenti ne sarebbero rimasti esclusi. Spagnoletti seguirà, negli anni, a lungo l’opera della Merini che, sicuramente, al primo Maestro deve moltissimo.
Ed ecco, improvviso, nel 1947, affacciarsi il primo periodo travagliato nella vita di Alda. Presenta segni di squilibrio ed entrano in lei le prime ombre della sua mente come afferma Maria Corti nella sua introduzione a Vuoto d’amore. Per circa un mese sarà rinchiusa nella clinica Villa Turro, indirizzata alla cura delle malattie psichiatriche, facente parte del San Raffaele di Milano.
Alla sua dimissione le sono vicini gli amici Giorgio Manganelli (Milano, 15 novembre 1922 – Roma, 29 maggio 1990. Scrittore, giornalista, critico letterario e teorico della neoavanguardia. Primo grande amore della giovane Alda), Luciano Erba (Milano, 18 settembre 1922. Poeta e critico letterario che fece parte della quarta generazione) e Fra’ David Maria Turoldo (Al secolo Giuseppe Turoldo. Coderno, 22 novembre 1916 – Milano. 6 febbraio 1992. Poeta ed appartenente all’Ordine dei Servi di Maria). Questi la indirizzano, per il proseguimento delle cure, agli specialisti Franco Fornari (psicoanalista e psicologo) e Cesare Musatti (Psicologo e fondatore della psicoanalisi italiana).
Grazie all’antologia di Spagnoletti, anche altri si accorgono di Alda. Eugenio Montale (Genova, 12 ottobre 1896 – Milano, 12 settembre 1981) e Maria Luisa Spaziani (Torino, 1924. Poeta) consigliano all’editore Giovanni Scheiwiller di proporre sue nuove poesie nella antologia del 1951 Poetesse del novecento edita dalla sua milanese casa editrice All’insegna del pesce d’oro. Insieme ad altre due poesie riappaiono qui Il gobbo e Luce.
Tra il 1950 ed il 1953, per questioni legate al lavoro, ma anche per una amicizia che si fa mano a mano più solida ed intima, frequenta Salvatore Quasimodo (Modica, 20 agosto 1901 – Napoli, 14 giugno 1968). Al poeta Alda dedicherà tre poesie: due nella raccolta inedita Il volume del canto (iniziata nel 1979 e pubblicata nel 1991 da Maria Corti per Einaudi in Vuoto d’amore riprodotte nel paragrafo 8: Sei poesie) e una in La gazza ladra – 20 ritratti raccolta iniziata a Taranto nel 1985, inedita anche questa, pubblicata nel 1998 nell’antologia già citata.
Nello stesso anno si unisce in matrimonio con Ettore Carniti, proprietario in Milano di alcune panetterie. Contemporaneamente, quasi un omaggio per le sue nozze, esce presso l’editore Schwarz, la sua prima raccolta di versi La presenza di Orfeo. In questa raccolta riappaiono, con giusta data, le due prime poesie pubblicate di Alda. Da questo momento la sua produzione si intensifica e le pubblicazioni si succedono con frequenza.
Nel 1955 nasce la sua prima figlia, Emanuela, e, quasi a renderle omaggio, Bompiani pubblica la sua opera in prosa La pazza della porta accanto da cui una breve citazione quale sottotitolo di questo scritto. La bimba ha spesso bisogno di cure, ne ha anche bisogno la seconda figlia, Barbara, nata nel 1958. Suo medico curante è il Dott. Pietro De Paschale, cui, nel 1961 Alda, ricordando il suo amore infelice e non corrisposto, dedica i versi di Tu sei Pietro. Questa volta la pubblicazione si deve a Vanni Schweiller, al quale il padre ha da diversi anni ceduto la casa editrice. La silloge è stata suggerita dall’allora nota astrologa Violetta Besesti.
Dal 1961 il canto della Merini si spegne. Sembrerebbe per sempre. Nel 1965 è internata all’Ospedale Psichiatrico milanese Paolo Pini. Lungo periodo intervallato da brevi rientri in famiglia per la nascita delle altre due sue figlie, Flavia ed infine Simona nel 1967. Il suo silenzio si prolunga. Riprende a comporre solo nel 1979. Qui la sua voce diviene drammatica, addirittura sconvolgente. È la sua tristissima esperienza, sono le sue ansie, i suoi spettri, il suo stesso io più recondito, vissuto e rivissuto nei lunghi anni di permanenza nella clinica psichiatrica. Opera prima, dopo il lunghissimo suo tacere, è La Terra Santa. Il suo capolavoro scrive Maria Corti. (Milano, 1915 – 22 febbraio 2002. Filologa, scrittrice, critica letteraria, semiologa) in Introduzione a Alda Merini. Fiore di poesia. 1951 – 1997 per l’editore Einaudi di Torino) Questo lavoro porterà ad Alda, nel 1993, il Premio Librex Montale istituito alla morte del poeta, che assocerà il nome della Merini ad altri grandi della poesia, della letteratura e della musica italiana ed internazionale.
Nuovi dolori. 1981, l’atroce morte del marito, colpito dal cancro, che la lascia sola. La sua voce sembra essere ignorata ormai da tutto il mondo letterario. Senza successo fa la spola presso innumerevoli editori che le rifiutano ogni lavoro. Solo nel 1982 Paolo Muri le offre uno spazio per trenta poesie sulla rivista Il cavallo di Troia che, con l’ausilio di Maria Corti, seleziona da un manoscritto che ne contiene oltre 100. Le poesie vengono pubblicate sul N° 4 della rivista dell’inverno 1982 – primavera 1983. Relativamente al numero delle poesie pubblicate, scrive Maria Corti …per anni Alda Merini si era abituata, su consiglio dei medici, a scrivere di getto, spesso a scopo liberatorio: nacquero così, a fianco ai testi poetici di grande valore, altri di carattere comunicativo. Di qui l’utilità di un lavoro di selezione che isoli le perle e i brillanti e dia loro la possibilità di splendere. Comunque il materiale lasciato inedito è a disposizione degli studiosi nel Fondo Manoscritti di Autori Moderni e Contemporanei dell’Università di Pavia.
Le ristrettezze economiche la tormentano. Affitta una stanza della sua abitazione al pittore Charles Charlot Charcot con cui stringe un legame sentimentale e al quale dedicherà molte poesie nella raccolta Poesie per Charles pubblicate sempre da Maria Corti. Contemporaneamente stringe rapporti con il poeta pugliese Michele Pierri membro dell’Accademia Salentina che, in quel periodo in cui tutti la ignorano, ha mostrato interesse per la sua lirica. Amicizia stretta, quasi subito seguita da matrimonio nell’ottobre del 1983.
Qualche mese dopo, con Vanni Scheiwiller, aggiungerà altri dieci componimenti a quelli pubblicati su Il cavallo di Troia che andranno a comporre e ad essere stampati ne La terra promessa che vede la luce, finalmente, nel 1984.
Si trasferisce a Taranto, dove vive con il marito, che era stato medico, da cui viene curata e protetta. Riprende a scrivere di buona lena. Rientra però quasi subito in ospedale psichiatrico a Taranto. Osteggiata dai figli del poeta per questioni finanziarie, nel 1986 se ne torna nella sua Milano dove la cura amorevolmente la Dottoressa Marcella Rizzo. Alla stessa dedica più di una poesia.
Di li a poco muore anche, nel 1988, Michele Pierri. Ed è nuovamente sola.
Pubblica ancora presso Vanni Scheiwiller L’altra verità. Diario di una diversa libro in prosa. Nella prefazione, il suo primo amore, Giorgio Manganelli scrive … non è un documento, né una testimonianza sui dieci anni trascorsi dalla scrittrice in manicomio. È una ricognizione, per epifanie, deliri, nenie, canzoni, disvelamenti e apparizioni, di uno spazio - non un luogo - in cui, venendo meno ogni consuetudine e accortezza quotidiana, irrompe il naturale inferno e il naturale luminoso dell’essere umano.
Questi sono gli anni in cui più si manifesta la vena lirica di Alda. Compone a getto continuo e le pubblicazioni si succedono a ritmo accelerato. Frequenta assiduamente il caffè-libreria Chimera, poco distante dalla sua abitazione, nei pressi del milanese Naviglio e fa spesso dono agli avventori di sue poesie dattiloscritte.
Premio Viareggio nel 1996 con La vita facile. Premio Procida-Elsa Morante nel 1997. Nello stesso 1997, presso l’editore Girardi, esce la silloge La volpe e il sipario illustrata da Gianni Casari. Qui una nuova tecnica di poesia. Quella orale che, a svantaggio della scrittura, sceglie appunto la forma orale di recitazione che poi, da altri viene trascritta e raccolta. Esempio, quello della Merini, per ora, rimasto unico nella poesia contemporanea. Questa tecnica porta Alda a composizioni sempre più brevi ed infine agli aforismi. Di li a poco ne comporrà oltre 500. Il meglio di questi, per la prima volta, viene raccolto in volume nel 1999 da Rizzoli Aforismi e magie, con illustrazioni di Alberto Casiraghi. Sul tema dei minitesti escono in questi anni per l’editore Michelangelo Camilliti Lettera ai figli con disegni onirici e surreali di Alberto Casiraghi, Alda Merini edito da L’Incisione con poesie inedite e disegni di Aligi Sassu.
Nel 2000, Einaudi pubblica Superba è la notte. Lungo e minuzioso lavoro di revisione su poesie composte tra il 1996 ed il 1999.
Nel 2001 posa, seminuda, per l’album Canto di Spine del complesso degli Altera che interpretano composizioni sia sue che di altri poeti contemporanei.
Inizia con il nuovo millennio la fase mistica di Alda Merini con una lunga serie di lavori tutti editi da Frassinelli L’anima innamorata 2000, Corpo d’amore: un incontro con Gesù 2001 con opere di Luca Pignatelli, Magnificat, un incontro con Maria con disegni di Ugo Nespolo 2002, La carne degli Angeli con opere inedite di Mimmo Paladino 2003, Poema della croce 2005, Francesco, canto di una creatura 2007. Questi, ed altri testi religiosi, sono stati curati da Arnoldo Mosca Mondadori che con Alda ha intessuto una seria e prolungata collaborazione.
Il primo giugno del 2002 a Roma è insignita del titolo di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il 18 marzo le era stato assegnato il Sigillo longobardo onorificenza annuale del Consiglio Regionale della Lombardia.
All’inizio del 2004, con musiche di Giovanni Nuti, viene pubblicato un album interpretato da Milva su undici testi di Alda. In occasione dei suoi settanta anni il 21 marzo, alla sua presenza, il recital al Teatro Strehler di Milano. Nell’autunno viene ricoverata al milanese Ospedale San Paolo per problemi di salute, ma soprattutto perché si trova senza una casa. È in gravi ristrettezze economiche. Qui detterà la sua autobiografia alla giornalista Cristiana Ceci. Tramite l’appello di un amico si scatena la solidarietà via Internet dove nascono numerosi siti e blog tutti richiedenti l’intervento dell’allora sindaco di Milano Gabriele Albertini. Alda ritornerà a breve nella sua adorata casa di Porta Ticinese.
Nella scia delle composizioni orali, esce nel 2005 per i tipi dell’editore Crocetti Nel cerchio di un pensiero (teatro per voce sola) raccolta che prende le mosse dalle dettature per telefono fatte dalla Merini a Marco Campedelli. 53 poesie, la maggior parte inedite, senza segni di interpunzione ne di suddivisione in versi, per rimarcarne la libera nascita e la natura orale e orfica.
16 ottobre del 2007. La Facoltà di Scienze della Formazione di Messina le concede la Laurea magistrale honoris causa in “Teorie della Comunicazione e dei Linguaggi”.
Ultimi atti della sua opera. Il genere noir con La nera novella per Rizzoli, 2006. Frassinelli pubblica ancora, nel 2008 Lettere al dottor G un libro in prosa in forma epistolare.
Nuovamente al San Paolo di Milano per un tumore osseo. Lì si spegne il primo novembre del 2009. Dopo la camera ardente del giorno 2 e del 3, funerali solenni di Stato il 4 nel Duomo di Milano.
A più riprese, senza successo, la Merini è stata candidata al Premio Nobel per la Letteratura. Molti Enti e Comitati si sono prodigati per ottenerle il riconoscimento. Tra questi l’Académie Francaise; il Pen Club d’Italia; un comitato milanese cui aderirono, tra gli altri, Dario Fo, Carla Fracci, Lucio Dalla, Paolo Bonolis, Ottavia Piccolo; il Comitato della Regione Sicilia della stessa ANPOSDI di cui fu Socia Onoraria.
3) Le opere
Nel racconto della vita di Alda, molte opere ho già riportato con gli opportuni riferimenti bibliografici. Per ragioni di spazio non è possibile trascrivere la bibliografia completa. Mi limito quindi ad alcuni tra suoi lavori più significativi.
Paura di Dio Scheiwiller, Milano 1955
Destinati a morire. Poesie vecchie e nuove Lalli, Poggibonsi 1980
Le satire della Ripa Laboratorio Arti Visive, Taranto 1983
Fogli bianchi. 23 inediti Biblioteca Cominiana, 1987
Le parole di Alda Merini Stampa Alternativa, Roma 1991
Aforismi Nuove Scritture, 1992
Se gli Angeli sono inquieti. Aforismi Shakespeare and Company, Firenze 1993
25 poesie autografe La città del sole, Torino 1994
Reato di vita. Autobiografia e poesia Melusine, Milano 1994
Ballate non pagate a cura di Laura Alunno. Einaudi, Torino 1995
La pazza della porta accanto Bompiani, 1995
Un poeta rimanga sempre solo Scheiwiller, Milano 1996
Un’anima indocile La Vita Felice, Milano 1996
L’altra verità. Diario di una diversa Rizzoli, Milano 1997
Ringrazio sempre chi mi da ragione. Aforismi di Alda Merini Stampa Alternativa, Viterbo 1997
Fiore di poesia (1951 – 1997) A cura di Maria Corti. Einaudi, Torino 1998
Vanni aveva mani lievi Nino Aragno, Racconigi, 2000
Più bella della poesia è stata la mia vita Einaudi, Torino 2004
La clinica dell’abbandono Einaudi, Torino 2004
Sono nata il 21 a primavera. Diario e nuove poesie Manni, Lecce 2005
Le briglie d’oro. Poesie per Marina 1984 – 2004 Scheiwiller, Milano 2005
Padre mio Frassinelli 2009 (Ultima opera sua)
4) Tre poesie
Luce
a G. S.
Chi ti descriverà, luce divina
che procedi immutata ed immutabile
dal mio sguardo redento?
Io no: perché l’essenza del possesso
di te è «segreto» eterno e inafferrabile;
io no perché col solo nominarti
ti nego e ti smarrisco;
tu, strana verità che mi richiami
il vagheggiato tono del mio essere.
Beata somiglianza,
beatissimo insistere sul giuoco
semplice e affascinante e misterioso
d’essere in due e diverse eppure tanto
somiglianti; ma in questo
è la chiave incredibile e fatale
del nostro «poter essere» e la mente
che ti raggiunge ove si domandasse
perché non ti rapisce all’Universo
per innalzare meglio il proprio corpo,
immantinente ti dissolverebbe.
Si ripete per me l’antica fiaba
d’Amore e Psiche in questo possederci
in modo tanto tenebrosamente
luminoso, ma, Dea,
non sia mai che io levi nella notte
della mia vita la lanterna vile
per misurarti coi presentimenti
emanati dai fiori e da ogni grazia.
12 dicembre 1949
Da Poetesse del novecento antologia curata dall’Editore milanese Giovanni Scheiwiller. (Quattro poesie di Alda Merini inserite su consiglio di Eugenio Montale e Maria Luisa Spaziani; due Il gobbo e Luce già apparse nella già citata antologia di Spagnoletti)
Sarò sola?
Quando avrò alzato in me l’intimo fuoco
che originava già queste bufere
e sarò salda, libera, vitale,
allora sarò sola?
E forse staccherò dalle radici
la rimossa speranza dell’amore,
ricorderò che frutto d’ogni
limite umano è assenza di memoria,
tutta mi affonderò nel divenire…
Ma fino a che io tremo del principio
cui la tua mano mi iniziò da ieri,
ogni attributo vivo che mi preme
giace incomposto nelle tue misure.
Ottobre 1952
Da La presenza di Orfeo Scheiwiller Milano 1953.
Toeletta
La triste toeletta del mattino,
corpi delusi, carni deludenti,
attorno al lavabo
il nero puzzo delle cose infami.
Oh, questo tremolar di oscene carni,
questo freddo oscuro
e il cadere più inumano
d’una malata sopra il pavimento.
Questo l’ingorgo che la stratosfera
mai conoscerà, questa l’infamia
dei corpi nudi messi a divampare
sotto la luce atavica dell’uomo.
Da La Terra Santa Scheiwiller Milano 1984
ALDA MERINI
Giovanni Delfino – Sergio Maria Gilardino
5) La critica
Cito solamente due lavori apparsi da poco. Ricordo che gli scritti, dedicati nel corso degli anni alla Merini, sono innumerevoli e rintracciabili su moltissime antologie di poesia contemporanea nonché sparsi su un’infinità di riviste letterarie.
Alda Merini. Poetessa punk Di Aldo Nove in Poesia. Mensile internazionale di cultura poetica. Anno XXII, Dicembre 2009 N° 244
19 poesie completano l’articolo che costituisce un ritratto fuori degli schemi usuali di Alda Merini. Purtroppo quasi tutte le poesie sono senza la data di composizione né riportano indicazione della eventuale raccolta di provenienza.
Alda Merini: in manicomio avevo trovato la felicità di Cristiana Ceci in Poesia. Mensile internazionale di cultura poetica. Anno XXII, Dicembre 2009 N° 244
Racconto autobiografico dettato dalla stessa Merini alla giornalista Cristiana Ceci nell’autunno del 2004. La Merini si trovava in ospedale più per mancanza di una casa che per malattia. Lo stesso pezzo era già apparso su L’espresso LV N° 45 del 12/11/2009
Mentre davo inizio a questo mio impegno, leggendo poesie e aforismi di Alda Merini, non molto avvezzo, come ho premesso, alla poesia odierna, mi sono posto domande e molti dubbi mi si sono presentati. Domande e dubbi ho offerto ad un caro amico, con il quale da anni collaboro in una ricerca sulla poesia piemontese. In riscontro ho avuto una personale, avvincente, profonda indagine su come possa essere definita la poesia. Una sintesi breve, ma di tutto rispetto, della poesia attraverso i secoli, le genti, i linguaggi le esperienze.
Sono certo che le considerazioni del Prof. Sergio Maria Gilardino, Docente di Letterature Comparate presso la Mc Gill University di Montreal, non meritano di rimanere archiviate nell’hard disk del mio computer, ma di essere condivise con un uditorio più vasto. E quello di Voci dialettali, mi appare ideale. Qui di seguito quindi lo scritto che, con mio sommo piacere ed entusiasmo, il Prof. Gilardino mi ha fatto così benevolmente pervenire.
6) Sergio Maria Gilardino: La poesia
La Poesia, come la Religione, è una necessità fortemente sentita dall’Uomo da tempi immemori. Non è lusso, attività oziosa o voluttuaria, ma necessità di base di ogni essere umano.
Lo so, è difficile crederlo, ma io non ho incontrato popolo sulla terra, dai più civili e sofisticati, ai più isolati e selvaggi, che non perseguisse qualche forma di poesia.
Basti dire che la Poesia è nata migliaia di anni prima della scrittura e che la Bibbia e i poemi omerici (sia la Thorà biblica che i due poemi omerici sono stati messi per iscritto 850 anni avanti Cristo) contengono tradizioni epiche e liriche, trasmesse oralmente, che li antedatano di almeno 1.000 anni, ma in alcuni casi, e per taluni avvenimenti e personaggi, anche di 2.000. Non c’è dunque epoca che non abbia tramandato la sua eredità poetica. Non c’è essere umano che non abbia mentalmente composto versi o cercato di mettere insieme parole per definire emozioni o visioni o sentimenti, senza magari poi aver mai scritto una riga.
La Poesia non si spiega razionalmente e non si definisce canonicamente (tramite l’osservanza o meno di certe regole). Quindi non c’è da nessuna parte un manuale che dica “per fare la critica di questa o quella poesia, di questo o quell’autore, bisogna fare questo o quello e poi scriverlo”. Non c’è. Ci sono valanghe di libri sulla poesia, Si possono leggere consumando gli anni, ma nessuno apre la scatola magica.
Tutto lasciato all’intuizione di chi fa poesia e di chi la legge?
No, per nulla. Ci sono degli spazi vuoti da riempire, dei codici da spiegare, dei modelli da reperire, delle cose da chiarire. La critica si fa, quando la si fa bene (come la poesia), con piena conoscenza di causa. Diventa poi una sorta di gioco a nascondino: il poeta emette versi criptici, o a tranello, il critico capisce il gioco, trova le risposte e le rende “plausibili e intellegibili a tutti”.
Il più delle volte i critici però non dicono, di un autore, in che cosa veramente è consistita la sua poesia, soprattutto perché non sappiamo in che cosa consista la “poesia”. C’è una breve composizione di Giacomo Leopardi, intitolata Imitazione. È in effetti una imitazione di una composizione altrettanto breve, in francese. Con qualche minimo cambiamento Leopardi ha dato il soffio lirico alla sua versione in italiano, mentre quella in francese non decolla. Ma perché quella in francese non è poesia, e quella in italiano sì? Capisco che siamo tutti d’accordo su questo giudizio, ma quale spiegazione, quali valori sono sottesi a questo giudizio?
Idem, Pinin Pacòt, il grande lirico piemontese, fondatore della Companìa dij Brandé, durante la sua prigionia (prima guerra mondiale) a Celle Lager, scrive una poesia, in italiano (non aveva ancora scoperto la sua vocazione più autentica, quella di scrivere versi in piemontese). La poesia s’intitola Apri la finestra, poeta. Qui a fare difetto fin dalle prime parole è la lingua: è vecchia, impotente, non autentica e uccide fin dall’inizio l’idea poetica sottesa alla breve composizione. La stessa poesia fu ripresa dopo la liberazione e dopo la scoperta del piemontese come lingua letteraria e intitolata Deurb la fnestra, poeta. È un capolavoro.
È chiaro che nel giudizio finale entrano considerazioni come l’autenticità del sentimento, della lingua, la rapidità e apparente freschezza o originalità delle visioni, delle intuizioni. E però queste cose, ed esse sole, non esauriscono il peso e la sostanza di una composizione poetica. Diciamo che sono i preliminari. Se superano quelli il resto verrà preso in considerazione.
La maggior parte dei critici letterari, davanti ad una grande produzione poetica, si limitano a collocare l’autore nello spazio poetico, sociale, culturale del suo tempo. Tracciano un quadro, un contesto e ve lo collocano: dicono in che società è vissuto, in che clima culturale ha respirato, che libri ha letto, quali grandi filosofi, poeti, creatori ha conosciuto o frequentato, quali pensieri ha espresso, a quali correnti è stato affiliato, che tecniche ha usato, a che partito politico apparteneva, che tipo di lingua ha utilizzato, per giungere alla conclusione finale classica: dato il suo ambiente, date le sue conoscenze, è riuscito con un linguaggio originale ad esprimere bene il suo mondo. E quindi è poeta. Ma anche questo non è spiegare la poesia.
Facciamo quindi un giro un po’ più ampio per capire almeno le difficoltà da affrontare.
Cominciamo subito con il dire che la poesia implica (anche nei casi più espliciti e più narrativi, senza ermetismi e senza parole misteriose) un uso molto insolito del linguaggio e della comunicazione.
Oggigiorno ci serviamo della lingua oramai solo più per messaggi o dichiarazioni fattuali: passami la forchetta, mi dia un chilo di mele, il tale ha fatto la tale cosa, sono arrivate tre casse di libri, in Sicilia tre operai sono morti per essere caduti dal tetto che stavano ripulendo, ecc.
Già Benedetto Croce in Poesia e non poesia aveva parlato dei due possibili usi del linguaggio, concetto da lui affrontato anche in Estetica ed Estetica in nuce: un uso reale (se diciamo passami la forchetta ci aspettiamo davvero che qualcuno, la persona cui ci siamo rivolti, ci passi per davvero una forchetta) e un uso estetico (la frase fa parte di un componimento in cui noi, come poeti, vogliamo raggiungere un certo risultato e non ci rivolgiamo a nessuno, non ci aspettiamo che nessuno ci passi una forchetta per davvero). Il primo uso implica dei risultati pratici, il secondo dei risultati estetici. Sempre Leopardi, nella Canzone all’Italia, quando si chiede nessuno combatte per te? e dà la risposta qua l’armi, io solo combatterò, io solo procomberò fa un uso estetico del linguaggio. In verità non c’era nessuno accanto a lui per passargli delle armi (che Giacomo, in tutta verità, non avrebbe mai saputo usare) e non intendeva davvero, come suo primo scopo, mettersi a tirare schioppettate, ma solo ottenere l’effetto di commuove e svergognare gli italiani per le ragioni che sappiamo. Il suo uso della lingua è quello estetico.
Ma vi è anche un altro uso della lingua.
Se noi prendiamo i versi della Merini:
Se qualcuno cercasse
di capire il tuo sguardo
Poeta difenditi con ferocia:
ci accorgiamo subito che queste parole non si riferiscono davvero a un vero essere umano che cercava di capire (cosa voleva dire) lo sguardo del poeta, né possono riferirsi davvero ad un vero poeta qui invitato a far uso della violenza – se necessario – per difendere il suo sguardo (metaforicamente inteso come “modo di vedere e di interpretare il mondo”, Weltanschauung insomma). La poesia è una lunghissima metafora in cui, in presenza di metafore vere o no, tutto è metaforico.
L’uso prevalentemente fattuale (e materialistico) del linguaggio dell’era contemporanea è un fatto nuovo nella storia della cultura. Non è sempre stato così e tuttora non è così in comunità isolate che ancora rivelano un uso molto più svariato del linguaggio: fiabe con animali che parlano, eroi che ritornano dal passato e parlano, formule d’incantesimo, vaticini, parole misteriosamente combinate insieme per produrre allitterazioni e omofonie, ecc. (I suonatori di guzla serbo-croati e i pupazzari siciliani, con i loro 6.000 versi a memoria, ci ripropongono il ruolo del poeta vate e incantatore ricordandoci che il mondo, migliaia di anni fa, ascoltava i loro predecessori con molta più assiduità e venerazione di quanto non si riuscirebbe a farlo oggi).
Il poeta nella società moderna è l’eccezione. In quelle primitive o antiche no. Il suo linguaggio era molto più frequente, molto più capito, molto più apprezzato, tant’è che i clan celtici scozzesi, anche in tempi di gravi carestie, avevano un filid, cioè un poeta tribale che veniva mantenuto e spesato e al quale non si chiedeva di lavorare nei campi e il cui unico scopo era di fornire poemi per feste, nozze, banchetti e guerre.
Per capire bene questo uso magico, ludico, surreale del linguaggio basta ascoltare i bambini. Non ancora astretti da una visione logica e ferrea del mondo, affidano al linguaggio visioni della realtà che – pur nella loro ingenuità – spesso confinano con alcuni degli impieghi che della realtà e del linguaggio fanno i poeti.
Non è, tanto nel caso dei bimbi, quanto in quello dei poeti, un uso ingenuo, un tantino visionario, del linguaggio, ma la coscienza che la realtà può essere vissuta a vari livelli e il loro è quello creativo: la realtà come trampolino da cui partire per costruire altre realtà, con delle leggi proprie, in cui ci si muove, si ragiona, si traggono conclusioni e si fanno constatazioni. Insomma, per paradosso, una realtà irreale che però assume gli stessi criteri di logica e di coerenza una volta che si sono accettati i criteri iniziali (gli animali che parlano o gli uomini che volano o esseri che scendono nell’oltretomba, e via dicendo).
Vi sono altre due cose che bisogna tenere presenti per capire lo scarto esistente tra poesia ed uso quotidiano, pratico e logico, della lingua.
La prima è che il linguaggio possiede caratteristiche musicali e ritmiche che non sono più sfruttate oggigiorno, ma che sono sempre latenti in ogni parola, nei suoi suoni e nella capacità di quei suoni di evocarne altri, come le corde di un pianoforte – percosse – ne fanno vibrare altre per “simpatia”. Noi non sappiamo come è nata la lingua, ma sappiamo che dietro alle parole vi sono non solo i campi semantici limitati (quelli del dizionario), ma anche altri che possono essere evocati, magicamente. L’uomo di migliaia di anni fa sfruttava molto di più questa potenzialità del linguaggio.
La seconda è che la capacità del cervello umano di proiettare la sua immaginazione ben al di là della realtà (l’insieme delle cose e della logica, dinamica, fisica, chimica, meccanica, cinetica delle cose) e di creare mondi surreali in cui il poeta si catapulta. Qui il poeta può mettersi a considerare questa “realtà” del tutto artificiale da lui creata, ma non per questo meno interessante (anche i cervelli dei lettori sono spesso in grado di seguirlo, di accettare il nuovo codice e di “stare al gioco”) ed emettere considerazioni ironiche, tragiche, paradossali, sulla propria persona libera dalle restrizioni della realtà reale, terrena, ottusa, meccanica.
L’insieme delle affermazioni fatte dal poeta sulla scorta della libertà del linguaggio (assonanze, allitterazioni, rime, ritmi, colori, accentuazioni, metri, ecc.) e della libertà dell’immaginazione (proiezione in mondi da leggi pure ferree, ma illimitati) costituiscono il tessuto della poesia contemporanea.
Bisogna dunque avere presenti queste considerazioni per affrontare la lettura poetica.
Ora passiamo a considerare due altri aspetti, quello della libertà di composizione e quello della centralità del messaggio poetico: l’uomo al centro di tutto.
Fino alla fine del Settecento - inizio Ottocento non era lecito inventarsi una storia per scrivere un romanzo o una composizione poetica. Chi scriveva doveva dichiarare di scrivere una “storia vera”. Lo fa anche il Manzoni all’inizio de I promessi sposi affermando di aver rifatto una storia che lui avrebbe trovato da qualche parte. Non si capiva che l’immaginazione, una volta fissati dei paletti, poteva prospettare situazioni molto più interessanti od avvincenti di quelle tratte dalla realtà osservata.
È stato solo con l’avvento del realismo - verismo che la letteratura si è emancipata per sempre dalla schiavitù alla realtà e creato personaggi memorabili che hanno finito per esistere nella mente dei lettori meglio e più delle persone vere da essi conosciute.
La poesia ha tratto molto più profitto di qualsiasi altro genere letterario da questa liberazione: tutto nel poeta contemporaneo è liberazione da qualsiasi obbligo a storie vere. Addirittura non è più tenuto a dare gli antecedenti: scrivono presupponendo che il lettore si cali immediatamente nella situazione e intuisca (o, comunque, riempia i vuoti) cosa è successo prima. Quando già Foscolo scrive: Né più mai toccherò le sacre sponde, egli esige che il lettore provveda da solo a riempire gli spazi narrativi che mancano (perché non potrà tornare, che cosa è successo, chi è il poeta che scrive). Questo saltare a pie’ pari gli antecedenti permette al poeta di occuparsi solo del momento apicale, cioè del momento più produttivo – come emozioni – e quindi più redditizio in termini di risultati lirici.
Il poeta contemporaneo, dall’ermetismo in poi, ha portato questo presupposto all’estremo, a tal punto che ogni verso, o paio di versi, richiedono tutto un lavoro molto intuitivo per riempire gli spazi narrativi che mancano. È la tecnica romantica del Bruckstück (frammento) portata all’estremo.
Perché?
Semplicissimo. La poesia vera è intelligenza, sapienza e comprensione del mondo e dei complessi rapporti tra individuo e società, individuo e realtà, individuo e umanità, ecc. Ripeto: i grandi poeti sono dei grandi pensatori. Capiscono un sacco di cose che le persone ordinarie non vedono. Le capiscono per osservazione diretta (contemporanea) o per riflessione sul passato (diacronica). Passato e presente spesso si incrociano e si fertilizzano. Arrivano a fare tutta una serie di considerazioni che ci stupiscono (quando riusciamo a decriptarle).
Ci sono poi anche i poeti falsi, quelli che imitano modi e forme, ma non sanno dar vita alle loro composizioni perché non sono dei grandi pensatori, non sono intelligenti, non sono portatori di novità. Imitano e basta: petrarchisti, arcadi, Minnesänger, ecc. E più ci avviciniamo all’era contemporanea, più il giochetto di pittori, scultori, poeti che imitano diventa facile, perché l’arte contemporanea ha rinunciato ai grandi affreschi, alla materia scolpita magistralmente, ai versi tradizionali con rime e ritmi. Il tutto si gioca su un’idea geniale, come Picasso che vede un vecchio manubrio di bici da corsa e una vecchia sella, li lega insieme con un fil di ferro e ci scrive sotto Cabeza de toro (Testa di toro), creando un capolavoro che oggi è al Guggenheim. Facile imitare un’arte così, ma difficilissimo riempirla con emozioni altrettanto autentiche.
Nell’arte contemporanea l’artista non è tanto il tecnico, ma l’ideatore, l’intuitore, il pensatore. La tecnica che poi usa per esprimere l’intuizione nell’arte moderna è di secondaria importanza, mentre era prioritaria e fondamentale nel Rinascimento e fino ai primi del Novecento. È questa la differenza tra la poesia alla Carducci, tutta rime e ritmi e parole classiche, e la poesia alla Ungaretti, che si regge su versi brevissimi e composizioni ancora più brevi (Mi illumino d’immenso). Pochi però sanno che per arrivare a quella poesia di un solo verso Ungaretti è passato per moltissime redazioni, via via più brevi, sull’arco di molti anni. Con il Novecento l’arte come magistero di forme esterne è finita: si privilegia l’uomo, al quale si chiede di essere veramente grande e originale, ma il trapasso dall’idea all’arte è sempre intuizione pura per chi crea, mistero per chi critica.
La poesia infine è la sola disciplina che non parli di cose esterne all’uomo (come lo fanno la fisica, la matematica, l’architettura, ecc.), ma parli dell’uomo, nell’uomo, per l’uomo. La poesia deve rendere oggettivo quello che è soggettivo (lo stato d’animo, l’intuizione fugace, l’emozione, il sentimento). Il pericolo costante e l’ostacolo sul quale naufragano milioni di poetucoli è la banalità. L’idea, l’emozione, la visione che hanno avuta era forte e autentica, ma nel momento in cui la mettono per iscritto diventa banale e non possiede più la luce, la forza, che aveva nella loro mente. Solo pochi grandi geni riescono a rendere oggettivo (cioè valido per tutti) quello che è soggettivo: Pushkin, Leopardi, Byron, Goethe ci sono riusciti in ogni verso che hanno scritto.
Perché?
Non sappiamo esattamente perché, ma sappiamo una cosa: la prosa è analisi, la poesia è sintesi. Estrema sintesi. La prosa amplifica ed analizza, la poesia concentra e sintetizza. Il grande lirico è così per natura, per disposizione mentale: vede, si chiede, si spiega, si esprime. Il prosatore include, il poeta sceglie.
Da questo punto di vista, se si tengono in mente queste dinamiche e se si è storicamente smaliziati (si conoscono gli stili poetici nel corso dei secoli) spiegare la poesia di Saffo o quella della Merini è la stessa cosa. Cambiano le lingue e i tempi, ma non la dinamica interna, non i moventi, non la capacità sintetica.
Geniale, felice, sempre ispirata, ironica, tragica, grande. È una grande poetessa. È un genio autentico. Sergio Maria Gilardino
…mi trovo davanti ad un gigante dell’arte e della saggezza poetica, non meno di quanto Emily Dickinson lo sia stata nell’Ottocento. Da bravo lettore pieno di pregiudizi l’eccellenza poetica la cercavo al maschile: la possibilità che un’anima malata, ma dalla mente così lucida, così rapida, così tagliente, potesse arrivare tanto facilmente a spalla alle vette della grande lirica europea, dalla Generation de 98 (Miguel de Unamuno, Juan Ramon Jiménez), alla felicissima stagione parnassiana francese, da Rainer Maria Rilke a Alexander Block, e per di più con un discorso, uno stile tutto suo, tutto spontaneo, tutto perfetto fin dalla prima dichiarazione, non mi era nemmeno venuta pel capo.
Sono certo che analizzando più da vicino il mondo, le visioni, le constatazioni e, di tutto ciò, la realizzazione in composizioni poetiche si potrebbero trarre importanti conclusioni sulla poesia nel 900: avvicinando cioè la Merini non tanto ai poeti italiani del secondo Novecento, ma ai grandi lirici americani, inglesi, europei dello stesso periodo capiremmo meglio che grande personalità è stata Alda Merini in prospettiva comparatistica. Sergio Maria Gilardino
(Brani tratti da due lettere a me inviate dal Prof. Sergio Maria Gilardino in data 2 e 3 gennaio 2010.)
7) Sei poesie
Due poesie per Q
I
Padre che fosti a me, grande poeta,
bene ricordo la tua cetra viva
e le tue dita bianche affusolate
che varcavano il solco del mio seno.
E io ricordo tutto, le bufere
i venti aperti e quella confusione
che trovava la nostra poesia.
Parlavamo il linguaggio dei poeti
casto, accorato senza delusioni
o eravamo delusi di noi stessi
poveri, confinati nello spazio
come astronauti sulla stessa luna.
II
M’avessi amato tu nella penombra
invece che nel caos primordiale
delle stelle cadenti, me protratta
m’avessi presa dritta nelle spalle
con uno strale d’armi vorticoso.
Invece tu d’amore m’incendiasti
là sopra i ghetti, a Porta Garibaldi,
come avessi la veste di chiazzata
gitana oppure donna malvestita
e vestita d’obbrobri. Oh ci voleva
così poco per te ch’eri poeta
darmi una ghianda d’oro e un soffio puro.
Invece a me porgesti le gomene
e i covoni di marzo e fummo due
arieti spinti dalla stessa fune.
Da Il volume del canto iniziato nel 1979, inedito, pubblicato in Vuoto d’amore a cura di Maria Corti, Einaudi Torino 1991.
Alda Merini
Amai teneramente dei dolcissimi amanti
senza che essi sapessero mai nulla.
E su questi intessei tele di ragno
e fui preda della mia stessa materia.
In me l’anima c’era della meretrice
della santa della sanguinaria e dell’ipocrita.
Molti diedero al mio modo di vivere un nome
e fui soltanto una isterica.
Da La gazza ladra Venti ritratti. 1985. Raccolta inedita, pubblicata da Maria Corti in Vuoto d’amore, Einaudi Torino 1991.
Per Milano
Non è che dalle cuspidi amorose
crescano i mutamenti della carne,
Milano benedetta
donna altera e sanguigna
con due mammelle amorose
pronte a sfamare i popoli del mondo,
Milano dagli irti colli
che ha veduto qui
crescere il mio amore
che ora è defunto.
Milano dai vorticosi pensieri
dove le mille allegrie
muoiono piangenti sul Naviglio
Milano ostrica pura
io sono la tua perla,
amore.
Da Poesie per Marina. Raccolta inedita, 1987 - 1990, pubblicata da Maria Corti in Vuoto d’amore, Einaudi Torino 1991.
Alla mia cara Marina Marina, tu sei giovane, ma pensa un po’: per pochi denaripercorrere tante strade.Dirò come dice Michele Pierri,che la poesia è una grande puttanae che tra me e Quasimodola vera puttana d’amore fu solo quella.Io mi sento tale Marinacostretta a chiedere poco argentoin cambio di voli doratidi frustrazioni degeneri,mi sento una terra devastatauna terra su cui camminano tutti.Marina, grazia diversavedi, tu sei come una reginail tuo trono è la tua volontàio sono la tua vassallasoltanto perché ho un genere diverso di vitasoltanto perché hai uno scettro profondoche a volte mi si sprofonda nel cuore,soltanto perché sei giovane e bella,come una dea, tu decidi della sorte disumana degli uomini.
Da Poesie per Marina. Raccolta inedita 1987-1990, pubblicata da Maria Corti in Vuoto d’amore, Einaudi Torino 1991.
A Vanni Scheiwiller
Su quel treno di Taranto, infinito,
ove guarirà l’ombra della mia giovinezza
io tornerò un giorno.
Tornerò, Vanni, dall’amore che ho perso
tra gli ulivi gaudenti della terra,
tornerò presso il suo vecchio corpo…
Fin qui, Vanni, non ho vissuto che un anno
di perduto dolore:
e quando il sole mi guariva le tempie,
o Vanni, io pregavo il Signore
che mi facesse morire con lui.
Ma su quel treno di Taranto, grigio
più del martirio più duro,
più dell’ospedale di Affori,
un giorno io tornerò a sentire la salsedine
pura,
le ombre cupe dei morti
le tradizioni dei vinti
l’avallo delle stagioni.
Tornerò, Vanni, a redimere il dolore di sempre
quello che mise radici lontane,
tu sai…
I folli sacramenti
onde si imbandivano feste oscure
negli antri dei manicomi
e il tripode lontano di una bibbia immalinconita
e i sensi che ti davano la profonda vertigine
e il mare cupo come il senso di colpa,
ahimè così lontano
e così vicino al mio corpo.
Ma io, Vanni, tornerò in quel golfo e per te e per me
e per tutti quanti hanno vestigia divine:
Afrodite d’oro mi rincorre le tempie
nei giorni del mio furore.
Ma qui come la ninfa selvaggia che brama le acque
ho messo il piede nello stagno più puro
e invece dell’acqua era sangue
era sangue di amore,
e ne uscii dormiente nella parola
ne uscii dormiente nei miei lunghi capelli
ne uscii smemorata dell’infelice canto
che aveva chiuso il giglio di Orfeo,
magnifico esecrando padrone
della mia giovinezza.
O Vanni, l’ebbrezza dei sensi
cambia il velo dell’eterna armonia:
tornerò da lui, da te
io tornerò a morire.
Da Poesie per Marina. Raccolta inedita 1987-1990, pubblicata da Maria Corti in Vuoto d’amore, Einaudi Torino 1991.
8) Aforismi
La pistola che ho puntata alla tempia si chiama Poesia
Non sono una donna addomesticabile
La casa della Poesia non avrà mai porte
Io amo perché il mio corpo è sempre in evoluzione
Per farsi salvare la vita bisogna averla
Io amo ciò che non si dice
Dio ci regala il sonno per vincerci il giorno dopo
Chi è prigioniero diventa potenzialmente libero
Ho avuto trentasei amanti più IVA
Bussate e vi sarà chiuso
Sono piena di bugie ma Dio mi costringe a dire la verità
I fiori della mia bronchite sono le mie sigarette
Sono la donna più casta della letteratura italiana
Quando la bugia sembra vera nasce la calunnia
Ho cominciato a piangere per gioco e poi ho creduto che fosse il mio destino
Si impara a vivere quando si impara a morire
La pazzia mi visita almeno due volte al giorno
Da anni indago sul caso Merini
Anche la follia merita i suoi applausi
Non mi vanno le lapidi perché mi peserebbero troppo
Da Aforismi e magie Rizzoli Milano 1999.
Piemontèis ancheuj Ann XXXIII N° 7/8 Luj/Agost
Alex Alexis alias Luigi Alessio
Luigi Alessio nasce a Caramagna Piemonte, Cuneo, l'otto maggio del 1902 e muore sempre nella sua natia Caramagna il cinque aprile del 1962).
Nato da agiata famiglia borghese, rimane orfano a nove anni e viene allevato a Torino da un nonno materno. Nelle pagine introduttive del suo romanzo In grigio e in nero descrive il triste ambiente della sua infanzia.
Nel 1920 abbandona gli studi per raggiungere Fiume e partecipare agli ultimi atti dell'impresa dannunziana. Rientrato a Torino si iscrive all'Università di legge che poi non terminerà.
Luigi Alessio, o Alex Alexis, inizia la sua avventura letteraria scrivendo moltissimo e vivendo tra Italia e Francia. (Drammi, romanzi, poesie, saggi storici, traduzioni, commedie, corrispondenze giornalistiche, soggetti per film).
Nel 1923 fonda a Torino la rivista Teatro, uno dei primi periodici al teatro appunto dedicati, qui da spazio ad autori emergenti, italiani e stranieri, guadagnandosi molte amicizie letterarie. Sempre a Torino fonda una casa editrice Rinascimento dove stampa romanzi, opere teatrali, raccolte di novelle.
Nel 1926 cede ad una casa editrice milanese la rivista. Nuova impostazione ed altra veste ne segneranno una rapida fine.
Dal 1927 al 1939 è a Parigi dove, nel 1934, fonda la sua nuova casa editrice Les Editeurs Associès. Con quest’ultima casa editrice inaugura un nuovo sistema di diffusione del libro, stampando ad altissima tiratura e vendendo le copie ad un prezzo molto basso, sia pur con un piccolo margine di guadagno, direttamente alle bancarelle parigine. Casa editrice che poi cede, nel 1935, per paura di essere troppo assorbito dalla nuova attività e non aver più il tempo per la composizione delle sue opere.
Nel 1939 è ancora a Caramagna, poi a Torino e a Roma. Incontra molti momenti di difficoltà sia economica che di salute. Durante la guerra, per sbarcare il lunario, fa il finto corrispondente dal fronte, scrive sceneggiature e biografie, con adattamenti radiofonici collabora anche alla radio.
Dal 1945 è a Milano, su incarico dell’amico scrittore ed editore Gian Dàuli, per la casa editrice Lucchi di Milano, compila una biografia di Mussolini raffazzonandola da scritti altrui, opera che verrà poi data alle stampe sotto il nome di Gian Dauli.
Ritorna nella sua Caramagna nel 1946, bussa a molte porte ma non riesce a far pubblicare nulla di suo.
Dal 1947 è nuovamente a Parigi. Scrive articoli per la rivista Le diable rouge. Uno in particolare, del gennaio 1945, è dedicato alla letteratura piemontese e al suo amico e concittadino Luigi Olivero: Luigi Olivero ou de la céleste anarchie. Questo articolo verrà poi pubblicato, lo stesso anno, sulla rivista di Olivero Ël Tòr N° 9-10 Roma, poi ripreso, con qualche modifica per attualizzarlo, in particolare nella parte riguardante la letteratura piemontese, come prefazione alla raccolta poetica di Olivero Ij faunèt del 1955.
Ragioni di salute, ma anche finanziarie, lo spingono, nel 1952, a rifugiarsi al mare di Latte, presso Ventimiglia, a due passi dal confine. Qualche traduzione ma, in particolare, l'aiuto di amici gli permette di sopravvivere.
Nel 1960 rientra nella sua Caramagna, Lo ritroviamo molto ingrassato, con le gambe che quasi più non lo reggono, l'asma che non gli da respiro, in una piccola e vecchia casa colonica che la carità del paese gli ha messo a disposizione. Qui lo accompagna una certa perdita di lucidità e la sua grave insofferenza per lo stato in cui si trova. Viene ricoverato al Cottolengo di Torino. Qui, forse, i medici avrebbero potuto ridargli un poco di salute, ma ancora la sua insofferenza lo porta a lasciare l'ospedale per rifugiarsi, sempre a Torino, presso le figlie, ma, presto, fa ritorno a Caramagna. Continua, per quanto la salute glielo permette, a lavorare di cesello sulle sue opere ancora da pubblicare e a riempire pagine e pagine con i suoi pensieri. Nuovo ricovero in ospedale a Caramagna dove muore dopo pochi mesi colpito da una sincope. È il 5 di aprile del 1962.
Fu il primo traduttore, nel 1933, del Voyage au bout de la nuit di Louis Ferdinand Celine. Rispetto all'edizione originale l'Alessio stempera, sia eliminando che modificando i termini più volgari e le più esplicite allusioni sessuali. Tradurrà ancora nel 1938, ad appena un anno dalla sua pubblicazione in Francia, Bagatelle pour un massacre. Anche questa volta interviene l'opera censoria, vuoi compiuta direttamente dal traduttore, vuoi per richiesta esplicita dell'editore, vuoi per l'intervento diretto di qualche gerarca di turno. A titolo di esempio ecco alcuni dei brani soppressi:
Tutte le fighette, Ferdinand, tutte vogliono sbattersi i giudei ~ Siamo in pieno fascismo ebreo ~ La politica del Vaticano è sempre a favore della giudaglia.
Tradurrà, sempre di Celine, L’ècole des cadavres che non è stato all'epoca pubblicato. In italiano verrà dato alle stampe nel 1997 con il titolo La scuola dei cadaveri dalle Edizioni Soleil di Santa Lucia di Piave (Treviso) nella Collana del Nibbio. Non viene citato il traduttore (dovrebbe trattarsi di Gian Paolo Ritze con Manuela Mongia) e non ho idea se nella traduzione si sia potuto attingere o meno da quella dell'Alessio.
Sergio Luzzato, nel suo saggio Bagatelle della critica apparso sul Sole 24 ore dell'otto novembre 2011, così si esprime a proposito di Luigi Alessio:
Alex Alexis era il nom de plume di tale Luigi Alessio, un trentenne piemontese emigrato a Parigi che la polizia segreta del Duce, sempre a caccia di cospirazioni da smascherare, considerava vicino agli ambienti di Giustizia e Libertà, ma che più banalmente cercava di sbarcare il lunario secondo la vecchia tradizione della bohème letteraria attraverso collaborazioni editoriali pagate un tanto alla pagina.
La bohème è di destra o di sinistra? In realtà, l'internazionale della Parigi anni trenta - un sottobosco poligrafico di immigrati italiani, russi, ebrei, tedeschi, spagnoli, ungheresi - condivideva passioni più che idee e pulsioni più che progetti. Non tutti potevano essere, né erano, Carlo Rosselli o Walter Benjamin. I precari della penna di cui Alex Alexis faceva parte somigliavano piuttosto a Ferdinand Bardamu, l'eroe autobiografico di Céline: vivevano meno di valori politici che di espedienti quotidiani, meno di speranza nel riscatto che di vertigine della negazione. Viaggio al termine della notte li rappresentava pienamente, ma in un senso che nulla aveva di fascista. Tanto è vero che l'arbitra del gusto nell'Italia mussoliniana, Margherita Sarfatti, non aveva atteso la traduzione del Corbaccio per denunciare nel primo libro di Céline la nichilistica quintessenza del non fascismo. Insomma, chi segua il filo di Alex Alexis e del Céline uno e indivisibile degli anni Trenta si ritrova in un mondo ni droite ni gauche assai più complicato di quanto non si vorrebbe oggi vederlo alla luce del politicamente corretto. È il mondo stesso delle edizioni Corbaccio, dove un imprenditore coraggioso come Enrico Dall'Oglio e un editor sensibile come Gian Dauli pubblicavano Arthur Schnitzler, Thomas Mann, Jakob Wassermann, Stefan Zweig, Alfred Döblin, Italo Svevo, insieme con il Lion Feuchtwanger di Süss l'ebreo e con il Céline del Viaggio e poi delle Bagatelle per un massacro. Fino al paradosso editoriale e politico della primavera 1938, quando proprio il Corbaccio entrò nel mirino della «bonifica libraria» di regime per una sovrabbondanza in catalogo di autori di «razza ebraica», ma il medesimo Corbaccio pubblicò il pamphlet abominevolmente antisemita di Céline tradotto da Alex Alexis.
Traduttor non porta pena: sette anni dopo - nell'Europa del 1945 liberata dal nazifascismo - Luigi Alessio sarebbe riuscito ancora a vivacchiare dentro la bohème letteraria di Milano. stampando sotto pseudonimo libri da bancarella sul Mussolini di Piazzale Loreto e sulle gambe di Claretta Petacci; mentre l'autore delle Bagatelles avrebbe dovuto percorrere fin dentro il marcio di Danimarca un terribile cammino di espiazione senza redenzione. (2)
Ancora sul Sole 24 ore del 14 dicembre 2011, Massimo Raffaeli, nell'articolo Céline, scrittura e vita, occupandosi del saggio di Riccardo De Benedetti Céline e il caso delle "Bagatelle" Medusa Mondadori, Milano 2011, a proposito di Luigi Alessio:
...in particolare nel terzo capitolo, De Benedetti opera un confronto fra la versione di Pontiggia e quella precedemnte, uscita nel 1938 dal Corbaccio, solo pochi mesi dopo la princeps francese nel doppiaggio di Alex Alexis (pseudonimo di Luigi Alessio, un fascista piemontese cui si deve la prima traduzione in assoluto del Viaggio al termine della notte - ancora da Corbaccio, già nel 1933): qui è però sorprendente rilevare che l'antisemita Céline aveva visto scorciato di un terzo il suo libello dal censore littorio, giusto nell'anno delle leggi razziali, con la caduta in blocco del lessico scatologico-blasfemo e l'epurazione di qualunque riferimento al Papa Pio XI, come a Benito Mussolini e Hitler, tutti quanti sospettati di eccessiva indulgenza nei confronti degli ebrei ovvero di ascendenze e/o connivenze giudaiche. (2)
Su Tiro libero N° 0 della primavera del 2011, Ernesto Ferrero, traduttore nel 1992 del Voyage, con il suo articolo Confesso: ho tradotto Céline e lo rifarei, ci fornisce qualche altra notizia dull'Alessio:
Sono passati vent'anni da quando ho tradotto per il risorto Corbaccio il Voyage au bout de la nuit di Louis Ferdinand Céline. Giusto sessant'anni dopo la versione di Alex Alexis, alias Luigi Alessio, polimorfo letterato, drammaturgo, giornalista, editore cuneese. già legionario fiumano con D'Annunzio, che nel 1927 aveva tentato la fortuna a Parigi, conducendo a Montparnasse un'esistenza da bohémien in mezzo a irregolari devianti d'ogni tipo e Paese.
A me hanno dato sei mesi di tempo, a lui la metà. Ma l'avventuroso Alessio
non ha dovuto lottare soltanto contro il tempo tiranno. Si è ritrovato in una situazione addirittura drammatica, perché non aveva una lingua in cui trasporre le novità perturbanti dello stile di Céline; o, se anche se la fosse inventata, non sarebbe stata accettata, in primis dal pur bravissimo editore Enrico Dall'Oglio, il più lesto a capire, con l'aiuto di Gian Dàuli. le qualità di quel capolavoro; e poi dal pubblico, abituato a ben altri standard stilistici. ...
Gilberto Tura, sul WEB, in data 14 maggio 2009 pubblica Gian Dàuli e Alex Alexis: la prima traduzione italiana del Viaggio al termine della notte. L'articolo non riporta novità rispetto a quanto già riportato. Interessante però, in calce, quanto scritto da un lettore a proposito della traduzione Alexis e di quella Ferrero:
Ho provato a leggere Ferrero, dopo Alexis. Non ho provato emozioni, la lingua è secca e stoppacciosa. Alexis, pulito di certi forse inevitabili toscanismi, per il mio palato ha fatto una traduzione egregia, imbattibile. Alla prima lettura, tre anni fa, il suo Viaggio cambiò il mio modo di intendere la scrittura. (Postato il 9 settembre 2010 ore 18.36)
Concludendo, vivendo al confine tra due culture, Luigi Alessio, Alex Alexis, non è citato, neppure di sfuggita, né tra gli indici bibliografici, né nelle storie letterarie anche se meriterebbe, forse, una maggiore considerazione.
Bibliografia:
La casa dei ricordi (dramma) Torino 1925.
L’incendio della foresta (dramma in 3 atti) A. Formica Torino 1930.
In grigio e in nero (romanzo) A. Formica Torino 1931. Tradotto in francese, ma non pubblicato, con titolo Les jours sombres.
Tu seras reine (romanzo) Les Editions Montparnasse 1931.
Piccola sirena (romanzo) Nicolli Milano 1935.
Amours a Montparnasse: souvenirs d'un montparno. Couverture illustrée par Odette Elina (romanzo) Parigi Ferenczi 1936 (Traduzione italiana: Amori a Montparnasse De Luigi Editore Roma 1945).
Bismark Corbaccio Varese 1939.
Dizionario dell’argot Torino 1939.
Storia del lavoro Corbaccio Varese 1940.
Pitagora Corbaccio Varese 1940.
Anime di esiliati (romanzo) con prefazione di Clemente Fusero, Modernissima Milano 1946.
Inediti
Les années du cauchemar (romanzo).
Chansons bohèmes (liriche).
Ancora un Balzac, quasi una sceneggiatura cinematografica, quattro romanzi, una Storia del costume, e ancora commedie e soggetti cinematografici.
Traduzioni
Louis Ferdinand Celine Voyage au bout de la nuit, Bagatelles pour un massacre, L’école des cadavres.
Arnould Galopin Il mostro (romanzo)
Edward Stilgebauer I giorni rossi (romanzo)
Maria Vinitzine Nella tormenta (romanzo della rivoluzione russa)
Hans Winter Medici e avvelenatori del XVII secolo
Nota
1) Notizie tratte da una lettera di Clemente Fusero del 30 novembre 1966 diretta a Michel David. In Opera Aperta N° 8-9 Roma 1967.
2) Luzzato e Raffaeli, come si può evincere dai due brani stralciati, danno un giudizio politico dell'Alessio diametralmente opposto.
Piemontèis ancheuj (11 puntate successive tra marzo 2014 e febbraio 2015)
Piemontèis ancheuj, Ann 32 N° 3 mars 2014~Ann 33 N° 2 fërvé 2015
Pinin Pacòt tra poesia, prosa ed editoria
dal 1926 al 1938
Pinin Pacòt (Giuseppe Pacotto) nasce a Torino il 20 febbraio del 1899. Giovanissimo inizia a comporre poesie, prima in lingua, quindi in piemontese.
Nel 1926, primo anno preso in rassegna in questo mio studio, Pinin Pacòt pubblica la sua prima opera poetica Arssivoli nella Colaña Piemônteisa dla Testa 'd Fer.
La raccolta è preceduta da uno studio di Nino Costa:
Per tutte le arti, ma specialmente per la poesia, la difficoltà maggiore e la qualità che più conta è l'essere sè stessi. Ora ecco finalmente un poeta che non ci ricorda un altro poeta: Giuseppe Pacotto, colui che, abbandonate le vecchie consuetudini della poesia dialettale, cerca nella infinita sinfonia della natura e del cuore un suono che sia tutto suo. ...
Ricercatore di gemme dialettali è Pacotto, amatore di vecchi testi, e più specialmente innamorato della canora lingua d'oc: trasognato e sperduto felibre, che insegue una visione trovadorica tra il rombo ultramoderno d'una 509 e il via vai farraginoso della nuova composita e dissonante popolazione torinese.
Egli giunge alla poesia dopo uno studio accurato della sua lingua: si è foggiato lo strumento. Non è più l'improvvisatore o il tôrôtôtela, ma sente di essere, o di poter essere col tempo, l'artista. Questo volume che egli licenzia, «Arssivoli», gli rassomiglia.
Non è poesia popolare, anzi a rigor di termini non è neppure poesia dialettale. Intendiamoci però, poesia dialettale corrente, poichè io non credo esistano limiti per nessuna poesia e tanto meno per la poesia dialettale.
Intanto è poesia: Incerta ancora, a contorni non perfettamente definiti, quasi come velata di brume, simili a certe albe torinesi, quando il profino dei colli, appare ammorbidito e sfumato dalle nebbie, e si direbbe quasi che sorga a poco a poco da un'atmosfera di sogno. ...
Ora una nuova luce balena da questi «Arssivoli». Sarà lo splendore di un nuovo astro che sorge, o il bagliore improvviso di un aerolito trasvolante nella notte d'agosto? A Pacotto, poeta, la risposta. Non basta incominciare bene, occorre perseverare con tenacia, con passione e con dolore.
Ora il fiore di quella che sarà la poesia di Pacotto è sbocciato, col tempo sarà la reusa dësbandija. Egli ci ha dato in questo primo volume una fragrante fioritura primaverile; attendiamo da lui la messe d'oro.
Il volume, di 112 pagine è dedicato a Marco Lessona che, prim, a l'à môstrame lon ch'a l'era pôesia. In tutto 40 poesie di cui una Bel sivaliè presentata anche con le note scritte da Marcello Boasso. Presenta anche un buon numero di belle incisioni, non firmate e di cui non si da conto.
Nel 1926 Pacòt detta la prefazione alla raccolta di poesie Freidôliñe del poeta langarolo Oreste Gallina pubblicato nella stessa collana di «Arssivoli»:
C'incontrammo la prima volta a Parma: Parma, la vecchia città ducale, piena di silenzi e di ricordi, dal grande parco abitato d'ombre, ove la sera sognavamo dolcissimi convegni di dame e cavalieri; Parma, dai grandi palazzi austeri e sonnolenti, risvegliati improvvisamente dal rintronare dei passi in cadenza sotto gli atri profondi.
Gallina, l'occhio vivissimo sul bronzo del viso incoronato dalla folta chioma corvina, portava dai campi che lo videro nascere quella naturale sicurezza, ingenua e disinvolta, che dà la terra ai suoi figli; io, dalla città piena di multiformi artifizi, la mia timidezza. C'incontrammo e diventammo amici. Allievi ufficiali nella stessa compagnia, passammo insieme i mesi di corso, inondando di sogni e di canti la triste monotonia della vigilia di guerra.
Ricordi, Oreste, le lunghe marce, sotto il dardeggiare del sole, per la campagna emiliana, attraverso alla densa e rigogliosa vegetazione, dal fogliame stancamente accasciato nella calura? Ricordi le interminabili esercitazioni, l'ordine sparso agile e snodato, il solenne e coreografico ordine chiuso, sul greto arso e infocato del torrente sotto la canicola d'agosto? Ricordi? In quelle ore monotone e pesanti, in quella fatica estenuante ci era conforto l'eguale sogno, la comune aspirazione, lo stesso amore per il Piemonte lontano e per la poesia; e allora la poesia, informe e spontanea, fluiva a ondate dai nostri cuori, e nelle nostre parole, per quanto povere e umili, era sempre un riflesso luminoso del nostro sogno di bellezza.
Le diverse destinazioni ci separarono; subimmo la stessa sorte, e ritornati, dopo l'immane tragedia, dagli squallidi Kriegsgefangenenlager, ci ritrovammo, fedeli sempre allo stesso sogno e con lo stesso amore.
(Annone d'Asti, Agosto 1926)
Ij Brandé Arvista Piemontèisa
Le idee e i sentimenti espressi da Pacòt in questa prefazione, portano, l'anno successivo, con l'amico Gallina e con un altro amico di Pinin, Alfredo Formica, editore e scrittore, al primo di marzo del 1927, quando i tre danno alle stampe il primo numero de Ij Brandé Arvista piemontèisa. L'iniziativa, per questioni amministrative, in parole povere il vil denaro, si ferma, purtroppo, con il quinto numero.
Questo primo fascicolo contiene la dichiarazione d'intenti dei tre che si firmano Ij Brandé:
I scrivouma 'l piemonteis perchè ch'i lou parlouma, e i lou parlouma e i lou scrivouma pròpi 'd cheur, ades ch'a smija ch'a vada perdendsse, dëspresià e dësmentià da jë stess piemonteis ch'a lou arnego.
Sa l'è vera ch'a staga per meuire, e bin, noui i vorouma nen ch'a meuira! Coun tut nòst sentiment e coun tuta nòstra fòrssa i s'oponouma.
Nòstra arvista, pcita e pòvra couma ch'a l'è, a nass apòsta per difendlo, nòst parlè e con chiel nòstra tradissioun, nòstra stòria, nòst caràter, perchè noui, italian e piemonteis, i savrouma esse 'd boun italian quand ch'i l'abio 'mparà a esse 'd boun piemonteis.
L'è sòn lòn che noui i vorouma: salvè nòst parlè. Salvelo sercand ëd rendje soua finëssa e soua fòrssa, soua serietà e soua blëssa, sercand ëd rendje sò patrimòni 'd paròle e d'espressioun nostrañe, sò found d'ideje e 'd sentiment piemonteis. E parei, senssa tema e senssa gena, i sercrouma 'd fé arvive le veie paròle bele ch'a peusso smijene dròle, perchè ch'i l'avijo desmentiaje: i finirouma per arconòssie e i tornerouma a sentije nòstre, naturale e frësche couma 'nt ël linguagi ch'a parlavo i nòstri vej, piemonteis ëd na vòlta, travajeur an pas e coragious an guera.
Senssa blaga, a l'è coust 'l dover ch'i s'imponouma, sperand che l'aprovassioun e l'agiut 'd coul ch'an capisso, a peussa permëtne dë riesse an cousta nòstra fatiga.
I Brandé
Come ben si può vedere da questo scritto, la grafia non è ancora quella unificata che verrà adottata di lì a poco e di cui mi occuperò in seguito.
La prima pagina dell'Arvista, contiene anche un articolo a firma Pinin Pacòt che merita essere trascritto per intero:
Dialèt o lingua
Dialèt o lingua, l'un e l'àutra; basta metsse d'acòrdi ant ël sens ëd le paròle.
Per noui, un dialèt as diferenssia da na lingua, pi che tut perchè, avend un vocabolari pòver, adatà mach a jë bsogn 'd na regioun e destinà a la conversassioun, a peul nen serve aj fin motoben pi àot d'una lingua: un dialèt a l'è mach 'n parlé local.
Dialèt fiña a quand ch'a serv mach per esprime jë bsògn pi comun, un parlé as trasforma ant na lingua quand che, chitand d'esse mach na fonssioun ëd la vita 'd tuti i dì, a dventa l'espressioun coletiva 'd l'ànima d'un pòpol. Antloura coust parlé a pija 'n valour spiritual. Sentiment, aspirassioun, penssé, ideai ëd na regioun ò 'd na nassioun a s'esprimo 'nt soue paròle, e coul che prima a l'era mach ël parlé d'un pais ò 'd na sità, dëspresià 'n comparassioun d'un'àutra lingua pi nòbil e dignitousa, a dventa 'l ségn ëd arconossiment ëd tuti coui ch'a lo parlo, an simbolisand la rasoun d'esse d'un pòpol.
Per coust sò neuv valour ël dialèt dventa lingua.
Se dë scritour a lou dòvro servendsse ëd soue soule arssousse, aj na vnirà fòra na leteratura ch'a sarà 'd sicura locala, tant per l'ispirassion che per la fourma. Le scritour ëd rassa, coul ch'a peul nen contentesse 'd coust pòvr utis, a deuv për fòrssa completè sò vocabolari, piand pa mach dai parlé dëvsin, ma 'd cò da coui pi lontan 'd l'istessa famija, le paròle ch'aj manco: parei a peul creé, ò fè arvive, la lingua ch'a esist an potenssa, divisa ant tuti i sò dialèt e sout-dialèt.
E parei 'd cò, nòst dialèt piemonteis a peul aossesse a lingua: basta ch'a sija sincera ant chi ch'a scriv, la cossienssa 'd la dignità dël linguagi ch'a dovra; basta che coun l'amour e lë studi a l'abia capine profondament la natura, e a l'abia la veuja e la forssa d'adatesse a 'n travaj ëd passienssa, che, s'a peul parësse ridicol, a l'é 'd cò 'l soul ch'a peussa permëtie 'd realisé sò seugn.
Per lòn a bsògna podei liberé 'l parlé e le composissioun leterarie da tute j'idéje malsañe ò grossere, da tuti j'italianism d'importassioun e da toute le fourme guaste ò forestere: a bsògna fè arvive tute l'espressioun nostrañe, tute le paròle an tute le manere verament ch'a veui d'essi conservà per tradissioun ant le campagne, lontan dal soufi e dal countat dla sità douva 'l parlé l'è vissià da l'arvisinanssa continua coun 'l linguagi nassional.
Ma se scrive 'n piemonteis a l'è 'l prim dover dlë scritour piemonteis, costi a l'à 'd cò n'àut dover: coul ëd fé nasse ant ël pòpol ch'a lou circounda sò istess amour për ël parlé, che i nòstri vei a l'àn lassane, coul ëd deje al pòpol ël senss ëd nostra rassa, l'orgheui 'd nòstre tradissioun e 'd nòstra stòria, ël sentiment dla blëssa 'd nòstre tere.
Perchè ch'a bsògna nen che lë scritour, ël poeta, as sara ant la tour d'avòri 'd la poesia; ma bsògna ch'a intuissa e ch'a spiega chiel coul ch'a l'é lë bsògn popolar; a bsògna ch'ai mostra a j'àutri lòn ch'a l'é sta lingua ch'a sèrco, a bsògna ch'ass fassa chiel ël difenssour ëd le tradissioun, l'ilustratour dël passà e 'l maestro 'd l'avnì. Perchè ch'a bsògna che al seugn di poeta a corispounda lë bsògn del pòpol. Un a l'è necessari a l'àot.
Na lingua, per raire e soasije ch'a sijo soue manifestassioun leterarie, a l'é artifissial peui mach fiña a na sèrta mira. A l'é na fioritura 'ns la pianta patanùa dël dialèt, e a bsògna ch'as nutrissa sprofondand le radis ant la tera. E la tera l'é la cossiensa dël pòpol ch'a la parla.
Mach antloura, quand ch'a sija formasse cousta cossienssa 'd nòstra perssonalità regional, a podrà nasse na vera poesia piemonteisa, e coun la poesia na leteratura, e 'l piemonteis esse lingua.
Noto che i due articoli che ho riportato, del 1927, hanno sempre e costantemente contraddistinto l'idee di Pacòt in merito alla lingua piemontese.
Faccio qui notare che Pacòt ha scritto lingua, linguagi e in altro pezzo successivo anche linguistich, e che così ha fatto per tutta la vita, come d'altra parte altri grandi poeti piemontesi quali l'Olivero. Solo dopo la sua morte, i suoi successori, hanno iniziato ad utilizzare lenga, langagi al punto che il dizionario Ël neuv Gribàud del 1972, alla voce lenga recita: Lingua, idioma (da condannare l'ital. lingua) e alla voce Langagi: Linguaggio (da condannare l'ital. linguagi). Altri, molto più autorevoli del sottoscritto, hanno dissertato in merito all'uso dei due termini. Personalmente mi viene solamente da condannare l'abuso che si è fatto nelle ristampe di scritti di Pacòt andando, arbitrariamente, a sostituire tutti i lingua con lenga e linguagi con langagi. Che ne avrebbe pensato e detto Pacòt?
E veniamo al contenuto del primo numero de Ij Brandé.
A pag. 2 un racconto fantastico sull'Alpe e l'anime dei morti Coui ch'a tourno a firma L. Caire di Prefounds (toponimo di una vallata nell'alta Val Gesso di Valdieri nella Valscura e pseudonimo utilizzato da Adolfo Balliano).
A pg. 3 La bella poesia Mia tera...! dedicata A mia mare di Oreste Gallina accompagnata da una bella incisione di Ercole Dogliani.
A pag. 4 inizia la pubblicazione a puntate della commedia in due atti d'Onorato Giraud Pòver Fòro!
A pag 6 Pacòt scrive una lunga recensione della rappresentazione di Tera Monfriña di Nino Costa con le musiche del M° Eduard Vercelletti rappresentata a Torino dalla compagnia Casaleggio. Segue una rassegna di libri da poco usciti a cura di Alfredo Formica (che si firmerà sempre sulla rivista Vigin Fiochèt) e dei libri e riviste ricevuti che comparirà poi in ogni numero.
Il secondo numero appare il 31 marzo. Un altro editoriale firmato J Brandé Ai giouvo e il racconto A l'avait di Oreste Gallina. A pag. 3 la poesia di Pacòt Folìa 'd viagi con dedica a Ismaël Girard (poeta occitano) e poi ripresa in Crosiere. Qui è accompagnata da una bella incisione, sempre di Ercole Dogliani.
A pag. 4 poi Tradission piemonteise ~ Nosse di Vigin Fiochèt. Quindi. a pag. 5 prosegue la pubblicazione a puntate di Pòver Fòro!
Nel Gasetin un articolo di Pacòt sul teatro Gianduia, l'antico torinese teatro D'Angennes, dove la famiglia Lupi opera con le sue marionette. Poi nel Leturil Pacòt, prendendo spunto da l'Almanach Occitan, si occupa della rinascita della parlata provenzale iniziando con De Clarmont à Malhorca e d'Alpas à Medoc, pertot ont rebombis lo preclar parlar d'Oc. E così conclude: E coust, per noui piemonteis, a peul ëd cò esse n'esempi.
Formica da poi conto dell'antologia 'l Piemount e i sò poeta appena pubblicata da Casanova sotto l'egida e a cura della Famija Turineisa.
Il 15 aprile esce il terzo numero. In prima pagina vengono pubblicate alcune manifestazioni di consenso per la pubblicazione (On Galimberti su La Sentinella delle Alpi, La Stampa, Ismaël Girard direttore di OC, Tolosa ed altri ancora).
In prima e seconda pagina Canssoun e amssòire al soul di Oreste Gallina. A pag. 3 il sonetto Në spìrit ch'a parla dedicato a Pinin da Giovanni Gianotti. Per la rubrica Tradissioun piemonteise 'L bal sempre a firma Vigin Fiochèt. Quindi ancora il seguito della commedia Pòver Fòro!
Nel Leturil Pacòt recensisce Griote e Frole... Frolòn... di Rico.
Ed eccoci al 30 aprile con l'uscita del quarto numero. In prima pagina nuovo interessantissimo pezzo di Pacòt:
Piemonteis e poesia.
Perchè 'l Piemount, ò mei nòst linguagi piemonteis, a l'à nen avù 'n gran poeta? A l'é-lo mach per ël motiv ch'a l'é mai spontaine gnun, ò perchè pròpi a l'é staje 'd càose ch'a l'àn podù contrarié e sofoché la cossienssa 'd na vocassioun ch'a sercava mach na fourma per manifestesse e fiorì?
Per ël prim motiv a fa pa dëbsògn ëd ciamé 'n bal la filosofia dël Croce, perchè ch'a l'é ciair ch'as peul nen discute e i chërdo ch'a saran tuti d'acòrdi; lë scound anvece as prësta a 'd considerassioun pi serie, che per adess im contento 'd noté a la svelta, riservandme 'd torné pi tard e coun còmod su coust argoment.
An Piemount a l'é sempre chërdusse che 'l piemonteis a fussa mach na corussioun ëd l'italian ò dël fransseis, ò magara 'd tuti doui anssema, dësmentiand che, se mai, a l'era 'nvece 'l piemonteis ch'a l'era stait corompù da l'avsinanssa 'd cousti doui linguagi leterari. Gnun a l'à mai avù la nossioun che 'l piemonteis a l'aveissa 'd caràter sò, così distint e così important, da dëstachelo completament dai linguagi dëvsin. Se mai, tra 'l piemonteis e le doue lingue la relassioun a l'é uña soula, coula 'd la parentela, l'istess che tra l'italian e 'l fransseis; tut al pì 'l piemonteis a l'é sempre stait ël parent pòver.
Sainte-Beuve a l'à scrit: «Je définis un patois une ancienne langue qui a eu des malheurs, ou encore une langue toute jeune et qui n'a pas fait fortune».
- E 'l piemonteis a l'à pa avù na gran fortuña.
Se noui i guardouma i verss di gran poeta 'd tute le nassioun, i vëdouma che pì i poeta a soun stait grand e mei e pì a found a l'àn conossù 'l parlé ch'a scrivijo, e che mach coun na padronanssa perfeta 'd sò linguagi a l'àn podù dene, an dë stròfe ch'as peulo pa dësmentiesse, l'ànima 'd sò pais, lëspirit ëd soua rassa, tut lòn ch'a l'é 'ncoura tërbol e confus ant ël sentiment dël pòpol e che 'nt ël cant ël poeta a treuva la soula fourma luminousa e bela. Fé 'd nòm a sarija n'erudissioun tròp facil.
Oura, couma a l'era possìbil che coun un parlé dëspresià, che da sécol an sécol a l'à sempre perdù quaicòsa ancontrandse coun d'àotri parlé, ch'a lòn dominavo politicament; couma a l'era possìbil che 'n ver poeta as buteissa a scrive 'nt un parlé ch'a l'era pa studià e ch'a l'era tant pòver an comparisioun d'àotri linguagi ch'a jë smonijo d'esempi così glorious ëd poesia?
E i mei piemonteis, dësmentiand sò parlé natural, a l'àn scrivù 'n latin prima e peui an provenssal, an fransseis, an italian; mentre che 'l piemonteis a l'é squasi sempre stait, gavand naturalment j'ecessioun (couma di? ecessiounai?), 'l camp riservà a 'd tanta brava gent, che senssa arsighesse a scrive ant un linguagi tròp nòbil e tròp dificil, a l'à sentù 'd cò sò bsògn ëd campé giù, uña dòp l'àotra, soue strofëte, alegre e galupe; còsa tut àot che da dëspresiesse, perchè a fa mal a gnun, ma che a l'é 'ncoura nen poesia, ò almen coula poesia ch'a duvrija esse l'espressioun pi viva, pi natural e pi fòrta 'd l'ànima nostraña,
Per fé 'd vera poesia piemonteisa, a sarija stait necessari fé arnasse 'l piemonteis; fé couma ch'as fa per tute le lingue: studielo; rendje soua purëssa e tuta soua richëssa 'd fourme e d'armonie, per ch'a podeissa esprime, coun tuta soua fòrsa, coula ch'a dovrija esse soua vera ispirassioun, la canssoun dla rassa piemonteisa. Ma 'l piemonteis a l'é così ambastardì e così pòver, così lontan ormai da couma a l'avrija dovù esse, se a l'aveissa podù vive indipendent da tante influensse, che pròpi a scoragia.
A j'é tut un travai da fé. Un travai che i poeta piemonteis a dovrijo avei la fòrssa 'd fé, coun la volontà e lë studi, e pi che tut coun l'ispirassioun tornand a le sorgiss pi lontañe 'd nòstra gent; perchè ch'a bsògna tourna tiré su la ca, ruvinà dal temp, per ch'a peussa intreje la poesia.
Segue a pag. 2 un altro racconto di montagna Fiòca 'n montagna siglato ancora 'L. Caire di Prefound (Adolfo Balliano) con una bella incisione di Dogliani rappresentante un villaggio alpino sotto la neve.
Alla terza pagina la poesia di Pacòt Crosiera dedicata al direttore della rivista Marsyas Sully - André Peyre con una bella incisione di Ercole Dogliani dedicata a Superga; a fianco la poesia di Gallina Vous matinere con dedica A me pare.
La pag. 4, di Vigin Fiochèt, è dedicata a "I fastidi d'un grand'òm" e il teatro piemontese mentre a pag. 5 continua la commedia Pòver Fòro!
Infine il Leturil presenta uno scritto di Severino Cerutti dedicato a Fulberto Alarni.
Ed ecco il 31 di maggio, data in cui compare il quinto, ed ultimo, numero dell'Arvista piemonteisa.
In prima pagina Pacòt prende spunto dal pezzo che aveva dedicato, nel precedente numero della rivista, a Rico per scrivere Doue tendensse dove ritorna ad amplia temi già trattati. Conclude così:
Còsa a veul di peui se 'l linguagi ch'as dòvra a l'é na lingua universal ò 'n dialèt parlà da quat perssouñe? La blëssa a basta da chila, e aj na fa pòch al valour ëd na poesia, s'a sarà lesua dal mond antregh a s'a trovà granca 'n letour.
L'important a l'é creé na blëssa 'd pi; per la gòi ëd tuti ò per la gòi d'un soul a fa l'istess.
Ancora in prima pagina, con seguito in seconda, un altro racconto di Gallina A le sorgiss.
La terza pagina è dedicata da Severino Cerutti all'incisore Ercole Dogliani tracciandone un breve ritratto accompagnato da tre belle incisioni: Il Monte dei Capuccini, Il Castello di Chatillon e La fatica del lavoro.
Vigin Fiochèt si occupa di storia piemontese lamentando l'assoluta ignoranza dei fatti storici accaduti salvo quelli (Madama Real, monssù Pingoun ad esempio) fatti rivivere dai romanzieri. Cita un buon numero di scritti sulla storia del Piemonte invitandone alla lettura.
Alla pagina cinque continua (ma non finirà) la pubblicazione della commedia d'Onorato Giraud Pòver Fòro!
Nel Leturil Pinin Pacòt descrive approfonditamente il Dizionario Etimologico del Dialetto Piemontese di Attilio Levi appena pubblicato da Paravia. Così conclude:
Tesòr verament pressious ch'a mancrà nen d'avei la fortuña ch'as mèrita, intrand ant tute le ca a occupé, dacant ai liber pi studià e pi amà, sò pòst d'onour ant le biblioteche piemonteise.
A caccia di nuove iniziative
Terminata, per mancanza di fondi, l'esperienza della rivista Ij Brandé, attorno a Pinin Pacòt si raccoglie un gruppo di poeti piemontesi che fondano la Compania di Brandé. I Brandé, gli alari che nel camino servono, rialzando la legna, ad arieggiare e quindi ravvivare la fiamma. È questo lo scopo dichiarato della Compania, tenere desta, ravvivare la fiamma della poesia piemontese che, come già scriveva Pacòt su Ij Brandé, se non proprio morta, almeno sul punto di morire era.
L'unificazione della grafia piemontese
Nel frattempo a Torino, su iniziativa dell'Avvocato Eugenio Rastelli, Direttore Tecnico per il Folclore dell'O.N.D. Opera Nazionale Dopolavoro, nell'inverno 1929~1930 si tengono una serie di riunioni nella sede provinciale di Torino per giungere ad uniformare la grafia del piemontese. I lavori avranno poco tempo a disposizione e si concluderanno con la presentazione della grafia messa a punto sul primo volume della appena nata collana Scrittori Dialettali Piemontesi della S.E.L.P. Alle riunioni partecipano, oltre l'Avvocato Rastelli, Matteo Bartoli, Nino Costa, Alfredo Formica, Ferdinando Neri, Luigi Olivero, Giuseppe Pacotto, Leo Torrero e Andrea Viglongo.
Da quel momento la grafia prende il nome di Pacotto~Viglongo e, tutte le volte che se ne parlerà, scientemente si tralasceranno i nomi degli altri che hanno contribuito al lavoro. Lavoro che poi, in pratica, si limitò all'eliminazione della ô e della ñ, all'introduzione di qualche accento grave o acuto e al trattino di separazione tra la n faucale e la vocale che segue (lun-a).
A Mistral
In una lettera del 29 luglio del 1930 Pacòt scrive all'amico Olivero della consistenza della Compania e dei suoi programmi futuri:
A pròposit, a të smijlo nen ch’a sarìa bel, butandse tuti ansema, a fé arvive eva, così piemonteis, abandonand acqua ò mej aqua, così toscan?
Alfredino a l’ha-co dite quai còsa dl’intension ch’a j’é an aria d’ fé arnass I Brandé, fait da noi giovo, mach da noi giovo. A të smija bona l’idea? J chërdo che’l moment a sia bon. Perché ch’a j’é na vera fioritura d’ poesìa giovo, un fòrt arnasse pa mach dla literatura, ma dl’anma piemonteisa.
I l’hai trovà n’apassionà (29 agn) d’ nòst folclòr, ch’a l’ha cujì e ch’a l’ha contà ant na manera delissiosa le stòrie, le faule, le legende d’soa region alessandrina, ant un bel piemonteis pien ëd saiva e pien ëd calor. Aj publicrà prest e a sarà na bela còsa. (Nino Autelli, Pan 'd coa)
Alfredino a më scriv ch’a l’ha decidù un sò amis a scrive an piemonteis: n’autr prosator!
Mi l’hai decidù Rovere; Tòta Rocco a scriv ëd poesiòle ch’a son delissiose; Signorini a l’ha d’ bona intension (a l’halo fait quaicòsa a Vilastlon?). E peui t’jë ses ti, j’é Alfredino, j’é Brero, j’é Galina, j’é Motura, modestament d’cò mi, e chissà vaire d’autri ch’i troveroma, amis e scritor piemonteis. Coma ch’it vëdde, mal contà, na desena già. E peui j’é ancora Còsta di nòstri, e Còsta…a conta! Coma ch’it vëdde tante idee, tanti seugn, e quaicòsa d’ positiv. Tante bele còse e arvëdsse prest. Ëd cheur
Neanche un mese dopo, 21 agosto 1930, sempre con lettera diretta a Luigi Olivero:
Me car Vigin,
I son tut sagrinà d’nen esse podù vnì d’cò mi a la Vila (Villastellone, paese natale di Luigi Olivero) ansema a j’autri amis. Prima ‘d tut perché ch’i l’avìa gòj ëd vëdte, e peui perché ch’a l’è mach parlandse che la gent a peul capisse. Ant coste còse scripta volant, verba manent, perché ch’a së scriv per j’euj, e parlesse, anvece as parla al cheur. E da già ch’i j’ero tuti ò squasi tuti ansema i l’avrìo podù dëscore e concreté quaicòsa. Passiensa! A sarà për n’autra vòta. E speroma ch’a peussa d’cò essje Mottura e Gallina. Così i sarìo al complet: sèt, coma i sèt poeta ëd la Pleiade. Sèt coma i sèt fondator dël Felibris, sèt come le stèile dël chèr, sèt coma…etc. etc. Lòu ch’a conta a l’è che’l sèt , nùmer prim, a pòrta fortuna, na fortunassa dla malora. E peui a a l’è un nùmer dèscobi, parej ‘d nostre teste e d’ tuti i nòstri seugn ch’a trovran forsi mai a cobiesse con la vita ch’as viv. Tant, as seugna për sugné, se d’ nò ‘l seugn a sarìa pi nen ël seugn, e a varria tròp poch. (Turin, 21 aost 1930)
Già è nell'aria l'idea di riprendere la pubblicazione de Ij Brandé che, a fine anno, prenderà vita con pubblicazione non più quindicinale ma con un almanacco annuale.
Nel frattempo Pacòt, celebrandosi di lì a poco il centenario della nascita di Mistral decide, coadiuvato dalla S.E.L.P. Studio Editoriale Librario Piemontese di Andrea Viglongo, di pubblicare in omaggio un'opera che raccolga le poesie dei poeti piemontesi di allora. Nasce così, con data 8 settembre 1930 A Mistral ~ Omagi di poeta piemontèis cui aderiscono diciassette poeti piemontesi: Mario Albano, Carlo Baretti, Renzo Brero, Nino Costa, Salvatore Ferrero, Saverio Fino, Oreste Gallina, Giovanni Gianotti, Tommaso Grosso, Armando Mottura, Alfredo Nicola, Ernesto Odiard des Ambrois, Luigi Olivero, Giuseppe Pacotto, Carlottina Rocco, Teresio Rovere, Giulio Segre.
L'opera ha una tiratura di 300 copie ed oggi è diventata molto rara. L'anno successivo ne viene data alle stampe una nuova edizione in mille copie con nuovo titolo Diciasette (sic) poeti piemontesi ma identica alla precedente, salvo una breve prefazione alla seconda edizione datata gennaio 1931.
Nell'elenco dei poeti partecipanti all'antologia compare un certo Tommaso Grosso che presenta nel volume due poesie Ariètine amorose e L'omagi. Questo poeta è inesistente. Le due poesie sono di Pinòt Casalegno che le invia a Pacòt dicendole opera di un suo amico ingegnere di Bra. Pinin le pubblica, vuoi perché le ritiene degne, vuoi per fare un piacere all'amico. Non si accorgerà che in seguito del brutto tiro giocatogli. Infatti le due poesie contengono entrambe un acrostico. Le iniziali dei 14 versi dei due sonetti, messe di fila, danno infatti Balin Provenssal e A l'é na montatùra. Pacòt se ne accorgerà, o gli verrà fatto notare, solo in seguito, tanto che le due poesie sono presenti anche nella seconda edizione. Del fatto a lungo rimarrà amareggiato e, conseguentemente, diffidente verso il prossimo.
Pan 'd coa
A questo punto, cronologicamente, dovrei iniziare un escursus su gli Armanach piemontèis la cui preparazione per l'uscita del primo, dedicato al 1931 inizia nella seconda metà del 1930. Anticipo però un piccolo lavoro di Pacòt, dell'estate del 1931, in quanto ci permette di puntualizzare meglio la composizione della compagnia raccolta intorno a lui.
Si tratta di una prefazione, quella alla raccolta di leggende e racconti popolari scritta da Nino Autelli Pan 'd coa.
In proposito Pacòt aveva scritto in una lettera a Luigi Olivero già precedentemente riportata:
I l’hai trovà n’apassionà (29 agn) d’ nòst folclòr, ch’a l’ha cujì e ch’a l’ha contà ant na manera delissiosa le stòrie, le faule, le legende d’soa region alessandrina, ant un bel piemonteis pien ëd saiva e pien ëd calor. Aj publicrà prest e a sarà na bela còsa.
Già il titolo della prefazione la dice lunga: Nino Autelli e la giovane poesia piemontese. Riporto i brani che riguardano appunto i giovani poeti.
Così, accanto a chi, come Teresio Rovere, dalla meditazione raccolta e dalla contemplazione trasfigurante, sa trarre ritmi larghi e sereni, percorsi da un intimo tremito di commozione e illuminati da un pensiero nobile e grave; o accanto a chi, cercando in se stesso, dopo essersi avidamente inebbriato della bellezza delle cose, lungo le strade percorse e nelle lontananze sognate, vorrebbe esprimere, nella desiderata e non mai raggiunta rara musicalità del verso, la preziosità di un pensiero in cui si fondessero le misteriose corrispondenze fra l'anima sua e il mondo; c'è chi, come la Carlottina Rocco, si abbandona alla freschezza dell'ispirazione ed esprime, con una immediatezza che non esclude l'arte, nella chiarità delle strofe, lo spontaneo fluire d'una lirica fatta di sensazioni squisite e di suggestioni sottili, sgorgante canora come alpestre acqua sorgiva.
Così accanto ad Alfredo Nicola ed Armando Mottura, appassionate anime cittadine, poeti d'amore, giovanilmente ardente il primo, e trasognato l'altro, nostalgicamente sognanti liriche evasioni verso la verde quiete della campagna od eroiche elevazioni verso le immacolate vette dei monti, un altro gruppo di poeti canta un ben diverso canto.
Figli della campagna, contadini fin nelle più profonde fibre, esiliati nella modernità vertiginosa della vita, essi esprimono nella loro poesia il canto stesso della terra, che, imile ad una linfa, sale alle loro bocche dai solchi cg'essi percorsero nella loro spensierata adolescenza.
Oreste Gallina, che, dopo essersi cercato e tormentato componendo in torinese, trova finalmente la sua strada e questa percorre superbamente quando, ritornato al suo rude dialetto delle Langhe, canta, (Canta, Pero!) e non più compone quella forte poesia della natura e dell'uomo, che gli gonfiava l'anima con repentini scoppi di niostalgia.
Luigi Olivero, che lancia i canti come l'anima attraverso la pianura della sua Villastellone, ricca d'acque specchianti e di pronube ombre, e riflette nei versi la sua vibrante anima di giovane fauno, aperta non soltanto a tutti i ritmi della natura e dell'amore, ma anche alla sperduta e morente poesia popolare echeggiante nelle fiabe, nelle leggende e nelle canzoni. Una moderna, sottile vena di ironia sottolinea e rialza la immediatezza dei suoi versi.
E Renzo Brero, che si libera finalmente da ogni maniera e da ogni influenza, per ritornare alla sua prima giovinezza, quando:
Mach che 'l sol luseissa an cel
che na rama ant le campagne
a buteissa un but novel,
egli correva libero
për i camp e le caussagne
sensa pene, 'l cheur content,
tra le fior ëd le campagne,
come 'n fòl, an brass al vent!
Da questa profonda, intima fonte egli trae una commossa e chiara poesia.
A questi poeti della terra, viene ora ad aggiungersi Nino Autelli, poeta che non scrive versi, ma ci offre in queste sue narrazioni, una schietta poesia popolare, che come il pane del contadino, 'l pan 'd coa, ricco di glutine, ha il caldo sapore della terra.
Tralascio le pagine che Pacòt dedica alla novellistica popolare e a Nino Autelli, riporto però la chiusa:
I giovani poeti piemontesi si sono riuniti in una «Companìa di Brandé».
I «Brandé», sono gli alari.
Il fuoco arde tra gli alari, ed una nuova fiamma si è accesa.
Che il vento gelido dell'invidia non la spenga con un soffio di scoraggiamento.
Gli Armanach piemontèis
Nel 1929 poeti, scrittori, storici piemontesi, senza una vera e propria dichiarazione d'intenti, si trovano riuniti nel gruppo J'amis dël dialèt. Con Costa e Pacòt, ai tavolini del Caffè Fiorina di Via Pietro Micca, di fronte all'omonimo albergo, si ritrovano Pinòt Casalegno, Giulio Segre, Carlinòt, Mario Albano, Carlo Baretti ed i giovani Renzo Brero, Armando Mottura, Alfredo Nicola e, naturalmente l'editore Andrea Viglongo. Altri ancora frequentano saltuariamente od assiduamente gli Amis dël dialèt: i due fratelli Formica, Alfredo editore e Remo scrittore, Carlo Emanuele Croce, musicista, ed ancora Teresio Rovere, Giovanni A,melotti, Dario Cesulani (Cesare Laudi), Giovanni Gianotti. Non manca l'avv. Eugenio Rastelli cui si deve l'iniziativa per arrivare all'unificazione della grafia del piemontese.
La pubblicazione di A Mistral, con la beffa attuata da Pinòt Casalegno segna la rottura del gruppo, la nascita della Companìa di Brandé intorno a Pinin Pacòt e la nuova avventura con la pubblicazione del primo numero della serie degli Armanach piemontèis per il 1931.
Pacòt cerca un finaziatore per l'impresa e lo trova in Andrea Viglongo che a sue spese pubblicherà il primo Armanach che uscirà A l'ansëgna d'j Brandé. In tutto 64 pagine accompagnate da sedici pagine pubblicitarie, otto in testa ed altrettante in coda al volumetto. Prezzo di vendita 5lire.
Nino Costa, richiesto di una presentazione, invia a Pacòt una lettera che questi utilizzerà come prefazione. Ne estraggo alcuni brani:
I temp a vario, ma mi i son sempre dl'istessa idea: cola ch'i l'hai già manifestate vaire vòlte. Val a dì: për fé conòsse al pùblich la leteratura dialetal piemonteisa al dì d'ancheui motoben ëd pì dël giornal ò dla rivista, a servo 'l lìber e la recitassion.
La recitassion ... përchè aj gionta a la paròla scrita tuta la mùsica, la comossion, l'andi e 'l calor dla paròla parlà.
Ël lìber, përchè a l'é na ròba ch'a resta, magara con i feuj da tajé, ma sempre dispòst a fesse lese.
Al contrari, ël giornal, la rivista, specialment për ël nòstr dialèt, ch'a l'é gnanca tròp capì da jë stessi piemonteis, a duro lòn ch'a duro; a veno lesù da 'd gent che ant la gran magioransa aj cerca an drinta la ròba ch'a fassa rije, e për serve dabon a quaicòsa a dovrìo avéi na difussion tal che ai nòstri ciair ëd luna a l'é folìa speré.
Ecco përchè i son d'acòrdi con ti sla publicassion d'un armanach. L'armanach, sla fasson ch'i veule felo seurte voi-autri, a l'é quasi un lìber, na specie d'antologìa, ch'as pùblica na vòlta a l'an e për lòn av caria nen dë speise, a costa nen tròp car, as peul guernesse con facilità, e, pi che tut, a cheuj ël travaj d'n'anada antrega, val a dì l' mej che i redator a l'abio podù fé, siassand ël bren, e dovrand pròpe mach la fior dla farina.
Viva donque l'Armanach! Auguromse che l'idea a taca e che la serie a continua.
Peui dòp i treuvo giust che 'l prim armanach a sia fait completament dai pì giovo.
Për le strà neuve l'é quasi sempre la gioventù ch'a s'ancamina, e nen për gnente la primavera l'é la pì viva stagion ëd l'an.
...
L'almanacco si apre con alcune pagine che l'avv. Rastelli, il Direttore Tecnico pel Folklore del Dopolavoro Provinciale dedica all'attività svolta.
La parte poetica si apre con Calottina Rocco (Vessolan, Istà, Madamisele an vesta 'd mussolina..., Otogn), poi Renzo Brero (A me paìs, Feuje giaune, Oh, matin serena e bela..., Fontana), Armando Mottura (L'Aiguille Noire du Péteret, Lòn ch'i seugno), Alfredo Nicola (Lë sciòp d'un basin, Obada, Stember), Luigi Olivero (L'erba grama, Egloga minima, Pitor a la cassa), Teresio Rovere (Invern), Pinin Pacòt (Quat rondei).
Per la prosa, di Oreste Gallina il racconto Canson e amsòire al sol; quindi due racconti di Nino Autelli I tré fratei e Toni Toblan entrambi ripresi poi in Pan 'd coa; riappare quindi il racconto fantastico di Adolfo Balliano Coi ch'a torno già apparso sul primo numero de Ij Brandé con la firma L Caire di Prefounds; poi un saggio di Luigi Olivero dedicato al pittore e acquarellista Agide Noelli Un pitor dla pi bel'aqua, Severino Cerutti ripropone poi il ritratto di Ercole Dogliani già presentato su Ij Brandé, Mottura illustra poi le novità del teatro piemontese cui fa seguire due brevi racconti Mal dël paìs, It ricorde?
Ed ora l'Armanach per il 1932. I fondi per la stampa mancano. Pacòt cerca aiuto. Con l'appoggio di Nino Costa si rivolge alla Famija turinèisa che si assume l'onere. Ma le condizioni...
In una lettera diretta a Luigi Olivero (senza data ma, sicuramente, della seconda metà del 1931) Pacòt scrive:
L'Armanach a marcia, a j'é 'n pòch ëd bora di poeta dla Famija, e ch'is'n'ambrigna! Basta ch'as fassa, noi peui ij butama lòn ch'i voroma. T'ses content ch'i buto i tò doi sonèt?
Naturalmente non sono tutte rose e fiori. L'accordo con la Famija prevede il ritorno all'abborrita grafia de 'l caval 'd brôns, male comunque necessario per Pacòt. Inoltre lo spazio a disposizione sarà diviso tra i due gruppi di collaboratori.
L'Armanach si apre questa volta con una Presentassiôn siglata Famija Turineisa:
Për côsta pubblicassôn la «Famija Turinejsa» a l'à sônà la sôa cioca granda për ciamé d'antôrn a chila i pôeta e jë scritôr dialetai piemônteis. ...
Tra i pôeta e jë scritôr dialetai nostran a j'erô fôrmasse diversse tendensse, për nen dì scole, su la grafia.
L'ann passà l'O. N. D. a l'avìa nôminà una Cômissiôn për lë studi 'd 'na rifôrma 'd la grafia dialetal, për rendla pì facila e a la pôrtà 'd tuti, ma côsta rifôrma l'è staita rimandà an seguit a le discussiôn e a le diverse proposte.
'Na partija 'd giôvô, côn a la testa Pinin Pacot, a l'àn risolt la questiôn për so cënt, cônvint che sôa manera dë scrive a rispeta nen mach la tradissiôn p' pura 'd nost dialet, ma ch'a sia 'd co côla pì pratica e 'nt l'istess temp côla che a rispônd mei ai prinssipi 'd la sienssa dël linguagi.
Ma côsta manera a va côntra la tradissiôn, che i ciamrôma Virigliana, d'una part dë scritôr e 'd pôeta che a la scola d'Alberto Viriglio, maestro, a sôn chërssù e tanta part d'atività e 'd fede a l'àn dait a l'increment 'd la leteratura dialetal, salvand-la da la ruviña e da l'indiferenssa 'nt i môment dificii.
Dnans a côste dôe tendensse, për evitè che l'Armanach a fussa 'na mnestra giardinera andôa 'na pôesia a fussa scrita ant una grafia e l'aôtra ant un'aôtra, butand 'l letôr ant un tirimbalin dialetal, i «Brandè» côn un sens 'd cômprenssiôn - e 'd lon i ringrassiôma tant - a l'àn rinunssià për côsta publicassiôn ai so cônvinciment grafich. ...
Sicuramente non è quello che avrebbe voluto Pacòt. L'Armanach si apre comunque con una seconda lettera di Nino Costa al Me car Pinin Pacot di cui qui alcuni stralci:
Për la strà as rangia la sômà. Stavolta, côn lë scônd «Armanch Piemôntes», d'antôrn a la bandiera dël dialet, ai marcia tuta la Cômpanìa.
Dë dnans i giôvô d'i Brandé a la bersagliera. d'apress a lôr i trôpié d'la guardia e i veteran.
La «Famija Turineisa» a l'ha fait San Giôann d'arlev e a l'è cariasse 'l badò d'le speise - nen mach, ma a l'ha giutave côn tuta l'autôrità e la pôpôlarità 'd so nom.
Lolì, se i fa ônôr a la Famija, a sminuiss nen ël merit ëd vôjaôtri che i l'eve, për i primi, avù l'idea e 'l côrage d'un armanach piemônteis. Quand che lë smenss a l'è bôn, dificil ch'a taca nen. ...
Mi l'hai faje da parin la prima volta e bin vôlôntè ii lô fass ancôra 'na scônda. Ma côme tuti i parin venta ch'i paga le batiaje. E i pagô côn na parola sôla - côn la parola 'd tuti nôjaôtri ch'is gavôma 'l capel dnanss al passà, ma i vôltôma la facia anvers l'avnì; côn la parola:«Côrage».
Di Nino Costa segue la poesia Piante con dedica a Gemma Vercelli (pittrice torinese) e più avanti Temp 'd vendumia, testo della canzone messa in musica dal M° Carlo Emanuele Croce.
Il volumetto è questa volta di 96 pagine. Qui tutti i Brandé, con orgoglio, si dichiarano d'la Cômpanìa d'ij Brandè. Primo poeta della Companìa è il M° Menotti Tomaselli con Su sta côlina, quindi Armando Mottura con A l'è nen vera gnante; segue Carlottina Rocco con Stich berlich, Bianche faje, 'L camposanto ëd Jovençeaux; di Pinin Pacòt Primavera; ora Luigi Olivero con Neuit a La Vila e Le tre fôntane; Pasieve...! Pasieve...! è il contributo di Carlo Baretti; Renato Bertolotto propone Le seire 'd San Lôrens; di Teresio Rovere Aniverssari; Alfredo Nicola con La freidôlina e 'l ciclamin e Natal; ancora Ôtôgn di Aldo Daverio per concludere con Simiteri campagnin di Renzo Brero.
Per la prosa Campagna di Armando Mottura e alcune sue pagine dedicata all'annata appena trascorsa del teatro piemontese; 'L pan dël mort di Nino Autelli; Baluëtte di Tilio Viriglio; Brich e ciabot di Aristide Mercato; di Renato Bertolotto La mëssa; Antonio Balliano ripropone Fioca an môntagna racconto già apparso su Ij Brandé; ultimo racconto dell'Armanch dell'avvocato di Villastellone Vincenzo Signorini Ann neuv e ann vei.
Ho citato in questo elenco solo Ij Brandé. Per corretteza elenco anche i principali collaboratori del 'l cavl 'd brôns: Paggio Fernando, Luigi Maggi, Elisa Vanoni Castagneri, Fernando Viale, Luisin Lupi (Gianduja), Alfredo Chin, Mario Leoni, Alerame Pallavicino, Arnaldo Soddanino, Salvator Ferrero, Saverio Fino, Luigi Gay, Giovanni Amelotti, Carlin Boella, Percy Roero di Cortanze.
Chiusa, senza troppa soddisfazione, l'esperienza dell'Armanach per il 1932, Pacòt pubblica A l'ansegna dij Brandé un lavoro dedicato a Alfonso Ferrero poeta piemontese, quasi un presagio per l'imminente fine del noto poeta e romanziere che giungerà nel dicembre dell'anno successivo. Nell'Armanach per il 1933, Nino Costa, nel Leturil, recensisce il lavoro di Pacòt di 63 pagine pubblicato da Mittone:
Ne studi su Alfonso Ferrero ch'a fussa anssema notassion biografica e interpretassion critica l'era n'afé nè facil nè alegher. Pinin Pacòt a l'é gavasla da bulo. La figura 'd Fònso a seurt fòra da ste pàgine con n'evidenssa e 'n risalt magnifich. Ël poeta romàntich ... a l'é studià da Pacòt an tute soe forme, an tute soe manifestassion e fina 'n tuti i sò eror. ...
Për tuti coi che a san lòn ch'a l'é stait e lòn ch'a l'é Fònso Ferrero, sto librèt ëd Pinin Pacòt a paress nen mach un bel travaj, ma 'dcò e specialment na bona assiòn.
Per la milanese Rivista Italiana di Letteratura Dialettale prepara un panorama dell'odierna poesia piemontese. Scrivendo ad Olivero a proposito A sarà 'd cò ilustrà, e farà 'l gir d'Italia 'd cò toa bela facia ansema a le nòstre bele facie (Tòrt a gnun!).
Pacòt si dedica anima e corpo al futuro almanacco per il 1933. Questa volta vuole fare da solo. Nel già citato scritto a Luigi Olivero così si pronuncia:
I soma peui butasse d'acòrdi an sla publicassion d'"J Brandé 1933", sensa apòj dla Famija e sensa tua 'd gnun. I l'oma decidù 'd quotesse a 10 lire al meis a pr'un, per podei formesse un cit fondo da paghé la stampa, ch'a sarà completà... (purtroppo, nel fondo Olivero di Villastellone, in cui si conserva l'originale, questa lettera è monca dell'ultimo foglio.)
A questo punto la grafia del piemontese è ormai quella unificata nata negli incontri banditi dal Rastelli di cui già ho scritto. Il merito di ciò va però attribuito all'editore Andrea Viglongo che, dalla nascita della collana Scrittori Dialettali Piemontesi (Primo volume Edoardo Ignazio Calvo, secondo Oreste Fasolo, un terzo volume già pronto dedicato a Norberto Rosa non vede la luce per difficoltà insorte e la collana, prevista in 40 volumi, purtroppo, qui avrà termine.), per pubblicare opere in piemontese pretende che quella unificata sia la grafia che tutti dovranno utilizzare.
L'Armanach del 1933 si apre con uno scritto di Aldo Daverio Piemont fascista piuttosto apologetico in relazione al regime di allora:
Ël Piemont, la tèra dle montagne pi aute e di vin pi generos, con soa rassa robusta e temprà a tute le fatighe e a tuti i sacrifissi, a l'é drit e a marcia 'd gamba sana sla stra luminosa che 'l Duce a l'ha daje a l'Italia. ...
Chiel, parland da 'n Piassa Castel, la piassa da 'n dova ch'a l'ha piat ël vòl la Libertà d'Italia, a l'ha sentulo, 'l cheur dë sto nòst Piemont, come na fiama sola, immensa giòla d'amor, bate con Sò gran cheur. Chiel a l'ha misurà con në sguard la cadenssa 'd nòstra vita 'd marca fascista, e noi i l'oma vistlo anluminesse ant un soris ëd sosisfassion, ël premi pi aut ëd nòstra fede e 'd nòstre fatighe. ...
Viva 'l Duce!
Con tutta probabilità questo scritto è stato utile per poter proseguire le pubblicazioni e non fare la line de 'l cavl 'd brôns costretto a chiudere dal regime.
Il contenuto. Da questo volume elencherò solamente i contributi più significativi.
Nino Costa presenta Torototela che così viene giustificata: Nino Costa an costa poesìa a l'ha cercà 'd fissé una dle figure pi caraterìstiche dle nòstre coline: «ël torototela», val a dì 'l rimador che 'nt le baldòrie d'i particolar e 'nt le feste d'ii pais a 'mprovisava la cansson e la poesìa 'd circostanssa.
Ancora Adolfo Balliano presenta un suo racconto Iv presento 'l pàroco! Elisa Vanoni Castagneri in uno dei Lituril presenta Fruta madura di Nino Costa da poco uscito per i tipi della S.E.L.P.
Luigi Olivero con Me paìs offre due sue poesie d'ambiente villastellonese Ël sanssué dël Pasch e Sol d'invern, Carlottina Rocco segue con L'arssigneul a canta e Le ore, e della Rocco, la Castagneri presenta la raccolta An sla brova dël senté. Di Renato Bertolotto Feu 'n sla montagna e Invocassion a la Musa, poi Armando Mottura Dame da beive!, Renzo Breo Primavera an sël prà, Alfredo Nicola Seira a Coni; in un altro Lituril Costa presenta di Nino Autelli Pan 'd coa.
Interessante Vei ricòrd di Giacolin Sacerdote in cui descrive la nascita e lo sviluppo del suo «Birichin».Quindi ancora un racconto di Nino Autelli Cabanòt. E, in conclusione, ancora due poesie L'ùltim viagi di Aldo Daverio e di Pinin Pacòt L'ùltim convent.
E quat! Così apre il redazionale firmato I Brandé dell'almanacco per il 1934. Ne estraggo qualche paragrafo:
Così coma ch'a l'é, cost armanach a riflet bastanssa bin le condission dla poesìa piemonteisa, giovo e moderna; cola ch'a l'ha ancora nen podusse esprime an pien, e che, giusta per lòn, a l'ha pi dë slanss e pi 'd possibilità, e a marcia decisa verss ëd forme neuve e verss ëd neuve realisassion.
Anssema a la generassion ch'a s'ancamina, a j'é 'd cò j'anssian ch'a son rivà, a j'é 'd cò coi ch'a l'han già dit tut, ma ch'a l'han sempre la vos ciaira e frësca coma i giovo, e ch'a sògno nen ant la bela companìa; ansi a servo a marché mej, da na part le simpatie e, da l'autra, le posission 'd partenssa dle neuve e i neuv obietiv 'd costa conquista senssa fin ch'a l'é la poesìa.
Con tut lòn, cost armanach, modest dë stampa e 'd preteise leterarie, a veul nen ese 'd pi che lòn ch'a l'é, e i sò colaborator a chërdo nen d'avèi fait 'd pi che lòn ch'a podìo. Lòn ch'a conta pi che tut, per lor a l'é la bona volontà ant la fatiga e l'amor ant le còse bele.
E mach per amor dla poesìa a l'han stampà st'Armanach.
L'Armanach, nel pubblicare il bando del secondo concorso di poesia La bùssola di Brandé da conto, a firma di Giacolin Sacerdote, del risultato del primo bandito con l'Armanach del 1933. I vincitori: Pinin Pacòt con la poesia I me vej proposta quasi in coda all'almanacco. Tra i premiati poi Carlottina Rocco e Alfredo Nicola.
Ed ora i contributi, a mio avviso, più significativi.
Si inizia con Me galet racconto di Nino Autelli, cui più avanti segue anche Masnà, poi ripresi appunto in Masnà, la sua seconda raccolta che uscirà nel 1937; Pinin Pacòt, in un Leturil, recensisce la Grammatica piemontese data alle stampe nel '33 dal prof. Arturo Alì Belfàdel. Pacòt chiosa:
...perchè con tut l'amor ch'a j'é an gir per nòst dialèt, as vèd che l'autor a l'ha nen podù trové a Turin n'editor ch'aj la stampeissa. (Tipografia L. Guin di Noale VE). Dopi merit, per lòn, dl'Alì Belfàdel, che, bele con un nòm così pòch nostran, a l'é tant bon piemonteis e studios generos, da nen avèi paura 'd paghé 'd borssa soa, per deje anfin al pùblich col travaj serio e complet, difeisa e ilustrassion 'd nòst dialèt, che da tant temp a spetava. Dopo i travaj dël medich Pipin, per i temp tut autr che da despresiesse, che ant ël 700, a l'avìa stampà, anssema a n'antologìa e a un vocabolari, la prima gramàtica piemonteisa; costa dl'Alì Belfàdel as peul bin disse la prima gramàtica moderna 'd còst nòst dialèt, nen mach, ma per la serietà rigorosa dla preparassion e dël método, per la cura dl'ànalisi, per la precision dle definission e dle classificassion, per ël bon gust e l'oportunità dle esemplificassion, as peul 'd cò disse un di pi bei e pi important studi gramaticai d'un dialèt, ch'a podrà erve d'esempi a jë studios dj'autre region. A l'era un travaj necessari, dël qual as peul pròpi disse, con na frase frusta, ma sta vòlta giusta, ch'as në sentìa lë bsògn, Parèj, adess, ant ël pian ëd nòstra librarìa destinà ai liber piemonteis, da fianch al Dissionari etimològich piemonteis d'Attilio Levi a trovrà sò pòst natural la Gramàtica d'Alì Belfàdel.
A pag. 20, in alto a destra, quasi a volerla nascondere, una breve composizione di Nino Autelli che mi piace riportare qui in quanto risveglia tanti ricordi della mia gioventù:
Saba Sant
Pena a së spantiava ant l'aria dossa d'avril ël prim bòt dle ciòche ch'a sonavo baudëtta,
(e 'l sol, a l'improvisa, a surtìa fòra dle nìvole)
via che ti t'corìe ant l'òrt a 'mbrassé una per una, le piante bele fiorìe 'd perssi, 'd pom, e 'd cerese;
e peui, su, con l'ànima an festa, a lavete la facia rijenta ant l'eva bela ciaira che Mama at tirava dal poss.
E chila - it ricòrde? - at disìa parèj ëd nen suvete j'euj,
Così ch'at restava an sima le parpèile, e it la sentìe 'd cò ant ël cheur, na rosà tuta frësca coma cola ch'a lusìa an sl'erba novela.
Luigi Olivero, quasi in coda, ci da un bel ritratto di Alfredo Nicola Alfredino un e doi quasi una presentazione dell'appena uscito Primavere. Polemizza con la lettera di Nino Costa utilizzata da Alfredino come prefazione, non trovandosi d'accordo con la frase ...gavà dontré fra le pi bele poesìe, da cost liber aj seurta ancora nen l'ànima e 'l caràter dl'autor.Vale la pena andare a rileggere sia la lettera di Nino Costa che il pezzo di Luigi Olivero. Olivero detta poi un accorato ricordo An mòrt ëd Dino Campana mentra Pacòt e Sacerdote tracciano quello di Alfonso Ferrero.
Della poesia contenuta nell'almanacco, un breve accenno.
Nino Costa presenta Lauda 'd Maria composta nel settembre del '33 che accompagna La Madòna dle fior - Misteri rievocazione in forma di dialogo del miracolo avvenuto a Bra il 29 dicembre del 1336 rappresentato dalla bella incisione siglata Franco XII (Franco Bertoni, 1934 anno XII E. F.).
Carlottina Rocco con Madòna montagnina, Château Beaulard; Aviator di Alòdo Daverio; Armando Mottura La Cansson dël Travaj; ancora di Nino Costa Le stra dedicata a Pinin Pacòt; Tre cotlà d'òr a la luna è il contributo poetico di Luigi Olivero; Alfredo Nicola Aque tërbole; Ël bòsch di Renzo Brero; Renato Bertolotto L'ùltima compagna.
Fra i 40 colaborator a cost fassìcol a j'é gnun Pëscador ëd Ciaraval an bombëtta e aquascutum con tuti i gàmber dël passà ch'a jë scapo da 'nt le sacòcie e aj manca assolutament ël Nostradamus an pantofle armà dël fly-tox dël criticaire për sghiceje 'l marin sech an sla facina robia e soridenta dl'avnì ch'as fa anans ant ël ghërmo dl'ann 1935.
Tuti sti 40 colaborator a l'avìo quaicòs da dì an dialèt piemonteis. Avèi quaicòsa da dì an dialèt piemonteis, ancheuj a signìfica pi nen fé rimé sartoirëtta con scarpëtta, bochin con basin, cheur con maleur, fé dle longhe tiritere geològiche për conté i risultati sentimentai ch'a l'ha dait l'esame microscòpich ëd tute le giaire dël Valentin, le pianà legere ant un pra 'd margherite, i cavèj biond ò ross ch'a l'é rëstaje an sla fodrëtta 'd seda d'un cussin.
Scrive an dialèt, për i 40 colaborator ëd cost ARMANACH PIEMONTEIS 1935, a l'ha vorsù dì esprime quaicòsa 'd përsonal, viv, sentù - ant una forma moderna ò tradissional, con un sentiment entusiàstich ò sagrinà - ma dovrand cola SINCERITÀ che, ancheui, a l'é la fisionomìa ùnica e luminosa dla figura italiana.
Ho riprodotto quasi per intero il brano d'apertura che non reca alcuna firma, dal tenore e dal vocabolario utilizzato lo riterrei non di Pacòt, ma di Luigi Olivero, magari un po' temprato da Pinin.
Anche questo almanacco A l'ansëgna di giovo si apre con una poesia di Nino Costa L'erpi, quindi Pinin Pacòt da più spazio a Luigi Olivero che presenta varie poesie e scritti: Danse neuvsent con le poesie Charleston, Rumba, Ranchera e ancora Algerina e Doe mistà pagane: La Madonina 'd mesaneuit e Ël demòne 'd mesdì, quindi, in Poesìa 1935 la lunga recensione della appena uscita dai torchi raccolta poetica di Pinin Pacòt Crosiere.
Ancora Nino Costa presenta il nuovo lavoro di Carlo Baretti, il poeta di Mondovì Salutme 'l Mòro!
Italo Lorio, scrittore della nuova corrente futurista, amico di Olivero e con lui alla rivista di Pitigrilli, le grandi firme, si occupa dell'avvenire della pittura piemontese. Carlottina Rocco seguita con le sue poesie valsusine Savoulx; Valldemosa di Daverio dedicata a Chopin; compare Mario Albano con Stèile, poi Renato Bertolotto con Tramont, La cantilena dla pinera.
Giacolin Sacerdode, chiedendosi Chissà perchè as parla mach di poeta dialetai e mai 'd coi ch'a scrivo an pròsa? ci da un ritratto di Giovanin Casalegno di cui offre la novella Batista.
Ancora poesia con Domse da man... di Armando Mottura; quindi un altro racconto di Nino Autelli La mare 'd San Pè già proposto in Pan 'd coa.
Pacòt presenta poi quattro poesie sotto il titolo Istà: Amson, Erbo, Ant ël vent, La fin dl'istà.
Di Armando Mottura il racconto Seìra an montagna; Vincenzo Signorino ci racconta della canzone piemontese a Aldo Daverio ci da un ritratto della pittrice Mercedes Tommaselli.
Va ancora rilevato che, a partire dall'almanacco del 1934, è notevolmente migliorata l'iconografia dei volumetti con le belle incisioni e i dipinti di Franco Bertone.
Come già anticipato, il 1935 è anche l'anno in cui Pinin Pacòt licenzia la sua seconda raccolta di poesie, Crosiere che contiene 45 componimenti. L'opera non ha prefazione nè apparato iconografico salvo un'incisione anonima al frontespizio ripetuta sulla copertina.
Presenterà lungamente Crosiere Luigi Olivero, come già detto, nell'Armanach 1935, eccone uno stralcio:
È në bsògn d’evasion, un mal sutil e tajent ch’aj fronsiss l’ànima, coma un fil ‘d seda bandà, ‘l mal che provoma tuti noi giovo: andé, navighé, volé, perdse ant ël lontan ëd la tera, dl’eva e dël cel; për savej, për vive fina a la fin nòstra pena, për lese ant j’eui d’òmini ‘d tute le rasse e ‘d tuti i canton còsa a l’é ch’a j’avisina, còsa a l’é ch’a j divid; për gòde ‘d na libertà sensa fren, d’un galòp ëd vitòria, fòi ‘d sol e d’asur, anciocand-se dël vin ëd j’obade e nutrend-se dle fëtte savurìe d’j’amlon ëd tute le lune pì caude d’amor.
L'Armanach per il 1936 si presenta, ancora una volta, con una precisazione d'intenti, ancora redazionale:
A farìa nen dabsògn, ma a l'é sempre mej torna sciarì che l'ARMANACH PIEMONTEIS a mostra nen a fe i tajarin ant-ë cà, a dà nen i nùmer për vince al lòt, a dis nen coma a venta fé për conservé da le càmole la smens di bigàt, a consija nen l'época giusta për buté la cioss a cové, aj sugeriss nen a le fije 'd famija la manera 'd pësché 'n bon marì, av marca nen i dì cuvert che deve seurte con ël parapieuva ò le giornà bele che peule vestive da mëssa. L'ARMANACH PIEMONTEIS a l'é nen la Sibilla Celeste.
L'ARMANACH PIEMONTEIS a l'é na publicassion leteraria, compilà da 'd giovo për i giovo, sensa specé d'autre tendense che cole (drinta ò fòra dël sëmnà ch'a sìo) ch'a esprimo i giovo. E a fa nen dë bsògn ëd di che la gioventù a peul duré ant ël cheur tuta la vita.
Ma l'ARMANACH PIEMONTEIS a ilustra 'd cò nen la Bibbia an ë-stil futurista: a 'v presenta semplicement un arch-an-cel polid ëd la mej produssion leteraria 1935 ëd 22 sërvei piemonteis: 22 sërvei giovo: garantì e patentà.
Direi che anche questo scritto rifletta più il pensiero di Olivero che quello di Pacòt, in particolare per lo stile letterario che utilizza. E a questo proposito vorrei far rilevare come, mano a mano che gli Armanach escono, sempre più la grafia utilizzata si affina.
Le prime pagine, come di solito, sono aperte da L'erca di Nino Costa.
Quindi, ancora una volta grande spazio ad Olivero con il suo molto polemico Silabare dël poeta neuvsent piemonteis. Sarebbe interessante riproporre tutte le 23 lettere che compongono il Silabare e che occupano ben sei pagine. Ne offro solo alcune:
COSA pretendo costi vej avans ëd carògne antidiluviane ch’a bato i pé doss su 154 sìlabe con ëd cadense e ‘d pensé di temp ëd Madama Real?
A vëdne nen, con i sò euj catërlos, che la pelìcola dla vita a l’è pi nen la medesima ‘d Lumiere ma ch’a presenta d’autre sene, d’autri gest, e che ‘l sò coment a l’è pi nen col d’un piano dëscordà, sonà da ‘d pé fiorì d’aiassin, ma ch’a l’è fait da ‘n còro ch’a ‘ntona le vos medesime dla vita?
A sent-ne nen ch’aj socrola da tute part un frisson neuv, una volontà inedita, në slans modern, n’ambission cauda ‘d superament?
Nò. Le veje carògne né vëddo, né sento. I sò euj a son sensa vista, i sò òss a son sensa miola. E ‘l sò fòsforo a traspariss pi nen – gnanca ant le neuit caude d’istà.
DOMJE na socrolà dë spale a la pover dël rispet tradissional. Domje un colp ëd batipover an sla schina di pi gargh: e peui piomje për man e tiromje con noi ant ël vent. Respiroma, e mostromje a respiré, a gola duvèrta e a nas liber. Sentiroma, e as sentiran, i polmon arsolà e le giàndole ambotìe: coma se ‘l buracio uman ch’a pendìa ai fìi dël pregiudisse a sia dësvijasse a l’improvis con una volontà soa, con una veuja ‘d vive soa, con un’ànima, un’ànima soa che chiel a savìa nen d’avèi e che adess as treuva duverta – coma na fior ch’a bèiv ël cel con una sèi sensa fin…
E BASTA con i Brichetaire filòsofo, La bagna di povron e La vita sgairà, ch’a son nen poesìa. Përchè i giovo maravijos ch’a l’han nobilità soa vita ant le trincere dël Carso e ch’a son dventà filòsofi ant i Kriegsgefangenenlager rusiand i tross di povron; e noi, ancora pi giovo, che l’oma frustasse l’ànima e la sòla dle scarpe a sërchesse ‘n tòch ëd pan an s’i marciapé dla disocupassion internassional; noi, poeta sarcàstich, brutai, insensìbii ai fidlin dël ciairdluna e a le gnògne slavà di sensacojon; noi, i l’oma na concession motobin diversa e rispetosa dla poesìa.
FEDE ‘d nascita - ò pedigree? – dla nòstra poesìa.
L’oma ‘mparà a trovela, vestìa an piemonteis, su n’idrovolant a quota 6000 an vòl su l’Acròpoli; su jë vlu d’un-ë sleeping atravers ël Mitteleuropa; sul pont d’un batel fracassà da la tempesta an mes al Mediterraneo; për na contrà spagneula foratà dai fusìi dla rivòlta; ant una benna ‘d paja e ‘d cìmes an sle seuje dël Sahara; drinta la gòi tëbia e paisana d’una casòta vërdarossa dla campagna piemonteisa.
Poesìa a l’é tut lòn che dla vita a intra ant noi; rosà velenosa ò parfumà, soris inossent ò schèrne ‘d rivòlta; për fene sgnor anche se strasson, gentìi anche se sostansialment maleducà; për che dle nòstre emossion i na fasso un colié ancërmant e pressios da argaleje al desidere ‘d perfession ch’a j’é an fond a tuti.
GIGANT ëd pera, con la testa coronà ’d tute le stèile dël firmament, Dante, su le seuje ansangonà dla stòria ‘d nòstr pòpol, a ricòrda al pòpol che ‘l prim linguage adat a esprime la poesìa dla vita a l’é ‘l dialèt
Ël dialèt, compagn dël vent e dla buria, creatura arsonanta nà da la tera e dal mar, batesà dal travai, faità a la pas e a la guèra, sensibil a le vibrassion ancreuse e sempie dj’element përché sciodù da le vos medesime dj’element dla natura: ch’a son vivi ant ël pòpol përché ‘l pòpol a l’é mangiatera: come as ciamo i paisan tra ‘d lor.
Retòrica, sité Dante? Nò. A l’è motobin pi retòrich chërde che ‘l dialèt bantù o l’esquimeis, l’awaian ò ‘l piemonteis a peusso nen esprime con nobilità la poesìa dla vita: quand che fina le serve dël Polesine e dla Basilicata a riconòsso che tuta la mùsica, ‘d tute le part dël mond, a peul esprime elevassion e sentiment.
LAVESSE j’euj ant ël dì ‘d Santa Lussìa, a l’é il pi bel sìmbol ch’a l’abio ansignane da masnà. A l’é nen mach una parabòla dla mitologìa cristiana: a l’é un consèj d’igiene spiritual che tut òm a dev compì ant l’età dël giudissi.
Lavomse j’euj ant l’eva di rì e aussomie al cël pë ch’a së specio ant l’azur e për ch’as lustro a ch’as suvo ant la sàbia d’òr, splendrienta, dël sol.
ÒH! le ragnà che l’oma dovù dëstaché da l’edifissi liberty dla nòstra coltura! Che ‘d bergamine, che ‘d cartasse inùtii e pretensiose l’oma dovù argalé ai tnivlòt di dentin aùss di giare e a le perforatris autògene naturai dle càmole di solé. Che bele fantasìe ‘d tribù ‘d bòie panatere l’oma dovù organisé, për trovesse tranquìi., anfin, con nòstra cossiensa e scoté nòstra sensibilità novela, fërbëlla, dësdeuita, ma viva, ciaira, fantasiosa: ch’a cor a pé dëscàuss an sle strobie e longh ai senté; ch’a scota – con le gambe an aria pataria – ‘l motor ëd n’aeroplano ant l’azur; e che s’aj taca ‘l vërtigo ‘d fé un pecà sla sponda d’un ri a lo fa e s’aj taca ‘d contelo a lo conta ‘d cò!
PECÀ! E-lo pecà fé l’amor? A sarìa un pecà nen felo. E përché nen canté l’amor: caud, liber, naturista, angorgà ‘d passion primitive, coma lo sentoma noi giovo - e nen coma lo subiave voiautri pé doss quand che fasìe i vasco con ël colèt ëd celulòide, la farinata an s’na bija e le braje streite?
Lassene un pò’ canté l’amor a nòstra manera; ché tant, anche s’a varia ‘nt l’espression, ël gest a cambia nen. E ‘l risultato a l’é sempre ‘l medesim: i cit ch’a j’avnirà da noi – coma coi ch’a son ë-vnù da voiautri – a jë smijran a le mame e le cite a jë smijran ai papà.
Lassé che canto l’amor a nòstra manera.
QUATÒRDES vers a basto për fërmé un mond poétich, quand che ‘l poeta a l’é dabon un poeta (sismògrafo dla sensibilità soa e dla sensibilità dël mond ch’a gira d’antorn a chiel) e nen mach un beduìn dle rime ch’a mena quatr fèje tosonà e quatr con ël pèil long, tre berine bianche e tre grise, a pasturé për ël desert d’un concet desolà, cissandje con òndes colp për vòlta cadensà su la tòla da petròlio dla métrica tradissional.
14 vers sensa firma a peulo fé dì queich volta: «sossì, dal deuit, a l’é na poesìa ‘d Nino Costa», «son a l’é na lìrica sgnora ‘d Pinin Pacòt».
Përché? Përché ‘l poeta a l’ha durvì la fialëtta ‘d soa ànima e a l’ha versane un pò’ dla soa essensa su cole quatòrdes righe ‘d piomb ch’a peulo avèj fait pioré ‘l lynotipista ch’a l’ha componuie.
E, sovens, a basta un titol, un nòm, un agetiv, a cataloghé un poeta.
E Pacòt insiste con lo spazio per Olivero. Gli dedica un bel ritratto di due pagine con due fotografie:
La poesìa a l'é parèj 'd na bela fija. E a le bele fije aj piaso i bei fieui dësciolà e franch che, combin ch'aj rispeto, a perdo nen ël temp an gnàgnere sentimentai al ciair ëd luna, coma a fan i bravi fieui ëd famija che, nen ancalandse a parlé, a basso le parpèile ansima ai bruti pensé ch'aj fan avnì ross. E 'd bravi fieui ëd famija, romàntich e coma as dev, ch'a s'ancalo nen a parlé, ò ch'a san pa còsa dije a le fije, aj na j'é 's cò tanti ant i salòt bleussiel dla poesìa sentimental al lait ëd gomo.
Olivero, anvece, a l'é un fiolin drit e degordì, ch'a sa avsinesse a la poesìa con l'istessa sincerità e sensa gena, ch'a s'avsinnerìa a na bela fija dla Vila, là 'nmes a l'òr di gran sota la gran serenità dël cel d'assel, antant che chila as na va cantand e j'euj aj rijo, an brass al sol ch'a l'anlupa 'd calor e aj gonfia l'ànima 'd veuje e 'd libertà. Poche paròle drite,
e baci e strilli su l'accesa bocca
mesconsi... (Carducci)
Con doi euj foinù ch'a fisso sensa bassesse e un bel soris posà an s'i làver parèj 'd na sigarëtta avisca, con un ghëddo degordì e sovens alégher, Olivero, come a dev piaseje a le fomne bele, così 'd vòlte aj dà 'n s'i nerv a certi gilichèt aserb e a certi moscardin madur e bièt, ch'a son gelos ëd chiel, perchè la poesìa aj va sot-brassëtta, parèj dle bele fije. Eh, sacherlòt! l'é giovo; e poi i poeta a son sempre giovo!
E giovo, Olivero, a l'é, nen mach per l'anàgrafe, ma pi che tut per soa manera barivela 'd sautesse a cavalina, con ëd ciombe fiamenghe, tre ò quat sécoi ëd poesìa dialetal piemonteisa, e 'd feje na bela rijada ansima! Ma sì, le tradission, le scòle, le manere a valo giusta mach per cola pòca poesìa ch'aj sarìa l'istess, sensa la tradission, le scòle, le manere. E che Olivero a rispeta ò a rispeta nen la tradission, ch'a pija Viriglio per un gran òm ò mach për l'autor dla bagna di povron, tut lo-lì a l'ha gnune importanse; basta mach che la soa a sia poesìa. ...
E quand che 'l pojin l'ha podù drissese sle gambe drite e sutile, e a l'ha podù pié l'andi, a l'é partì con tuti i seugn, travers a le stra dla fantasìa e travers le stra dla tèra. Fratel pi giovo 'd Rimbaud, e 'd tuti j'autri vagabond ëd le stèile. E la poesìa ch'a l'avìa an chiel a l'ha portala an gir për ël mond, dai mascheugn angossant dle metròpoli d'Euròpa, al misteri bianch di vilagi african solitari e sperdù an brova di desert, a le campagne vërde frësche e riposante 'd cà nòstra; a l'ha portala in gir ansima a j'onde tempestose dël mar, për le stra - vent e nìvole - dël cel, longh le rotaje lusente e an si stradon bianch ëd ëd póver, daspertut dova che lë bsògn ò ‘l desideri a lo portavo, per trovela sempre e mach an chiel, tëssùa, con tute soe angosse e soe rivòlte, con tute soe veuje e soe gòi an sël tlé cadensà, tra un seugn e na pena, ‘d soa ànìma doleuria profonda. Cola ch’as vëd nen sota ‘l rije tajent dël polemista dësbrilà e bìrichin, ch’a dòvra la lenga sutila e pontùa, parèj d’un fiorèt, ch’a vòla improvis da la tersa a la quarta, per parte decis ant lë slussi ‘d n’afond sensa parada.
Polemista per temperament, moschetié dël Re, d’Artagnan ëd la poesìa, per chiel tute j’ocasion a son bone per tachesse con le guardie del Cardinal. E guardie del Cardinal, per chiel, a son tuti coi che ‘d sòlit a scapo, për stërmesse a l’avait darera j’erbo, pontand lë spaciafòss contra l’alegra cavalcada ch’a s’avsina cantand, con le spa al sol e con le piume al vent. Per lòn a l’é fasse, forse, pi ‘d nemis che d’amis. Bon segn. L’òm, soa arte, soe idee a son nen indiferent. E a va bin.
D’autra part, lòn ch’a conta pi che tut ant un poeta a l’é peui mach soa poesìa. E Olivero, poeta a l’é. ‘L volum ch’a stamprà prest a lo proverà, portand na nòta tuta neuva ant la poesìa piemonteisa, marcand na personalità original ëd poeta, ch’a mancrà nen ‘d trové tanti ch’a vorran discutlo sensa capilo, ma a troverà ‘d cò queicadun che, an nòm dla poesìa, dòp d’avèilo lesù, a dventerà per sempre sò amis.
Seguono, dedicate a Pinin Pacòt e sotto il titolo di Paesagi sota la fòca le due poesie di Olivero Tristitia e Confiteor, quindi ancora Mè rosare neir.
Pacòt traccioa quindi un bel ritratto di Casaleggio e della sua compagnia teatrale.
Di Nino Costa viene poi proprosto un Bossè ant un at La dota 'd Maria ed ancora un'intervista all'attrice di teatro Na ciaciarada con Maria Sanquirico.
Pacòt presenta poi La Dòra ancërmà (La Dzouére entzarmaie)della poetessa valdostana Eugenia Martinet.
Sempre di Costa poi, tratto da le Storie 'd me Nòno, L'aso a vòla.
Aldo Daverio ci da un ritratto del poeta Giovanni Gianotti e Nino Autelli propone Ël moscon dël maleur che troverà poi posto in Masnà.
Oltre le poesie già citate Casté d'Anòn di Pacòt; Canson 'd vendumia e Quat cite faule: I povron, Ël tarpon, Bianch e neir, Doi gàmber di Alfredo Nicola; di Aldo Daverio Muraje; Tramont di Armando Mottura; di Carlottina Rocco Quat moment: Ciòca lontana, L'arbra sola, Luna, Fontana.
L'almanacco si chiude con la pubblicazione del N° 7 de la Colana Musical di Brandé con tre canzoni per canto e piano It veusto vnì testo di Carlottina Rocco e musica di Alfredo Nicola, La valanca testo di Pinin Pacòt e musica di Nicola, La spina testo e musica di Nicola.
Mè car Pacòtt.
Grassie dl'invit a la collaborassion per l'Armanach 1937.
Ti t'sas coma i l'hai sempre goardà con simpatia e cercà 'd giuté an tute le manere vòstr moviment d'i Brandé - per lòn ch'a rigoarda lë slanss dla gioventù e 'l desideri ëd fé 'd poesìa bela e neuva.
Ma j'ani a passo, purtròp, e con mia età e mia fasson ëd vëdde le còse (ch'a l'é, forsse, na conseguenssa dl'età) adess im sento nen d'esse nì d'i vòstri, nì d'j'aotri.
Per lòn iv prego, per cost'ann sì, ëd lasseme an dispart, bin sicur che l'Armanach 1937 a sarà na pubblicassion viva e interessanta bele senssa mia colaborassion.
Con na streita 'd man e tanti auguri.
NINO COSTA
Ritorna qui la vecchia diatriba tra i seguaci di Pinin Pacòt aggregati nella Companìa dij Brandé (i vòstri) e i poeti rimasti fedeli alla tradizione rappresentata dal giornale della Famija turineisa: 'l caval 'd brôns attorno al quale altri poeti si raccoglievano (gli aotri).
Pacòt la prende veramente male e così risponde sullo stesso Armanach riferendosi anche alla lettera ricevuta da Giovanni Gianotti che si offiva lui stesso per collaborare:
Vous l'avez voulou, George Dandin, vous l'avez voulou
Ste doe létere a l'han pa dë bsògn ëd coment. A son così ciaire, ant lë spirit e ant la forma, ch'a basta lesje per capì ch'as peul esse ancora giovo a 70 ani e meno a 50. E noi ringrassioma Giovanni Gianotti, - ël poeta 'd «Fërvaje d'ànima», ch'a festegia coat ann i sò stant'ani, - che da soa bela autura d'ani a sa guardé con tanta smpatìa i giovo ch'a marcio a metà còsta, coma s'a l'aveissa ancora 'l boneur ëd marceje ansema, ansi sentendlo, col boneur, ant la frësca gioventù 'd sò cheur.
E i ringrassioma 'd cò Còsta. Na paròla ciaira a l'é sempre un regal da amis.
Giumai chiel a l'é vej (j'ani a passo, purtròp!) e con soa fasson ëd vëdde le còse chiel adess a peul pi nen esse nì di nòstri nì dj'autri. Verament noi i savìo nen ch'a j'esisteissa d'autri. Aj na sarà magara, ma noi ij conossoma nen. Anvece Còsta a treuva ch'a l'é bel esse amis con tuti, fin-a con i fantasma. Ansi! E così sia!
E a sarìa bele finì, con n'ùltim ringrassiament a Còsta per i sò auguri, bin sicur 'd cò noi che l'Armanach 1937 a sarà na publicassion viva e interessanta, bele sensa la soa colaborassion.
Ma i duvoma recité 'l confiteor:
Fin-a al 17 otober ëd cost ann, Costa i l'avoma sempre consideralo coma nòst Maestro, con tanto d'M maiùscola; e i l'oma fait bin, perchè ch'a l'é bel che i giovo a rispeto i vej, prima 'd tut perchè ch'a son vej. Ma i l'oma avù tòrt.
L'oma avù tòrt perchè Costa a l'era nen e a pudìa nen esse un maestro per noi. Chiel a rapresenta la fin d'un temp e noi i l'oma la preteisa d'esse 'l prinsipi 'd n'autr. Chiel a l'é la continuassion, e, diomlo sùbit, pi artìstica e pi dignitosa, di Viriglio, di Fasolo, di Rico, di Solferini, etc. etc.; e a sti modei a sa nen rinonsieje; l'istess coma a savrìa nen rinonsié a la spassgiada da ses a sèt sota i pòrti 'd Pò, ant la veja religion dla faseusa e dla sartoriëtta, Poesìa dialetal per ecelensa.
Un òm sol, ant ël torment ëd soa granda ànima inchieta, a l'ha avù 'l coragi 'd ribelesse a la fum 'd mese toscane ch'a lo sofocava: Fonso Ferrero. E bele mach an passand i s'inchinoma dnans a soa memòria.
Ma Costa a peul nen dëstachesse da tuta soa nostalgìa bicerina e a resta, per lòn, ancora, Esposission Universal 1911.
Sì, l'oma amparà da chiel ël bel piemontèis, pur, armonios, sgnor e polid; l'oma amparà da chielò coma ch'as martela 'l vers e coma ch'a s'antërsa ant la stòfa pien-a e legera, armoniosa e fòrta. Ma l'é nen stit un maestro 'd vita, nen un maestro 'd poesìa. Coma ch'i s'iludìo noi ch'a fussa.
Nòstra gioventù l'é staita sùbit tròp provà, e la vita i l'oma conossula tròp prest ant lë splendor ross dla tragedia, per nen rivé 'd colp a capì che la poesìa, coma la vita, a l'é quaicòsa 'd pi profond ò 'd pi aut, 'd pi sutil ò 'd pì grand, che i pòvri sonèt e le maire strofëtte dla poesìa dialetal piemonteisa. E se la poesìa i soma nen rivà sempre a fela nòstra, ant l'ingenuità 'd nòstra arte, i l'oma però avù 'l sens 'd lòn che la poesìa a l'é, ò, almeno, 'd lòn che la poesìa a l'é nen.
Questo scritto, violento, ed anche cattivo, rappresenta, probabilmente, uno sfogo dovuto più che altro al suo orgoglio ferito dal rifiuto di Costa a collaborare.
Nel secondo numero della sua nuova rivista, la seconda serie de Ij Brandé del primo di ottobre del 1946, con Costa morto l'anno prima, Pacòt rivede nettamente quei suoi giudizi dettati con tutta probabilità da uno scatto d'ira:
La poesìa 'd Nino Costa a l'é vnua al moment giust. Quand che jë scritor dël temp ëd Viriglio, e ij sò imitator, a l'avìo ormai dit soa ùltima paròla neuva, e quand che le tendense giovo'd nòstra poesìa, preanunsià da Alfonso Ferrero e da Giovanni Gianotti, a l'avìo ancora nen trovà la tonalità giusta për esprimse: ant col moment che la poesìa piemonteisa a smijava ch'a stèissa për finì, Nino Costa, cujend lòn ch'a j'era ancora 'd viv ant l'eredità dël passà, rimontand ansi quaich vòlta pi an su, fina a Brofferio, fina a Calvo, e interpretand le aspirassion 'd rinovament ch'ancaminavo a fiorì d'antorn a chiel, a l'ha savù fonde ant soa ispirassion, ël vej con ël neuv, e tnisendse bin atacà a nòstra tradission nostrana, sensa arneghé la viva esperiensa poética moderna, a l'ha dane cola soa poesìa, così piemonteisa e così soa, che partend da na manera squasi popolar a l'é rivà, travers a na decantassion interior e sutila, a d'espression liriche da gran poeta.
Rispondendo poi a chi gli ricordava del suo ripudio di Costa nel 1936, va ancora oltre:
... për noi Nino Costa a l'é stait un maestro 'd poesìa; un gran maestro, i l'avoma dilo e i lo ripetoma, liberament sia pure con tute le riserve che an sede crìtica i chërdoma bin ëd fé. Gnente a peul sgrisé'l sentiment 'd riconossensa e d'amirassion che noi i l'avoma për col che, malgré certi moment d'incomprension e 'd dissens, recìproch, a l'é stait për noi n'amis e n'esempi. I ricordoma l'ùltima visita ch'i l'avoma faje, pòch temp prima ch'an mancheissa, e soe paròle serene e soa streita 'd man afetuosa a son staite për noi coma un pegn d'amicissia e 'd poesìa. I dësmentiroma mai pi sò ùltim salut!
In altra occasione ancora ( 1 dicembre 1946) aggiunge:
E adess i podoma afermé tranquilament, dòp che la mòrt a l'ha portalo via, che tuta soa òpera 'd poeta a resta coma n'esempi magnifich, al qual i dovoma ispirese noi-autri pi giovo ch'i së sforsoma d'esprime an bela forma 'd poesìa col pòch ò tant, che 'l cheur an deta. E për lòn i lo ciamoma maestro.
E dopo questa lunga premessa, eccomi all'Armanach per il 1937.
Il nuovo almanacco si apre, su due pagine, con una poesia di Pinin Pacòt volta a celebrare l'Impero Fascista. Ecco che ne dirà Giovanni Tesio in un suo lavoro dal titolo Tra Costa e pacòt In margine a un centenario (e a un'antologia) pubblicato sull'Almanacco Viglongo del 1987:
Ma anche Pacòt non manca di accendere il suo lumicino alle glorie dell'Impero e l'«Armanach Piemonteis 1937-XV» apre con un suo epinicio-epicedio intitolato A. XIV E. F. nel primo anniversario della conquista.
Riproduco alcune strofe della poesia (composta da 10 quartine):
I soldà mòrt lagiù, da quarant'ane
a l'han montà la guardia ant i valon
e an s'j'ambe antorn al pass d'Enda Chidane,
spetand i viv, sle veje posission.
E i viv, i fieuj, a son avnù, lassand
piantà la slòira drinta i sorch laurà;
l'han passà 'l mar e a son rivà, cantand
d'nans a la mòrt, parèj d'annamorà.
Otugn d'Italia, luminosa prima
d'Africa an arme, an sl'alba ansangonà
l'é coruje na lus da sima an sima,
quand che a l'arbomb dla prima canonà.
l'é slargasse marciand coma na pien-a
prima lontan e peui sempre pi fòrt,
ël pass di fieuj da l'ànima seren-a,
ch'a son avnù per deje 'l cambi ai mòrt.
E adess i mòrt a peulo deurme an pas,
che la vitòria a l'ha forsà 'l destin.
A son scapà da la paura i Ras,
e i fieuj di mòrt a fan la guardia, e bin!
...
Brun-a congiò, chita tò cant ëd mòrt
e fate anans e crija l'elleltà,
che 'd cò per ti a l'é cambià la sòrt,
e 'd cò per ti un di pi bel l'é nà;
e aussa 'l brass, che 'd zora aj batajon
a vòla e a splend la volontà d'un Om:
brun-a congiò, dësmentia toe canson,
e crija fòrt, con i soldà, sò Nom.
(Enda Chidanè, guerra italo-abissina. Battaglia detta di Adua. Qui il primo marzo del 1896 fu distrutta la colonna di sinistra dello schieramento italiano. La colonna, comandata dal generale Albertone, era forte di quattro battaglioni indigeni, bande dell'Acchelé Guzai (messe a dsiposizione dal capo abissino Batha Agos), 4 batterie, per un totale di 4.076 uomini e 12 pezzi d'artiglieria. - Congiò: ragazza; ellaltà: grido di gioia delle donne abissine)
Luigi Olivero presenta la sua Ël bòch, cui fa seguire la recensione di Masnà di Nino Autelli del quale. tratti da Masnà, seguono i raccont: Nòno, Vigilia 'd Natal (Natal an sël brich in Masnà), La muda neuva, Le masse.
Seguono due poesie di Carlottina Rocco: A smìo 'd róndole... e Acqua përsonera; di Carlo Baretti L'àngel biond.
Pacòt dedica un lungo ricordo per i sett'antanni compiuti da Giovanni Gianotti con la sua poesia Nebie an colin-a.
Di Alfredino vengono offerte Stèmber e Ondin-a, quindi Lo bagazdo de veula ('l bagagi 'd sità) della poetessa valdostana Eugenia Martinet con annessa traduzione di Pinin Pacòt.
Viene poi presentata Seira an montagna di Renato Bertolotto e un ritratto del pittore Felice Vellan proposto da Pinin Pacòt.
Di Armando Mottura il racconto Voleur dedicato ad un cane da pastore; in conclusione , sempre a cura di Pacòt, una rassegna teatrale ed alcuni giudizi espressi da giornali piemontesi sull'almanacco del 1936.
Nella rivista del comune di Torino, Augusta Taurinorum, a firma M. B. a proposito dell'oliveriano Silabare:
Un originale «Sillabario del poeta novecento piemontese», fissa con un'andatura volutamente caprioleggiante e polemica quali sono i doveri di modernità e di totalità ottimistica della poesia vernacola che non intende ingiallire fra gli scarti di magazzino librario e finire illibata nella carta da macero. Il primissimo di questi doveri è l'italianità dell'ispirazione, quindi la freschezza di respiro, l'originalità, l'abbandono dell'arido formalismo. Olivero, autore di questo"Sillabario", è andato più in là di questi canoni: ha presentato un esempio di lirica coloniale che è una strana mescolanza di sogno e di realtà e che al rilievo artistico aggiunge quello dell'inedito nella poesia in dialetto.
Nella Gazzetta del Popolo Enzo Ciuffo:
...non si tratta di una miscellanea incoerente o di una raccolta platonica di pezzi di bravura, come sarebbe lecito supporre: c'è nella scelta un certo piglio rinnovatore e una certa spregiudicatezza polemica, del quali, del resto, dà ragione, fin dalle prime pagine del fascicolo, un «sillabario del poeta piemontese novecento», che è un gustoso e vivace richiamo ai còmpiti attuali della poesia.
L'Armanach per il 1938 cambia in parte veste. Inizia con alcune pagine pubblicitarie tra le quali si inserisce un racconto di pacòt Ël machinista an pension.
Ecco ora l'introduzione, ancora una volta anonima:
8 ani 'd vita a son pòchi per n'elefant, per un cocodril ò per la barba 'd Matusalem, ma a son già tanti per na publicassion coma nòstr ARMANACH PIEMONTEIS, ch'a viv mach dla bon-a volontà ëd pòchi poeta, che a coltivo ancora l'ilusion, che ant ël gieugh ëd la vita la poesìa a serva a quaicòsa, fussa nen autr che a fé bela la vita. N'ilusion, ch'i speroma che i letor a condivido. Per lòn i j'ofroma un pòch ëd nòstra modesta poesìa, content se quaicadun, lassandse 'd cò chiel ilude dai nòstri seugn, a l'avrà per un moment - pa mach per un moment - dësmentià la realtà 'd soa vita e trovà 'l cit confòrt 'd na paròla.
Na paròla sola - sempia brava uman-a fraterna - costa: SPERANSA, poesìa dla vita.
Cost l'é n'Armanach ëd poeta. Cit o grand, pòver ò sgnor ëd poesìa, a conta nen lo-lì; ma poeta perchè ch'a chërdo d'avèi quaicòsa da canté, quaicòsa da dì, da evoché, da sugerì, da confidé, da amis a amis, da fratel a fratel, da scritor a letor. Per lòn cost Armanach a conten forse tròpe poesìe; ma aj fà gnente: l'é n'Armanach ëd poeta.
Nell'introduzione si cita SPERANSA che è anche il titolo della poesia che Pacòt propone quasi al termine del fascicolo. 21 distici più un verso finale. SPERANSA è anche il titolo della terza raccolta poetica di Pacòt, più che singole, un'unica poesìa suddivisa in diciannove componimenti, tutti senza titolo, dedicati A mè fieul e a soa mama con premessi questi quattro versi:
Rosari d'amor,
bësbià vsin a toa cun-a:
ten-lo an sël cheur,
për ch'at pòrta fortun-a.
Il componimento introduttivo, che porta il numero uno, riproduce in parte la SPERANSA dell'Armanach. Identici i primi dieci distici. Due successivi distici vengono espunti. Poi ancora tre distici identici. Del prossimo solo il primo verso, il resto, 5 distici più due versi, non verrà più utilizzato.
Sempre di Pacòt, un bel ritratto di Nino Autelli seguito dal suo raccaonto La camisa dël nòno, anche questo tratto da Masnà.
Di Luigi Olivero Sahara accompagnata da bel disegno di Ugo Pozzo mentre Giovanni Gianotti pubblica Vita neuva e Alfredino Ël pelegrin,
Nostalgie eutsent: scarabocià su 'n taulin dël Cafè Alfieri è la bella raccolta di impressioni e ricorsi di Pinin. Poi ancora due poesie La nòna di mario Albano e di Armando Mottura Le man dël cit. Poi ancora di Elisa Vanoni-Castagneri Fnestra duverta, di Carlottina Rocco Ël pan dla carità di Aldo Daverio Pianta 'd sità.
Di Luigi Olivero segue una raccolta di ricordi giovanili legati a Ël Valentin an véder ëd Muran dai titoli seguenti: Imbarch, Viai, Erbo, Imbarch,viai erbo. Leggiamo l'ultimo brano:
Ël Valentin a l'ha freid, a frisson-a sota la nebia e a tramola sota la pieuva. Ma l'é ancora viv. Doman a resterà ampëssì sota la prima fiòca e 'l gel a lo farà perësse 'd cristal: cangiandlo tut an un arabesch a ant un fioram, coma una riprodussion an ë-stil floreal liberty, sota la campan-a 'd véder d'un cel niss trasparent. E a në smijrà 'd vëdde 'l Valentin an véder ëd Muran.
Quindi ancora una poesia della valdostana Eugenia Martinet L'erë dzà l'aoura... (L'era già l'ora...) anche questa con traduzione in piemontese di Pacòt. Piccola nota di colore, la copia dell'Armanach della Biblioteca Civica di Torino, scritto a matita, a fianco di quello attribuito da Pacòt si trova: L'era già l'ora... 'd fé lamur (sic)!
Ancora una poesia di Carlo baretti L'armeui. Quindi un intermezzo scenico di Dario Cesulani Sacrifissi e la conclusione con tre canzoni: Ven fé nana su testo di Alfredino e musica del M° Menotii Tomaselli; Noneto, testo di Armando Mottura e musica del M° Edoardo Vercelletti; Bela fija e 'l soldalin Testo di renzo Brero e musica di Alfredo Nicola.
E poi?...
L'avventura qui si interrompe. La guerra s'impone. La poesia piemontese riprenderà a vivere il 14 luglio del 1945, prima con Ël Tòr Arvìsta libera dij Piemontèis che per 32 numeri Luigi Olivero stamperà a Roma per una totale di 256 pagine fino al dicembre del 1948, quindi, il 15 settembre del 1946 con Ij Brandé Giornal ëd poesìa piemontèisa, seconda serie della pubblicazione del 1926, che Pinin Pacòt porterà indefessamente avanti quindicinalmente fino al 1957, con oltre 1.000 pagine di poesia e prosa piemontese.
Piemontèis ancheuj Ann XXXIII N° 3 ~ 9 ( 4 puntate marzo ~settembre)
Per Ij Brandé Antologìa 'd poesìa e pròsa piemontèisa 2015, con l'aiuto della poesia e della prosa di Luigi Armando Olivero (1) e del racconto fattone da Giampaolo Pansa (2) (seguendo i ricordi della figlia di Nino, Paola) in Sconosciuto 1945, ho tentato di porgere al lettore un ritratto, il più veritiero, ma anche il più umano, di Nino Autelli, ël pi fòrt prosator dla nòstra leteratura 'd tuti ij temp, come ebbe a definirlo Nino Costa.
Sempre con l'ausilio dei due citati mentori, riprendo, per approfondirla, la figura di Nino Autelli esplorator d'un mond ëd pura poesìa dova a l'ha savù ausesse për la prima vòlta ant la stòria dla pròsa piemontèisa. (3)
Ne Ij Brandé 2015 è descritto dettagliatamente il vile assassinio di Nino, qui aggiungo un passaggio del ricordo di Olivero dal suo Ël Tòr: (1)
Ël di 'd Soa mòrt - òh la virtù 'd divinassion dij poeta! col di a smiava ch'a sentèissa la man frèida dla mòrt passeje 'd nans a la front! - a l'avìa scrit costi pensè 'n sël feujèt d'un Sò "notes":
«Il mio cuore piange in silenzio per le sorti della nostra terra. Voi no, voi non avete nessun dolore. Vi sento ridere, vi sento cantare per le strade. A voi nulla importa della nostra terra e avete vent'anni, giovani del mio paese».
«Voi non sapete che odiare. Il mio cuore è invece pieno d'amore per la nostra terra, per le nostre case, per voi... Voi non sapete come è bello anche morire per questo amore».
***
Riassumo la breve, troppo breve, vita di Nino Autelli. Nasce a Spinetta Marengo il 17 agosto del 1903, studente della facoltà medico chirurgica a Torino, abbandona gli studi vuoi perché troppo impressionato dalla vista del sangue, vuoi per la chiamata al servizio militare. Al ritorno preferisce dedicarsi, come maestro di scuola elementare, ai bimbi che adora. Nel 1936 parte come volontario per l'Africa Orientale (un posto al sole per l'Italia!!!) rientra nel 1937 e il 23 novembre del 1940 realizza il suo più grande sogno d'amore sposando Maria, come lui maestra. Dopo soli due mesi di matrimonio, nel gennaio del 1941, è richiamato, come soldato semplice di sanità, destinato al treno ospedale N° 3 che trasportava i feriti dell'AMIR rientranti dalla Russia. Il 4 ottobre del 1941 nasce la sua figlioletta Paola, lui a Kolosvar in Transilvania. Malato viene congedato. Nel novembre del 1944 è richiamato sotto le armi e presta servizio in Alessandria fino al 25 aprile del 1945. Lascio la parola ad Olivero dal suo Ël Tòr (1):
A l'avìa la cossiensa tranquila. A savija d'avèj faje 'd bin a tanti e 'd mal a gnun. A l'avìa mai vorsù aceté gnun-e cariche politiche ant la vita civil, ni 'd gradi ant cola militar. Ant ij di dl'ocupassion dël Piemont da part ëd j'esèrcit anglo-american, a l'era tornassne a cà. Che fardel pericolos a peul diventé na cossiensa polida ant un mond ëd cossiense spòrche! ...A l'era tornassne a cà con ël cheur pien dë sconfòrt, con la sola convinsion d'avèj fait tut Sò dover d'italian e 'd piemontèis vers Soa Patria e Soa tèra che, ant la granda luminosa ilusion ch'a l'avìa ancërmalo, a l'era rivà a chërde pi importante 'd Soa Famija, 'd Soa inteligensa, 'd Sò sangh e 'd Soa vita midema.
Il 18 maggio 1945, all'una di notte, un'auto si ferma davanti alla sua casa. Scendono giovani che indossano berretti e foulard rossi. Irrompono in casa. Lo trascinano nel cortile tra le urla strazianti della figlioletta Paola, di soli quattro anni, della sua sposa e della mamma adorata. All'una e un quarto una sventagliata di mitra spegne per sempre la vita e la voce di Nino.
***
Eccomi ora all'opera, troppo breve, purtroppo, stante gli eventi, di Nino Autelli autor ëd coi doi diamant leterare, batesà Pan d' coa (4) e Masnà (5), ch'as romperan mai con ël passé dël temp përché a son doe ciadeuvre faite pi con ëd sangh lìrich cristalisà che nen con d'inciòstr e pi ancastrà 'nt la pera che nen tramandà 'n sël papé.
Pinin Pacòt ha scoperto Nino Autelli, chi meglio di lui per un'escursus sui racconti, sulle favole di Pan 'd coa? Dalla prefazione Nino Autelli e la giovane poesia piemontese, alcuni brani:
Nino Autelli non ha fatto opera di scienza, ha fatto di meglio; si è piegato con fraterna simpatia sul cuore del popolo, ne ha ascoltato la voce, ne ha raccolto gli sparsi frammenti di poesia e questa ha rivissuto in se stesso ed ha espresso come poesia sua.
Queste fiabe, queste leggende, questi proverbi, che egli ci narra e che ricordano, benché inconsapevolmente, per la loro strana affinità di spirito e di arte, le Proso d'Armana di Mistral, richiamano alla nostra coscienza di razza intimidita dalla snobistica superficialità del cosmopolitismo stracittadino, tutto un passato, ormai quasi scomparso, che di questa secolare poesia s'infiorava.
Lunghe veglie invernali ormai così lontane nel tempo, trascorse in una vaga atmosfera di fiaba e di leggenda, chi potrà descriverci senza ricorrere ad una stantia rettorica del sentimento?
Di tutto un mondo fantastico, che allietò , commosse, nutrì l'anima di generazioni susseguentisi immutate nello spirito, non restano più che poche reliquie affidate alla tenace memoria di qualche vecchio.
Questo libro è formato di questi frammenti del passato, che Nino Autelli ha raccolto nelle campagne dell'Alessandrino e del Monferrato, pellegrinando modernamente in bicicletta da paese a paese, in cerca dei pochi vecchi, inconsci custodi delle belle tradizioni, in grado di narrargli le storie d'una volta.
Non è certo possibile valutare, ora al suo apparire, l'importanza di questo libriccino; è però reale la sorpresa gradita e nuova che esso produce e che deve essere, salvando, se si vuole, le proporzioni, della stessa natura di quella prodotta al loro apparire dai Contes del Perrault, dalle Kinder-und Hausmärchen dei Grimm o dalle già citate Proso d'Armana di Mistral. (3)
Nino Costa per due volte, sugli Armanach piemontèis, si occupa di Pan 'd coa. In quello del 1933:
La pròsa piemontèisa, dop i bossèt del tròp dësmentià Giovanin Casalegno, a l'ha mai butà fòra 'n volum ch'a valeissa col ëd Nino Autelli: Pan 'd coa. L'intenssion dl'autor a l'é modesta. Chiel a veul mach raduné, cheuje, e buté 'n vista tradission, storiëtte, manere 'd dì, e proverbi dla gent paisana ant la provincia d'Alessandria. Ma le ròbe a valo tant per lòn ch'a son, come per la manera ch'a son dite. E Nino Autelli l'ha tut un fé sò per conté na stòria ò riporté un proverbi. A fòrssa 'd fatighe e dë studi a l'é rivà a deje a sò discorss na tornura popolar, ciaira e fresca come l'acqua - e per chiel as podrìa ripet-se lòn che a sò temp l'han dije a Daudet: Quelle jolie façon as-tu de dire les choses! Senssa conté che 'l lìber d'Autelli, foravìa dla forma, l'ha un valor particolar per le ròbe ch'a presenta e ch'a son tanti citi bijoux sernù con gust d'artista e con passion ëd folklorista piemontèis. Chi a l'ha lesù sto prim volum ëd Pan 'd coa a na speta n'aotr con desideri e con simpatia.
Nell'Armanach per il 1935 Nino Costa ribadisce:
Nino Autelli dòp Gioanin Casalegno, a l'é un d'i pòchi (ma pòchi dabon) ch'a veujo, ch'a peusso, e ch'a sapio scrive 'd bona pròsa piemontèisa. Sò dialèt a mëscia ansema, con n'armonia sclina e polida, la freschëssa dle sorgiss paisane e la sernia medità dlë studi e dla riflession. S'i l'aveisso 'd cò noi ël permess ëd fé certi paragon, i podrìo dì che i sò racont e i sò bosset a ricòrdo, gnanca tròp da lontan, le pròse toscane dël tersent.
Fin adess Autelli a l'ha mach publicà 'n volum: Pan 'd coa, ch'a l'é 'ncora nen apressià e conossù com'as mérita; però a l'han dine ch'a l'ha nt'sò tirol, bel e pront, n'autr volum ëd pròse ch'a saran na galuparia.
Noi i soma sicur che Autelli, ò prest ò tard, a farà soa strà, e quand ch'a sarà rivà a la mira dla popolarità, noi i saroma fier d'esse stait fra i primi ch'a l'han sentù e proclamà sò valor.
A pag. 1 queste parole di Luigi Olivero:
Le bele faule dle virtù paisan-e e 'l "pan ëd coa" d'una candeur ëd lait a l'ero al mond toe sole gòj uman-e. (Dalla sua poesia A Nino Autelli rilesend «Masnà» N. d. A.)
L'edizione è preceduta da una introduzione di Andrea Viglongo dalla quale riporto alcuni brani:
Nino Autelli è nato a Spinetta Marengo ed è morto stroncato a tradimento da sconosciuti che hanno disonorato il nome di partigiani. Di lui e della sua tragica fine ha scritto magistralmente Luigi Olivero (Almanacco Piemontese 1985) nel quarantesimo anniversario della morte.
(Mi permetto di segnalare che quanto pubblicato sull'Almanacco citato, non è che la Versione dal piemontese, contrassegnata da qualche variante, soppressione o aggiunta, da Ël Tòr, arvista lìbera dij piemontèpis, A. IV, Nn 31-32. Roma, 15 dicembre 1948, come viene correttamente indicato in calce al pezzo. Questo omaggio di Olivero a Nino Autelli era quindi stato composto ben 37 anni prima poco più di tre anni dalla morte di Nino. N. d. A.)
La mia appassionata attività di editore studioso di cultura piemontese non poteva iniziare meglio che col felice incontro anche con Nino Autelli, e Pan d' coa resterà sempre tra le mie pubblicazioni più vissute e più care.
***
I bruti che stroncarono la giovane esistenza di Nino Autelli non sapranno mai di avere insieme stroncato colle loro mani una grande possibilità d'avvenire degli studi piemontesi.
Autelli era appena all'inizio del suo impegno culturale. Lo dimostra il fatto che, al momento della pubblicazione di Pan d' coa egli suggeriva di presentare il libro «come un primo risultato di ricerche folcloristiche dell'autore».
***
Mentre nel 1931 Pan 'd coa si avvalse della prefazione di Pinin Pacòt, nel 1937 Masnà è dato alle stampe preceduto solamente da questa dedica:
AI MÈ
con la gòi nossenta dle masnà
con le bin madura dl'òm
Nell'Armanach piemontèis per il 1937 appare la recensione di Masnà da parte di Luigi Olivero:
…Per un ghiribis dla natura, lë scritor Nino Autelli – l’ùnich autentich scritor piemonteis d’ancheuj – a ‘s presenta al mond con un cheur a double face. Da na part a l’é un cheur còti e vlutà coma ‘l pontaguce d’una fiëtta da marié: e cola a l’é la part ëd l’artista sensibilissim ëd MASNÀ. Da l’autra part a l’é un cheur dru e sislà ‘d corage coma na medaja al valor militar. A l’é che Nino Autelli a l’ha vorsù esse volontare an A. O. e an cost moment a ‘s treuva ancora an tèra d’Africa a protege i sorch signà dal destin imperial dla nòstra rassa paisan-a e gueriera.
Da la fusion ed coste doe facie dël cheur ëd Nino Autelli - dòp la preuva dla guera - a pudrìa desse ch'ai surtieissa ël cheur dël poeta 1937: ël cheur metalich e armonios ch'a sà bate con ël son ëd la spa e sospiré su na nòta 'd fisarmònica paisan-a.
Ed ecco come Pinin Pacòt ci descriveva nell'Armanach per il 1938 Masnà:
...Nino Autelli, tornà al paìs dòp soa bela aventura african-a, volontari an camisa neira, ch'a l'é rivà fin-a ai pé brusà dle montagne dël Semien da le ponte quatà 'd fiòca; tornà al paìs con l'ànima pien-a 'd sol, ëd calor, ëd figure, a l'ha savù chinesse su sò cheur, ant un gest ëd ripòs, dòp tanta stra e tanta fatiga, e fasend arvive coma ant un seugn soa prima vita masnà e campagnin-a, a l'ha trasfigurala an poesìa, con la dlicatëssa 'd soa arte frësca e squisìa. E cost a l'é 'l miraco 'd MASNÀ. Oh! Un cit miraco, d'acòrdi, coma tute le vòlte che un poeta, anche scrivend an pròsa, a riva, ant la forma armoniosa 'd soa paròla, a deje vita a un seugn, per la consolassionn soa e di sò letor. E ant cost sens, per noi MASNÀ a l'é un miraco.
La magìa dël poeta a l'ha savù evoché le ombre lontan-e e spërdue dij ricòrd, e a l'ha fàit, ëd cite impression ëd legere sensassion, ëd fërvaje 'd sentiment, n'ansema 'd creature vive ant un paisagi real, dova che l'aria a sofia, ël sol a scàuda, la vita a madura, e a l'é tornà, chiel, la masnà, vera sempia cita d'una vòlta, e a l'é guardasse a vive, chiel, òm con sò fardel d'esperiensee 'd fatighe, e a l'ha contà: l'ha contà, parèj, a la bon-a. ant soa pròsa da l'aparensa ùmila e pian-a, ma cadensà da n'armonìa segreta, da un contrapont an filigran-a, ch'a trasformo soa pròsa an poesìa. Certe vòlte ij sò racont a l'han n'andura da poemèt an pròsa, e dabon che soe creature, soe figure, le còse, le ore e ij color dij sò racont, sovens a son pì lìrich che narativ, quasi ch'a fusso 'd tòch ëd poesìa, gropà man man da 'd passagi d'un'elegansa musical...
Armanach piemonteis del 1941. Anonime, ma con tutta probabilità dell'editore dell'almanacco Andrea Viglongo, queste parole dedicate al Masnà di Nino Autelli:
L'aotor 'd Pan 'd coa a l'ha torna dane ant cost sò neuv liber la preuva che la pròsa piemonteisa a peul esse viva, corposa, colorita, faita ëd nerv e 'd muscoi tant come la poesia. Ma dabon, an lesend le soe stòrie, memòrie, legende, proverbi, e tradission paisane, viste con la meravija e l'intuission dle masnà e contà con la grassia e l'amor d'una noneta setà s'un cadregon a randa dla stùa: un a sa pì nen andoa ch'ai finissa la pròsa e ch'ai prinssipia la poesia. E i tornoma 'd cò noi masnà, setà s'jë scagnett, con j'euj spalancà e la man an faoda:
La stòria l'é bela - fa piasì contela...
***
Nel 1985, edito dalla Ca dë studi "Pinin Pacòt" esce la seconda edizione di Masnà, preceduta da una lettera della figlia di Nino, Paola e dalla presentazione di Camillo Brero tratta da Ij Brandé del 1978 e da un pezzo di Pacòt dall' Armanach piemontèis del 1938. Nella presentazione di Brero è una lettera di Nino datata Cracovia, 27 aprile 1942:
Tra i bambini che vengono al treno (Prego, signore, pane) c'è una bambina che non ha ancora due anni. Si chiama Janka. Abita in una baracca di legno vicina al treno ed è l'ultima di tanti bambini tutti cenciosi e scalzi. Anch'essa è vestita di cenci ma ha una testina bionda e un bel visetto tondo. Ogni giorno la vedo uscire dalla sua casa e si avvicina al treno a piccoli passi ancora incerti, recando in mano un pentolino. Janka non dice nulla, ma appena mi vede mi sorride. Ha imparato subito a riconoscermi tra gli altri soldati. Io mi privo volentieri di qualcosa per farla contenta. Io voglio bene a Janka. Ho dato a questa bambina povera e innocente un po' del mio immenso e traboccante amore per Paola...
Con lo stesso editore, nel 1994 esce la seconda ristampa introdotta da Camillo Brero e da Paola Autelli. Questa edizione presenta anche una dotta dissertazione del Prof. Sergio Maria Gilardino, già docente di letterature comparate presso la McGill University di Montreal, dal titolo Ars nova, ars rara - I poemetti in prosa di Nino Autelli. Del lunghissimo studio del Prof. Gilardino (facilmente rintracciabile in molte biblioteche), riporto alcuni brani:
La lingua della memoria è di gran lunga il primo e il più importante dei moventi dell'arte di Autelli. Si tratta cioè di un autore che custodiva un'universalità linguistica ed epica che minacciava di svaporare se egli, in un qualche modo, non la fissava per sempre sulla pagina. Ha colto nel segno Nino Costa quando, più poeticamente che criticamente, ha definito l'atto creativo di Autelli come un ritrovare il proprio cuore di bimbo:
Mi an fan l'efet che chiel, un bel di, drinta un tirol ëd la chërdensa 'nt
la stansia bela, a l'abia trovà sò cheur da masnà, ross e càud, e che sò
cheur ëd na vòlta a l'abia contaje a sò cheur d'adess le bele stòrie ch'i l'hai lesù 'nt ël lìber.
***
La maestria di Autelli in materia linguistica non è però soltanto di natura sintattica, ma anche assonantica. Siamo ben lungi dall'allitterazione "a bugne", vistosa e altisonante, che troviamo sia nella letteratura nordica che in quella italiana (vedasi, uno per tutti, il suon della tartarea tromba del Tasso). Siamo invece nel regno delle vibrazioni simpatetiche lievi lievi, appena percepibili, eppure indispensabili per sorreggere un tessuto linguistico così finemente assonanzato. Si notino, ad esempio, nel brano seguente, il succedersi delle labiali e delle sibilanti, quasi "a cappella", nella loro tempestiva concatenazione:
Le fomne l'han ciapà 'n pressa la sapa e son butasse a sapé sota 'l fi con n'anvìa straordinaria, fintant che a fòrsa 'd sapé, l'han dëssotrà l'ola 'd Giaco ...
***
In effetti entrambi i libri, Pan 'd coa, che è del 1931 e Masnà , che è del 1937, poggiano su un substrato di oralità. Si può anzi dire che il passaggio dal primo al secondo (che, fuor d'ogni dubbio, è stato il suo capolavoro), si è fatto attraverso un affinamento dei modi con cui questa oralità era recepita e utilizzata: voce dei padri tout court nel primo volume, e quindi letteratura in terza persona, voce intima e individualissima, e quindi in prima persona, nel secondo.
Programmaticamente il suo primo libro vuole essere una raccolta di racconti e di leggende della sua gente, e così, ad litteram, è stilato il sottotitolo dell'edizione originale: leggende e racconti popolari piemontesi. Poiché si ratta di favole che i vecchi solevano recitare in prosa, la scelta del genere letterario s'imponeva da sé. In un certo qual senso, se il movente iniziale di Autelli era quello di riportare queste leggende (che ha raccolto con tenacia e certosinità di gran filologo, rastrellando in bicicletta le colline del vicinato...) ben presto gli si presenta il problema di un linguaggio letterario che possa accogliere le varianti diacroniche e tematiche riscontrabili nelle versioni raccolte dai vari narratori. È qui che si inserisce l'intervento dell'Autelli letterato de visu all'Autelli filologo. Ben aveva colto nel segno Pacòt quando nello scritto Nino Autelli e la giovane poesia piemontese asseriva:
Nino Autelli non ha fatto opera di scienza, ha fatto di meglio; si è piegato con fraterna simpatia sul cuore del popolo, ne ha ascoltato la voce, ne ha raccolto gli sparsi frammenti di poesia e questa ha rivissuto in se stesso ed ha espresso come poesia sua.
***
Da Sconosciuto 1945 (2) di Giampaolo Pansa, ecco qualche ricordo della figlia di Nino, Paola:
Lei (Paola risponde ad una domanda di Pansa) mi chiede come sarebbe stata diversa la mia vita, se non mi avessero ucciso il papà. Forse avrei avuto dei fratelli, che ho desiderato sempre. E non avrei visto la mamma perennemente triste. Da quel giorno non l’ho più sentita ridere. Sempre vestita di nero o di grigio, non ha mai avuto dei colori addosso. Ha continuato a fare la maestra, nessuno l’ha epurata o perseguitata. Le avevano ammazzato il marito, e forse questo bastava... Papà mi è mancato sempre, ogni giorno. Non mi sono mai vergognata di lui. E non ho mai avvertito ostilità nella gente. Le persone di Spinetta mi stimano. Anche di papà dicono che era una brava persona. Io non mi sono mai mossa da questa casa, ci vivo da quando sono nata. Lei vuol sapere quando mi sono resa conto che l’assassinio di mio padre stava dentro un dramma politico collettivo. Le rispondo che me ne sono resa conto sempre, non appena sono stata in grado di capire quel che era avvenuto. Sentivo mia madre dare giudizi durissimi su chi aveva ucciso papà. E ho conosciuto presto altre storie simili alla nostra.
Giampaolo Pansa conclude così il capitolo La fiaba di Nino:
Nel sessantesimo anniversario (dell'assassinio di Autelli, il libro di Pansa esce nel 2005) la figlia ricorda quel padre grande e buono che Dio le ha dato e gli uomini le hanno tolto.
Luigi Olivero, nell'ultimo numero della sua rivista Ël Tòr (1), pubblicato per il Natale del 1947, oltre al lungo e commosso articolo (Omage a Nino Autelli - A trè ani e mes da l'assassinat dël pi fòrt prosator dla leteratura piemontèisa) a ricordo della vita, della morte, dell'opera di Nino Autelli, gli dedica anche le poesie A Nino Autelli rilesend «Masnà» e Tòrce a vent entrambe riprodotte qui di seguito. Olivero dedica a Nino anche la Mëssa paisan-a - Cantà da la mare d'un povr soldà mòrt an guèra pubblicata integralmente su Ij Brandè Antologìa 'd poesìa e pròsa piemontèisa 2015.
A NINO AUTELLI
rilesend "Masnà"
Voici le temps des ASSASSINS
RIMBAUD
Con le doe man unije a leturil
reso tò lìber, Nino, dle «Masnà»
parèj d'un missalin anluminà.
E an tuti ij nerv l'hai un frisson sutil.
A l'alba dla toa vita 't l'has cantà
j'ànime sempie come smens d'avril
ch'a viro ant l'aria, e, con un vòl gentil,
calo an tèra a visché 'd fior profumà.
Le bele fàule dle virtù paisan-e
e 'l «pan ëd coa» d'una candeur ëd lait
a l'ero al mond toe sole gòj uman-e.
Dë vlu 'd reusa tò cheur a l'era fait.
E a l'han strompatlo, 'd neuit, ëd man nostran-e
con na bala 'd fusil tirà a l'avait.
Sla seuja dla toa cà j'era l'invit
dla canson dla toa sposa ch'a spartìa
sla tàula 'l pan ëd la toa poesìa...
E 't ses mòrt sensa un crij parèj d'un cit.
N'ombra a lassava 'nt l'ombra sò delit
ëd fassion da la guèra anvelenìa.
Na stèila visca an cel. L'ombra a sparìa...
E 't ses mòrt sensa un crij parèj d'un cit.
Le feuje rosse d'un garòfo scrit
j'ero le màcie 'd sangh dla toa ferìa...
E 't ses mòrt sensa un crij parèj d'un cit.
Con ij brass largh, con lë sguard fiss e drit
t'has vist në slussi su n'areà fiorìa...
E 't ses mòrt sensa un crij parèj d'un cit.
T'avie chërdù 'nt la Patria e 'nt la bontà
dla toa gent ëd campagna, ànima pura.
Da j'ambe giàune a j'isbe 'd tèra scura
ël sign ross dla toa cros t'avìe portà.
An front al lìber, con la toa scritura
còtia come j'ariss ëd le masnà,
t'avìe scritme l'ofèrta: «A ti, ancërmà
'd n'anciarm midem ëd seugn e d'aventura».
Për nòst seugn d'aventura it ses cascà...
E mi leso tò lìber inossent
travèrs un vel ëd làcrime d'argent.
Tant che, 'nt la neuit, doe man ansangonà
- Nino, 'd tò sangh! - am calo 'd nans a j'euj
e as saro al còl d'na Mare sensa fieuj.
Roma, 2 agost 1947 (6)
TÒRCE A VENT
Yo tengo el fuego en mis manos.
Federico García Lorca
Fiame, rosse caviere
che spatare ant ël vent
le farfale d’argent
ëd le spluve legere.
Fiame, rosse bandiere.
L’hai sërcà ’d carësseve
pen-a vistve, da cit:
che ’m cissave un invit,
n’anvìa fòla ’d baseve.
Spricc ëd sangh ch’iv soleve.
Mese lun-e ’d faussije
anfiorà, come ’d làver,
de spi ’d gran e ’d papàver
sota un vòle d’avije.
Lenghe ’d fàun cioch ëd rije.
Crëste vive ’d galòro
come giòie ’d sufrin;
doje përgne dël vin
dle vos càude dij còro.
Feuje ’d vis ch’a s’andòro.
Foèt giàun ch’a s-ciuplisso
dësneudà come ’d serp:
tra la fum ëd jë sterp
euj ëd brasa ch’at fisso.
Cove ’d tigri ch’as drisso.
Cheur avisch d’alegrìa
ant la neuit frissonant
con rifless ëd diamant
cangià ’n feu për magìa.
Cornà ’d tòr ëd Sevija.
Fianch foà ’d bailadora
ch’a së stòrzo ’d piasì
sbrincià ’d sangh benedì
dël Crist nu con j’òss fòra.
S-cirpe ’d mùsica mòra.
Bussonà ’d reuse mate
dij tramont ëd cel vèrt
che l’hai vist sij desert
con ël ghibli a combate.
Simitare scarlate.
Reu ’d colòne torzùe
’d mausolei egissian
s’j’orisont ëd safran
tajà ’d palme spërdùe.
Trombe ’d sabia e dë splùe.
Ale ’d màchine ’d guèra
tra garlande ’d color,
canson drùe ’d motor
ch’a rimbombo an sla tera.
Tèra ’d sënner amèra.
Scaje ’d pèss tra le fèrle
dij boschèt ëd coral
sota ij mar stërnì ’d sal
e ’d cuchìe orlà ’d perle.
Euj d’olive ant le gèrle.
Fiame! Stèile marin-e
fëstonà ’d zora ij sen
d’Aventura ch’a ven
coroneme dë spin-e.
Òh, ij mè seugn, mie ruvin-e!
Ma sël nèir paisagi
dla mia vita ’d torment
àosso un pugn prepotent
con na tòrcia ’d coragi.
E un sorch, ross, l’é mè viagi ...
*
Tòrce a vent, crij ëd fiama
ant la neuit sensa fin:
compagné mè destin
vers la lus doa lo ciama
ël silensi ’d mia Mama.
Roma, 7 dzèmber 1947. ~ ËL TÒR, n. 30/31 15 / 12 / 1947
In conclusione, di Autelli un racconto breve, Saba Sant dall'Armanach piemontèis del 1934 e, tratto da Masnà, il racconto Natal an sël brich.
SABA SANT
Pena a së spantiava l'aria dossa d'avril ël prim bòt dle ciòche ch'a sonavo baudëtta,
( e 'l sol, a l'improvisa, a surtìa fòra dle nivole)
via che ti t'corìe ant l'òrt a 'mbrassé, una per una, le piante bele fiorìe 'd perssi, 'd pom, e 'd cerese;
e peui, su, con l'ànima an festa, a lavete la facia rijenta ant l'eva bela ciaira che Mama at tirava dal poss.
E chila - it ricòrde? - at disìa parèj ëd nen suvete j'euj.
Così ch'at restava an sima le parpëile, e it la sentìe 'd cò ant ël cheur, na rosà tuta frësca coma cola ch'a lusìa an sl'erba novela.
NATAL AN SËL BRICH
Vigilia dla Festa. Ant ël fornel a j'è un such ch'a branda e nòno, setà lì davsin, a fa soa pipà. Minca na golà a smija ch'aj daga un basin a la pipa. Mama, tacà l'erca, a pronta 'l seuj per le lasagne. Mi vardo sò travaj. L'ha già ras-cià da bin soa taula polida e la ras-ciura l'é andaita a campela ant la bronsa dle galin-e. Adess a cheuj dal sach don-trè pugnà 'd farin-a e a fa, ansima a la taula, na bela preus. Ant ël mes dla preus a jë s-ciapa n'euv. 'L ross, così fresch, così lusent, posà an mes al bianch dla farin-a, a smija ch'a rija. L'é coma la testa 'd na fior, gròssa, 'd margrita e la farin-a d'antorna son le feuje.
Ma, òmmì!, la bela fior a j'é pi nen. Mama l'é sùbit butasse a baciassé e la potìa, tuta mòla e tacanta, a pòch a pòch as liga, a ven pi dura, a l'é un malòch ëd pasta. Chila anlora a lo sgnaca, a lo dobia, a lo ardobia, (che andi ch'aj da la mama! E a fa fòrsa un pòch con na man e un pòch con l'autra, che fin-a l'erca, ògni bòt, a scrussiss) a lo mugia adess, a lo sgiafela e 'l paston tëbbi, còti, odoros, varda, l'é bele e pront.
A l'é da un pess che mi lo spetava.
- Mama të m'na dass un tòch?
E lì, an sël canton dla taula, im fass mia bela fogassëta.
Ij buto adess na cita pëssià 'd sal e dòp ij la pòrto a nòno ch'a la buta a cheuse ansima a la sënner cauda, randa a la brasa.
***
I vardo fòra dla fnestra.
A fiòca largh na man e 'l brich l'é tut quatà. Con tute cole valòsche ch'a balo e ch'a girolo ant l'aria coma farfale, a smija 'd cò 'd vëdde balé tut an gir i camp, i pra e le taragne.
An mes a tut col bianch j'é mach ël ri, lì a bass, ch'a l'é coma na macia neira e a smija un viandant che, andand sota la fiòca, mincatant a sopata soa pelegrin-a.
***
Ah! E mia fogassëta l'é-la cheuita?
L'é dël color ëd l'òr, con don-trè gòle pi scure e na cita chërpa squasi bianca.
I la gavo da la sënner e im la fasso sauté da na man a l'autra, për sfreidela. Na tasto un cantonin. Coma l'é bon-a! E l'é tuta odorosa coma 'l pan, quand che mama a lo gava dal forn.
Adess mama l'ha finì sò feuj e a taja le lasagne.
As sento a soné le ciòche dal paìs. E a l'han un son, le ciòche, così smortà, ch'a smija ch'a ven-a da lontan da lontan.
Nòno as signa.
Ant l'aria a j'é quaicòsa che mi capisso nen bin, ma ch'a l'é dossa coma n'orassion.
Longh a la stra, su per la rampa dël brich, a j'é n'òm con sò baston e un fagotin ch'a va su adasi adasi...
NOTE
La grafia dei brani in piemontese riprodotti, è quella licenziata dagli autori. Rispecchia il momento di transizione tra la grafia cosiddetta tradizionale, quella de 'l caval 'd brôns e quella proposta da Ij Brandé che poi si affermerà. Per rispetto ai vari autori ho preferito non apportare variazioni di sorta. (N. d. A.)
(1) Ël Tòr Arvista libera dij Piemontèis N° 31/32 15/12/1948~1/1/1949 - Roma.
(2) Giampaolo Pansa. Sconosciuto 1945 Sperling & Kupfer Editori S.p.A., 2005 Milano.
(3) Pinin Pacòt. Dall' introduzione (Nino Autelli e la giovane poesia piemontese) a Pan 'd coa Leggende e racconti popolari piemontesi Edizioni S. E. L. P. Studio Editoriale Librario Piemontese 1931- Torino.
(4) Nino Autelli. Pan d' coa Leggende e racconti popolari piemontesi Edizioni S. E. L. P. Studio Editoriale Librario Piemontese 1931. Torino. Introduzione di Giuseppe Pacotto - Xilografie originali di Pino Stampini. Pag. 152.
(5) Nino Autelli. Masnà Turin. A l'ansëgna di Brandé 1937 - Con la tradussion italian-a dl'Autor e con i disegn ëd Felice Vellan - Pag. 141.
(6) Olivero scrive in nota (1): La fin ëd Nino Autelli, coma l'oma documentala an sle testimonianse dij Sò familiar e dla gente ëd Sò paìs, a l'è staita bin pi tràgica 'd come l'oma descrivula ant ij tre sonèt che publicoma, an Soa memòria, ant la pagina 10 (Ël Tòr N° 31/32 15/12/1947 ~ 1/1/1948) e che l'oma scrit quand che conossìjo ancora nen tuta la vrità an tuti ij sò afros particolar.
Ij Brandé Antologìa 'd poesìa e pròsa piemontèisa 2015
Come scrittore ce lo presenta Pinin Pacòt in una lettera indirizzata a Luigi Olivero il 29 luglio del 1930: I l’hai trovà n’apassionà d’ nòst folclòr, ch’a l’ha cujì e ch’a l’ha contà ant na manera delissiosa le stòrie, le faule, le legende d’soa region alessandrina, ant un bel piemonteis pien ëd saiva e pien ëd calor. Questi racconti, favole e leggende saranno il corpo di Pan ëd coa pubblicato nel 1931 dalle Edizioni S.E.L.P. (Studio Editoriale Librario Piemontese di Andrea Viglongo). Appena il tempo di pubblicare il suo Masnà nel 1937 che parte volontario per l’Africa e la campagna d’Etiopia.
Olivero aveva dedicato a Nino Autelli un articolo sull’Armanach piemontèis del 1937 dove tra l’altro scrive:
…Per un ghiribiss dla natura, lë scritor Nino Autelli – l’ùnich autentich scritor piemonteis d’ancheuj – a ‘s presenta al mond con un cheur a double face. Da na part a l’é un cheur còti e vlutà coma ‘l pontaguce d’una fiëtta da marié: e cola a l’é la part ëd l’artista sensibilissim ëd MASNÀ. Da l’autra part a l’é un cheur dru e sislà ‘d corage coma na medaja al valor militar. A l’é che Nino Autelli a l’ha vorsù esse volontare an A. O. e an cost moment a ‘s treuva ancora an tèra d’Africa a protege i sorch signà dal destin imperial dla nòstra rassa paisan-a e gueriera. …
Dicembre 1948, dopo una lunga sosta durata due anni, Olivero pubblica l’ultimo numero doppio, 31/32, della sua rivista Ël Tòr. Un suo accorato articolo è dedicato alla memoria di Nino Autelli, barbaramente ucciso a Spinetta Marengo il 18 maggio 1945 avanti la figlioletta Paola di quattro anni, la moglie Maria e l’adorata Mamma. Giovani con foulard e berretti rossi gli sparano una raffica di mitra alle ore 1.15. Muore, confortato dai famigliari, da un sacerdote e da un medico, alle 4.15. Assassinio mai punito, in nome di una giustizia sommaria e di un popolo lacerato da una guerra perduta. Olivero ci dà il primo, e a quella data, unico, vivido ricordo dell’autore di Pan d’coa e di Masnà. Ecco alcuni brani del commosso ricordo di Olivero per il suo amico Nino Autelli:
L’ultimo suo anélito fu un pensiero soffuso della luce purissima del perdóno per i giovani sconosciuti che ostentavano berretti e foulards rossi e i quali, alle ore 1 di quella stessa notte, eran balzati giù da un’automobile che s’era improvvisamente arrestata di fronte a casa sua, avevano fatto irruzione, con i mitra spianati, nella sua stanza da letto, e, insensibili alle grida d’angoscia e di terrore della sua creaturina e delle sue donne, gli avevano intimato di uscire nella contrada, nera di silenzio, dove, proprio sulla soglia della sua abitazione, gli avevano sparato addosso una sventagliata di proiettili, lasciandolo disteso in un lago di sangue (ore 1.15). In un quarto d’ora avevano strozzato per sempre la più alta voce della prosa fiabesca in piemontese di tutti i tempi.
…Povero Nino! Hanno voluto ravvisare in lui nient’altro che un uomo d’un colore politico cancellato dalla spugna infocata degli avvenimenti bellici. Hanno voluto scorgere, sotto la sua bella fronte, un’idea politica ormai bruciata dalle fòlgori della tempesta: un’idea nella quale egli aveva creduto fino all’ultimo istante, con tutta la sincera onestà della sua anima limpida, perché in quell’idea – giusta o sbagliata che fosse – per lui s’identificavano la legalità, l’onore, la difesa della Patria. …la malvagità umana è grande, ma la vigliaccheria è immensa. Nino Autelli ebbe tanti amici, da vivo, che lodarono le sue virtù etiche ed artistiche. Post mortem, su di lui, sulla sua opera letteraria, non si è più udita né letta una parola.
Quanta tristezza! Se certa malintesa politica può pervenire a tanta accanita violenza demolitrice da eliminare persino il sentimento spontaneo e congenito del ricordo d’un compagno estinto, da parte degli amici della propria giovinezza, quanto ribrezzo, anche nelle marmoree statue cimiteriali, può suscitare talvolta la politica! Tuttavia noi sentiamo di poter superare, in tutta calma spirituale, anche la paura della politica degenere e degli uomini che se ne fanno strumento di offesa per legittimare i loro crimini. E offriamo serenamente questo omaggio a Nino Autelli: l’unico che gli sia stato pubblicamente tributato dalla data della sua morte (18 maggio 1945) ad oggi (15 novembre 1948), alla sua santa memoria, alla sua anima pura, coraggiosa e delicata, che sentiamo sorella della nostra e viva: più viva che mai, in noi, situati ancora al di qua del regno delle ombre livide della Morte nel cui grembo il suo corpo ha trovato finalmente la pace. La pace eterna dopo un’esistenza inquieta, come la nostra, figlia onesta dell’avventura e dell’azzardo, genitori di virilità e di energetica poesia. …
Nino Autelli fu un eroe disarmato (stavo per scrivere armato del gambo di un giglio):
Fu un còndor con occhi e cuore di colomba.
Come Federico Garcìa Lorca. (1)
Come Robert Brasillach. (2)
Così fu Nino Autelli.
E tale amo supporre che rimanga per la posterità, quest’ormai leggendario mio inobliabile amico.
All’articolo segue, dedicata a Nino Autelli rilesend “Masnà” e, con premesso il verso di Rimbaud
Il prologo è una lunga e commossa poesia dedicata a Nino Autelli che inizia:
reso tò liber, Nino, dle «Masnà»
parèj d’un missalin anluminà.
E an tuti ij nerv l’hai un frisson sutil.
…………………
E ‘t ses mòrt sensa un crij parèj d’un cit.
Quindi, prima dell’Introitus, l’immaginazione della scena in cui si svolge l’azione:
Mëssa paisan-a Cantà da la mare d'un pòvr soldà mòrt an guèra
In un clima di apparizione surreale, un bianco sacerdote officia la Messa dei Defunti sull'altare di pietra di un Ossario dei Caduti eretto sulla cima di una montagna solitaria. Una vecchia contadina in gramaglie è inginocchiata sopra una roccia scura protesa verso la croce dell'Ossario a pochi metri dall'apparizione. La vecchia canta con voce trémula gli inni della Messa - da lei immaginata - sulle note di una musica rudimentalmente liturgica: quale può essere concepita dalla rozza fantasia della povera devota che invoca dal Signore riposo eterno per i resti mortali del proprio figlio racchiusi in quell'Ossario.
Introitus
Anvlupé 'nt ël sudare dla Vòstra lus cilesta
j'òss ëd mè fieul, Nosgnor.
Deje Voi la pas etèrma
ch'a peul nen deje mè dolor.
Réquiem aetérnam dona eis Dómine
et lux perpetua lúceat eis.
Psalmus
A Voi che vije 'd zora tute uman-e passion
na mare a ven ciameve la grassia dël përdon
su costa ròca scura pregandve an ginojon.
Dòp esse restà sola, dòp avèj tant piorà
'd zora le sënner frèide dël feu 'd mia pòvra cà,
son vnùa a 'sta montagna ansangonand mia strà.
Da sota cola pera ch'a coata tanti fieuj
fé ch'as visca la reusa che, 'nt ël mè cheur, arbeuj
dle gosse 'd sangh ch'a peulo pi nen spërme ij mè euj.
E fé che peussa s-ciaire, 'nt la lus ëd cola fior,
na front che da na banda l'ha 'n përtus bleu, Nosgnor!,
dont veuj enté la reusa bujenta 'd mè dolor.
...exáudi orationem meam
ad te omnis cura véniet. Réquiem.
Kyrie
Nosgnor, avèj pietà
'd na mare an-magonà.
Ò Crist, avéj pietà
'd na mare sconsolà.
Nosgnor, avéj pietà
'nt Vòstra granda bontà
'd na mare disperà.
Kyrie
Nosgnor, chiné Vòst cheur
aranda mè pòr cheur
ch'ai vèrsa sò maleur.
Le doe man ëd doe seur
- Vita e Mòrt - A Vòst cheur
a spòrzo mè pòr cheur.
Ò cheur ëd tuti ij cheur.
Kyrie
Mare dël Fieul Divin,
preghé për mè fiolin,
preghé Gesù Bambin.
Për Vòst bianch autarin
tajrai ògni matin
ij liri 'd mè giardin:
e ij vischrai un lumin.
Kyrie
Vòst Fieul che tut a peul
don-a la pas al fieul
d'na pòvra mare an deul.
Mi ij donnrai un linseul
ricamà con un reul
ëd tute fior ch'a veul.
Mi ij donnrai a Vòst Fieul.
Kyrie
Dëstendrai col linseul
tut brodà sul pogieul
ël di 'd Pasqua, s'a veul.
Ma Chiel ch'a salva 'l fieul
d'na pòvra mare an deul.
Nosgnor che tut a peul,
ch'a peul tut lòn ch'a veul.
Kyrie
Ò Crist, biond Redentor,
erbo uman ëd Nosgnor.
Maria, sàiva 'd Nosgnor.
Àngei, branch ëd Nosgnor.
Radis vive d'amor
Sant e Sante 'd Nosgnor.
Pietà 'd na mare an pior.
Pietà dël sò dolor.
Kyrie
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.
Dómine exáudi orationem meam.
Et clámor meus ad te véniat.
Dies iræ
Quand che su da costa tèra
coatà 'd ròch, d'erbassa amèra,
s'ausseran ij mòrt dla guèra;
quand che tute le Toe trombe
dësvijran j'òss da le tombe
sle montagne, pian-e, combe;
quand che 'l tron ciamrà a giudisse
nòstre colpe e nòstri visse
giù 'nt ël creus d'un precipisse;
'd zora cola val in-mensa
it lesras la Toa sentensa,
ò Nosgnor d'ògni cossiensa.
Ti 't vëdras, Nosgnor, antlora,
un paisan biond ch'a lavora
'n camp che al sol a sfiama ancora.
Sò bel camp che l'hai guernaje
për ël gran ëd le batiaje
dl'angelèt che 't l'has nen daje.
Mè pòr fieul (sòrt dolorosa!)
'd nans ëd sèrne la soa sposa
l'é mòrt su 'sta ròca frosa.
Sovagnà l'ha soa campagna
da paisan ch'a guma e a sagna
e soa mica as la guadagna.
Al travaj mia creatura
l'ha fàit seulia ògni giuntura
dij sò òss e la pel dura.
Da masnà pasturand fèje,
da grandin a spòrze e a mèje:
mai stornà da 'd brute idèje.
Om, sò pugn scurpì 'n sla slòira
mai slanghisse 'd na mariòira
tra ij dilin d'bòja pëssiòira.
Drit - parèj dij sorch ch'arava
'ndoa la smens peuj vantolava -
l'ha marcià da masnà brava.
Sempre! E un dì l'han piamlo an guèra.
A më smija ancor nen vèra
ch'a sia mòrt su costa tèra.
Ò Nosgnor, quand che t'ën ciame
ant la val circondà 'd fiame,
salva 'l fieul che 't l'has doname.
Da lë strop dle fèje mate
sèrn la fèja ch'a l'ha date
sò lait bianch, soe lan-e fate.
E col'ombra, ch'a lavora
daré ij beu parèj d'antlora,
ciamla a Ti 'nt col'ùltim'ora.
Sla soa front l'ànima mia
fà, col dì, Nosgnor, ch'a sia
na farfala benedìa.
N'òstia bianca, n'òstia cita,
për guidé la Toa man drita
vèrs la fior ëd la mia vita.
'D nans a costa seportura
scota 'l crij dla mia tortura:
«Salva, ò Crist, mia creatura!».
Hic ergo parce Deus:
Pie Jesu Dómine.
Dona eis requiem. Amen.
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sàbaoth.
Sant, Sant, Sant
a l'é 'l Signor ëd coi ch'as bato
për difende la soa tèra
e ch'a dàn la vita an guèra.
Hosánna in excélsis.
Sant, Sant, Sant
a l'é 'l Signor dij mòrt ch'a vivo
'd tuti ij viv ant la memòria
e 'nt ël Paradis d' Soa glòria.
Hosánna in excélsis.
Agnus Dei
Agnel càndi 'd Nosgnor
che 't monde ij pecà dël mond,
dà la pas a mè fieul.
Miserere nobis.
Agnel càndi 'd Nosgnor,
ëd la tomba ant ël profond
scàuda j'òss ëd mè fieul.
Miserere nobis.
Agnel càndi 'd Nosgnor,
për ël mè cheur sol al mond
guida Ti an Cel mè fieul.
Dona nobis pacem
sempiternam.
Libera me, Domine
L'é scura la montagna e la tèra a tramola.
Lë sparm am gela 'l sangh, a më strenz a la gola.
Libera me, Dómine.
J'é pì nen un pò 'd vita ant mè cheur ch'a së s-cianca.
M'abandon-a ògni fòrsa e la rason am manca.
Libera me, Dómine.
Lë slussi am brusa j'euj, mia carn l'é tuta an fiama
e 'l crij dël vent am pòrta una paròla: «Mama!».
Libera me, Dómine.
Nosgnor, Nosgnor, giutme! Su costa seportura
fé ch'ai meuira una mare tra ij brass d'soa creatura.
Réquiem aetérnam.
E quand a spontrà l'alba 'd Vòstra grassia divin-a
fé che doi cheur a sio doe smens d'na stèila alpin-a.
Réquiem aetérnam dona eis Dómine:
et lux perpétua
luceat eis.
Roma, 13 mars 1947
Da Ël Tòr N° 31/32 15 dicembre 1947 ~ 1 gennaio 1948
La descrizione della fine di Nino Autelli, praticamente identica a quella fornita da Olivero, si trova anche nel saggio di Giampaolo Pansa Sconosciuto 1945, Sperling & Kupfer Milano 2005. Nella parte quarta del volume, un intero capitolo La fiaba di Nino è dedicato a Nino Autelli e al ricordo del suo assassinio raccontato dalla di lui figlia Paola. È citato pure il giudizio di Luigi Olivero su Masnà di Autelli: la più alta voce della prosa fiabesca in piemontese di tutti i tempi.
Da Sconosciuto 1945 estraggo alcuni brani del ricordo del padre da parte della figlia Paola.
Una cartolina spedita da Verona da Nino alla figlia il 16 aprile 1942: «Mia cara Paola, nel mio continuo andare per le strade del mondo, sei tu il mio pensiero più bello e la mia gioia più pura. Tuo babbo».
Il racconto di Paola:
Dopo la maturità, nel novembre del 1922, a 19 anni, si è iscritto alla facoltà di Medicina, all’Università di Torino. Poi si è accorto che il sangue gli faceva impressione e ha deciso di abbandonare. Ha preso il diploma magistrale e ha cominciato a insegnare come maestro elementare.
Ha fatto il servizio militare da soldato semplice. Nel marzo 1936 è andato volontario in Africa Orientale, come soldato della Sussistenza, il servizio che distribuiva i viveri ai militari. Aveva 33 anni e non era ancora sposato. È rimasto in Africa sino al gennaio 1937. Alla guerra di Spagna no, per quella non è partito.
Papà e mamma si sono sposati nel novembre del 1940, qui a Spinetta. E pochi mesi dopo, lui è stato richiamato alle armi. Dal momento che aveva frequentato Medicina, l’hanno messo nella Sanità, ancora da soldato semplice. Faceva la spola tra il fronte russo e l’Italia, sui treni ospedale che riportavano in Patria i nostri militari feriti.
Quando sono nata io, il 4 ottobre 1941, lui era a Kolozsvar, in Transilvania, una tappa di quei convogli. Scriveva alla mamma: «Sono stato assegnato alla vettura dei feriti gravi, tutti barellati. Sono contento di questo incarico perché avrò modo di essere più vicino a coloro che hanno vissuto la guerra e di esercitare verso di essi tutta la mia umana simpatia e il mio spirito di carità». Dopo due anni di servizio duro sui treni ospedale, papà si è ammalato ed è stato messo in congedo.
Quando è nata la Repubblica sociale, lui si è iscritto al Partito fascista repubblicano. Anche qui non ha avuto cariche, mansioni speciali, gradi. Poi nel luglio 1944, il segretario del Pfr, Alessandro Pavolini, ha deciso di militarizzare il partito: tutti gli iscritti maschi, dai 18 ai 60 anni, dovevano arruolarsi in una formazione militare, le Brigate nere. In questo modo, anche papà ha vestito di nuovo la divisa. Da semplice milite della Brigata nera «Attilio Prato», senza partecipare a rastrellamenti o a operazioni contro i partigiani. Frequentava la sede della federazione, ad Alessandria. Penso che facesse lo scritturale, addetto a qualche ufficio. E nient’altro. Il 25 aprile la mamma è andata a prenderlo in bicicletta, portandogli un abito civile. Papà è ritornato a casa, in questa villetta. Non ha mai pensato di scappare. Stava qui, allora il cortile era aperto, non esisteva la recinzione che lei avrà notato (Paola racconta a Giampaolo Pansa n.d.r.). Lavorava nel giardino, si faceva vedere.
Ho aggiunto questi ricordi di Nino da parte della figlia Paola in quanto permettono di meglio comprendere la figura, l'umanità. la coerenza di questo, permettetemelo, grande piemontese che, a distanza di 70 anni dal suo vile assassinio, meriterebbe di essere maggiormente conosciuto in particolare dalle nuove generazioni.
In conclusione un racconto di Nino 'L pan dël mort tratto da Armanach Piemontèis del 1932, non raccolto poi in volume.
'L pan dël mort
Quand ch'i era masnà, bôn'anima 'd me pare, sicôme, anlôra a me pais a j'era gnuñe scole, a l'ha butame 'nt le man a me barba preive, ch'a stasìa 'nt un paisot d'le Langhe piantà propi 'nsima la pônta d'un brich.
Me barba, eben, venta savej, tuti i pover ch'a j'ero d'passage 'nsima a nostr brich ai dasìa da deurme; lon che 'na seira, giusta 'nt côl temp che mi j'era l'à, a l'è rivajne un ch'a l'era pien ëd freid e ch'a tôssìa.
Tôgniña, ch'a l'era la serva, l'ha daje subit 'n pò d'roba caôda e a l'ha falô côgiè 'nsima 'na paiassa.
Ma a l'avìa di s-ciat ëd tôss ch'a fasìa franch peña; e mincatant as butava a parlè tut da sôl.
Mi, ch'i j'era curiôs, sôn andait pianin, pianin tacà la porta e l'hai sentù ch'a disìa parei: «T'l'has propi nen 'na frisa d'cômapassiôn! Lassme chieté 'na minuta!».
E peui ai piava tôrna la tôss ch'a tacava a bôlversselô côme prima.
Bin, veule savei côn chi ch'a parlava côl pôvr'om? A parlava côn sôa tôss, a parlava.
Mi côla neuit, fè cônt, l'hai nen durmì gnanca 'na stissa. I fasìa 'd tut për nen sente, ma côi côlp ëd tôss arbômbavô côsì fort për tuta la cà, che fiña le muraje a smijava ch'arsaôtessô.
A la matin però l'è smijà ch'a steissa 'na frisa mej.
Peui, s'ël pì tard, me barba a l'ha dime a mi: «Va 'n pò a vëdde se côl povr'om a l'ha dë bsogn quaicos».
Mi l'hai tôcalô s'na spala e l'hai faje: «L'ha dit me barba s'i l'eve dë bsogn quaicos»; ma, sicome a l'ha nen dame risposta, sôn andait tacà la fnestra, ch'a guardava 'n s'la valada. Côl dì là a fiôcava largh 'na man. Tuta la val l'era un turbij 'd valosche e as vëdìa pì gnente, fora che côl girè 'd valosche 'nt l'aria.
Mi i sercava 'd fissene uña 'n mes a tute j'aôtre, côsì për fé, e peui 'd seguitela fiña 'n tera; ma a forssa 'd ancantame, côsì che l'hai gnanca sentù me barba ch'a l'era entrà 'nt la stanssa.
«T'l'has nen vëdù ch'a l'è mort?»
Anlôra mi i sôn vôltame dlônch, fasend un tërmôlôn, e i sôn scapà, dël côlp côme la losna.
***
*
La giornà apress, côme i veui dive, Tôgniña a l'ha fait 'l pan dël mort.
Tuti i pais, as sa ben, j'è sôa côstuma.
Bele là, quand ch'ai meurìa quaidun, a fasìô 'l pan, ch'as ciamava precisament 'l pan dël mort e peui ai na dasìo 'na ghërssa a tuti côi
ch'andasìô a cômpagnelô.
Côsì a l'han damla d'cò a mi.
Ma mi, peña ch'i sôn stait a ca, sôn andait, dë scôndiôn, a stërmela 'n pressa dapara 'n roch, sôta la fioca.
Peui dop, m'arcordô d'cò ch'i sôn mai pi passà davsin a côl roch, l'istess côma ch'ai fussa sôtrà bele là, côl povr'om.
Nino Autelli
d'la Cômpanìa d'ij Brandè (3)
NOTE
(1) Federico Garcia Lorca poeta andaluso nato a Fuente Vaqueros, vicino a Granada, il 5 giugno 1898. Fucilato dai franchisti ed il suo corpo per sempre disperso nei barrancos di Viznar, sulle alture retrostanti Granada, il 17 agosto del 1936.
(2) Robert Brassilach scrittore, giornalista e critico cinematografico francese nato a Perpignan, nei Pirenei orientali, il 31 marzo 1909. Collaborazionista e quindi imputato di tradimento ed intelligenza con il nemico. Condannato a morte. Gli fu rifiutata la grazia da parte del Generale De Gaulle. Fucilato nel forte di Montrouge il 6 febbraio 1945.
(3) Come avrete potuto notare la grafia, riportata nel racconto di Autelli, non è quella già utilizzata nel precedente Armanach Piemontèis del 1931. Per mancanza di fondi, Pinin Pacòt era dovuto ricorrere all'aiuto della Famija Turineisa che, oltre a pretendere l'inserimento dei suoi collaboratori ha voluto il ritorno alla grafia utilizzata dagli scrittori che collaboravano al suo giornale 'l caval 'd brôns. Da qui l'utilizzo di ô, ñ che, per correttezza, ho voluto conservare. Gli scrittori e poeti della cerchia di Pacòt, orgogliosamente, si firmarono tutti d'la Cômpanìa d'ij Brandè. Dall'anno successivo Pacòt ritornerà alla grafia cosidetta Pacòt - Viglongo alla formazione della quale avevano collaborato anche, in numerose riunioni nel 1930, Luigi Olivero, Nino Costa, Alfredo Formica, Leo Torrero ed altri ancora.
Giovanni Delfino
delfino.giovanni@virgilio.it
Piemontèis ancheuj Ann 34-35 N° 7/8 luj~agost 2016~N° 4 avril 2017 (9 puntate)
Filippo Tartùfari
Roma 1884 ~ Torino 1956
La vita
I primi anni
Luigi Olivero a proposito della prima raccolta di poesie di Tartùfari Du' risate e un sospiro:
Ecco un libro di cui non sai se più apprezzare i versi flùidi, vispi, cordiali o le illustrazioni che li commentano: morbide, agute, dilettosissime. La ragione di questa spontanea aderenza fra la parola e la figura è dovuta ad un elemento molto semplice e nello stesso tempo molto raro: all'amicizia che lega due temperamenti di poeti. Un poeta della penna, Filippo Tartùfari. E un poeta della matita, Felice Vellan.
... Scrocchiarello, proprio così: croccantino. Uno squisito rettangolino di Torrone d'Alba. Ecco cos'è il sonetto romanesco di Tartùfari.
... Questo libro veramente indovinato sembra scritto con un rametto temperato di ciliegio in fiore, intinto in una làcrima agrodolce, nel chiaro azzurro del nostro cielo alpino.
(da Ël Tòr N° 15 del 11 maggio 1946)
Filippo Tartùfari nasce a Roma nel 1884. Il nonno ne trae un oroscopo per lui: sarebbe stato un uomo fortunato. Non può prevedere che quella generazione sarebbe passata tra ben quattro guerre.
Di padre proveniente da Osimo, nella Marche, impiegato di banca; di madre romana, orfana da piccola e accolta dai nonni a Novillara, vicino a Pesaro, Clarice importante romanziera di fine ottocento, inizio novecento.
Su consiglio della madre si laurea in ingegneria cui poco dopo fa seguire anche lauree in matematica ed elettrochimica. Rifiuta un impiego all'Officina del Gas di Roma. Per breve tempo nel 1910 è a Lecce come Allievo Ispettore delle Ferrovie dello Stato. Si trasferisce quindi a Torino dove vince un concorso per ingegnere della Casa Reale. Lavora al Castello di Moncalieri per rimodernare, su incarico della Principessa Clotilde, un salone del castello da lei stessa abitato. Qualche critica sul lavoro del Tartùfari da parte della Principessa, ma anche lodi tanto che, da allora, è il solo ingegnere che ella chiama per i lavori nel castello.
Lo scoppio della prima guerra mondiale lo trova a San Rossore dove lavora al rimodernamento dell'appartamento reale al Casino del Combo. Nominato Tenente del Genio diviene Capo Ufficio delle invenzioni.
A guerra finita torna a Torino dove prende moglie nel 1919, una torinesina di origine valsesiana mia cara e fedelissima compagna, affettuosa mamma del mio figliolo Giovanni.
Brevemente a Roma al Ministero delle Belle Arti come il più giovane capodivisione di allora. Ufficio piccolissimo e mansioni che non gli si confanno lo spingono a chiedere la liquidazione e tornare a Torino dove apre uno Studio Tecnico in Cso Vittorio all'angolo con Via della Rocca. I clienti latitano. Ma, poco a poco, il lavoro prende corpo in particolare nel ramo dell'utensileria meccanica. In breve apre un magazzino in Via dei Mille. Così per qualche anno fino all'avverarsi della profezia del nonno. Entra nel suo magazzino un ingegnere ungherese con una misteriosa valigetta. Ne trae un piccolo apparecchio radio ad una sola valvola. Filippo ne fa alcune prove, con scarsi risultati, ne intuisce però i possibili sviluppi futuri. Fa subito degli ordini, trasforma completamente la ditta dedicandosi anima e corpo al commercio della radio. Per un anno risultati quasi nulli ma, nel 1926, Torino è dotata di una potente stazione trasmittente. Tartùfari inizia a costruire apparecchi a galena, ma piuttosto voluminosi per attrarre la psicologia del compratore ancora inesperto di questa nuova tecnologia. Era un piacere vedere uscire a frotte i compratori con i loro grossi pacchi.
Nuova idea e colpo di fortuna: costruire un'antenna facilmente trasportabile e adatta ad ogni tipo di apparecchio e che potesse ridurre, se non eliminare, i fastidiosi disturbi che all'epoca rendevano sgradevole la ricezione. Antenna schermata la chiama ed il successo è notevole.
Si divide tra il negozio, la direzione di una scuola pratica di radiotecnica prima, l'Istituto Professionale di Torino con la cattedra di radio poi, che dovette abbandonare per una disposizione fascista che vieta l'insegnamento nelle scuole pubbliche ai non tesserati.
La passione per la montagna
Così Tartùfari ci racconta del perché abbia preso la decisione di fermarsi a Torino:
... un giorno m'imbattei in una bella creatura: era una bionda di quelle bionde torinesi che ... levati. Come imbambolato mi fermai a guardarla e mentre mi passava davanti la urtai con ardore un po' troppo giovanile. Attesi trepidante il giusto rimprovero e invece
La bionda se vortò, fece un soriso
e me disse un «pardon» così carino
che ner sentillo ce rimasi scosso.
Gridai: - Ma che città, che paradiso!
Nun parto più, me fermo qui a Torino...
E da quer giorno non me son più mosso!
Studente a Roma conosce una piccola torinese che soprannomina la piemontesina; questa, con nostalgia, gli parla spesso della sua Torino e della sua poetica collina, delle superbe montagne del Piemonte. Una mattina di maggio, passeggiando malinconico per Torino si sente chiamare; è l'antica amica la piemontesina. Convenevoli. Filippo confessa della sua scarsa attività fisica, di essere diventato ben grasso. La piemontesina lo invita ad una gita alla Sagra di San Michele la domenica successiva con appuntamento alle sei del mattino alla stazione di Porta Nuova ed aggiunge che così sarebbero finite anche le sue paturnie.
Con un amico che ne sa di montagna corre ad equipaggiarsi. La domenica mattina giunge per tempo alla stazione bardato come avesse dovuto arrivare in punta al Cervino ed è accolto da uno scoppio di ilarità.
E in questo modo è nata la passione che lo accompagnerà per il resto della vita. Partecipa a tutte le gite domenicali nelle valli vicine a Torino. Poi, conosciuto e fatta amicizia con un biellese, con lui inizia tutta una serie di gite alpine. L'amico prende l'abitudine di portare nel suo sacco un barattolo di vernice rossa ed un piccolo pennello. Nei punti più panoramici scrive su un qualche sasso Tartùfari-Radio, sorta di pubblicità a buon mercato, così dice l'amico.
Un giorno però Filippo riceve visita di un milite della Finanza con una bella contravvenzione! Corre da un amico colonnello della Tributaria, giura di non essere stato lui a fare quelle scritte; la cosa si accomoda con la battuta da parte del colonnello Neh, ingegnè ccà nisciuno è ffesso. Nelle gite degli anni a venire con piacere incontra ancora qualcuna di quelle iscrizioni seppure un po' sbiadite.
Le gite si susseguono nel tempo e si fanno più impegnative fino all'agosto del 1933 quando il destino prepara un'amara sorpresa per Filippo.
La morte dell'adorata mamma
È a Valtournanche con un gruppo di amici per belle gite in alta montagna. Un telegramma Mamma malata, parti subito. Al più presto giunge a Santa Fiora, nell'Appennino ai piedi dell'Amiata, accolto dalla sorella. La mamma si è sentita male a seguito degli sforzi compiuti per portare a termine il suo ultimo romanzo L'uomo senza volto la cui edizione curerà Filippo qualche anno dopo.
Merita ricordare l'ultimo incontro di Clarice e Filippo con le sue parole :
- Senti Filippo, ascoltami attentamente.
- Non ti affaticare, mamma.
- Mi sento meglio, non temere. Ascolta: tu sai che io non sono stata mai visionaria né suggestionabile; ebbene io ti dico con la più completa calma e in piena conoscenza che, quando sono stramazzata al suolo, papà mi ha aiutata a rimettermi sulla sedia e mi ha detto: - Coraggio Clarice. Poi è sparito.
Mi tornò un tratto alla mente la fisionomia dolce e bonaria di mio padre che improvvisamente, cinque anni prima, era sparito dalla vita terrena, e guardai mia madre con una espressione di dolore e stupore. Ella, forse, vide nel mio sguardo anche un'ombra di melanconico dubbio per cui riprese:
- Credimi, è vero! Ricordati Filippo, esiste un'altra vita, ora ne sono sicura e io nei momenti più importanti della tua esistenza ti sarò a fianco. Quando un grave dispiacere ti affliggerà, pensami intensamente, e rivedrai la tua mamma.
Questo fu l'ultimo raggio della sua bella e serena intelligenza, ed io ancora oggi sento risuonare le sue parole nel profondo dell'anima.
Il 2 settembre del 1933 Clarice Tartùfari lascia questa vita e Filippo, sbrigate le dovute formalità a Roma, fa ritorno alla ora sua Torino.
Ricordi di vita famigliare
Ancora giovinetto Filippo accompagna la madre a Milano per la rappresentazione della sua commedia L'eroe, lavoro che diviene cavallo di battaglia per la compagnia veneziana di Ferruccio Benini che la presenta con il titolo tradotto in Quelli che comanda.
In quell'occasione, con la mamma, si reca a far visita alla poetessa Ada Negri. Costei, ad un certo punto dice alla madre:
- Perché pure te, Clarice, non scrivi con il nome da nubile? Se non erro esso è Gouzy il cui sapore, un po' esotico, non dispiacerebbe al pubblico.
La madre rimane un attimo pensosa, poi:
- Cara Ada, io farò piuttosto poco che molto nella mia carriera artistica, ma quel poco desidero che serva a rendere sempre più conosciuto il nome di mio marito, che è quello del mio figliuolo.
E nel pronunciare quelle parole carezza e da un bacio al figlio.
Nei momenti bui per le finanze famigliari Clarice scrive di getto novelle. Novelle delle tasse le definirà poi Filippo in quanto utili al pagamento delle tasse scolastiche per lui e la sorella Luisa.
In ricordo della madre accende un'assicurazione a favore del figlio. Somma che potrà ritirare compiuti i 40 anni ma che dovrà destinare alla ristampa, a sua scelta, di qualche romanzo della madre e se quella ristampa non ti rifarà materialmente della spesa, poco male; anche in tal caso essa ti procurerà il vantaggio di crescere nella estimazione degli amici, perché colui che cerca di onorare i propri congiunti veramente meritevoli, riscuote sempre ammirazione e rispetto.
Clarice è deposta provvisoriamente in un loculo prestato da amici a Santa Fiora. Poiché il nonno materno di Filippo è stato Comandante a Roma delle truppe pontificie ha tomba di famiglia nella zona del Verano denominata Pincetto poiché elevata e ricca di alberi e piante, appare al visitatore come un melanconico Pincio attraversato da vialetti ombrosi. Dure le vicissitudini incontrate dalla sorella per ottenere il trasferimento della tomba alla propria famiglia. Amici e parenti concorrono al rimodernamento e lo scultore Nicola D'Anterio scolpisce un riuscitissimo medaglione. Funerali a Roma in Santa Maria degli Angeli con enorme concorso di folla, gli sollevano maggiormente il cuore le parole di una semplice popolana: Era una grande poetessa!
Filippo cerca quindi consolazione nella rilettura dei brani dei romanzi della madre dedicati ai cantucci reconditi e poetici di Roma. Dopo aver letto un capitolo che si svolge sullo sfondo del Bosco Sacro della Via Appia Antica, sente il desiderio di rivisitare quei posti da cui da tanti anni manca. Porta San Sebastiano, la chiesa di San Callisto, la Via Appia Antica con le tombe romane che, sebbene morse dal tempo, e spogliate del fulgore dei marmi, stanno ancora a testimoniare della potenza e della fastosità dei nostri avi.
Commozioni sconosciute lo turbano, si stupisce dei suoi nuovi sentimenti e prova la medesima impressione di quando, studentello, frequentando le esercitazioni di astronomia, vedeva trasformarsi la massa scura e grigia del cielo in una superficie costellata di luci vive e brillanti. Sente la poesia forte e solenne della storica via. È nel Bosco Sacro che cerca di esprimere con frase rapida e serrata quanto gli turbina d'intorno. E qui risolve che sempre, quando cercherò di fermare nel verso una mia impressione, sarò portato a svolgerla nella forma poetica del sonetto.
Come più volte racconterà in seguito è proprio l'episodio della morte dell'adorata madre che lo ha condotto sulla via della poesia che da allora lo seguirà per il resto della vita.
Gli anni della maturità
Rientrato a Torino trova che gli affari languono. Le vendite stentano, si accresce la concorrenza. Si convince che è necessario spostarsi nel centro della città. Si decide al grande passo ed eccolo nei locali di Piazza Carignano dove, dalle vetrine del suo nuovo negozio, può ammirare Palazzo Carignano.
La sorella gli scrive pregandolo di portare di persona alcuni libri della mamma a Benedetto Croce, in quei giorni in vacanza con la moglie in quel di Meana. Aveva espresso il desiderio di rimediare alla mancanza di nulla aver scritto su Clarice Tartùfari, ella vivente, e di voler scrivere uno studio sulla sua opera da pubblicarsi nella rivista Critica. Croce aggiunge: Clarice Tartùfari è una delle figure più caratteristiche della sua epoca e alcuni de' suoi libri sono molto interessanti per la storia della letteratura nel periodo tra l'ottocento e il novecento.
Un vero monumento innalzato alla memoria della donna e della scrittrice è il lungo e denso articolo che il Croce scrive per Critica. Durante questo incontro Tartùfari declama alcuni suoi sonetti in lingua, il Croce glieli fa ripetere e poi con brutalità esclama: Questi sonetti letterariamente non mi vanno, per la ragione che hanno troppo colore: possono paragonarsi a una bella popolana forte e rubiconda, imbellettata e vestita con abiti cittadini e alla moda; se ne ritrae una sensazione curiosa, pure comprendendone la bellezza sostanziale. Perché voi, Tartùfari, non vi esprimete nei versi come nel vostro parlare così vivo e colorito; perché non scrivete per ora in dialetto romanesco? Codesto eccesso di colore, che in lingua pura è un difetto d'incontinenza, diverrà una qualità in vernacolo e voi diverrete un buon poeta dialettale se darete alla poesia la personale impronta del vostro carattere.
Tartùfari segue l'illuminato consiglio trattando in lingua da allora in poi esclusivamente soggetti di concezione popolaresca. A circa dieci anni di distanza dal colloquio con Croce, Tartùfari gli invia la sua prima raccolta di sonetti in romanesco Du' risate e un sospiro e ne riceve in cambio una lunga lettera il cui giudizio sulla sua poesia è così possibile sintetizzare: Ella ha un'anima semplice e limpida.
Alcune amicizie
Nino Costa
Un consiglio della madre è stato quello di studiare i grandi della letteratura. Per tre anni dopo la sua morte a questo si dedica. Inizia dai poeti dialettali, Belli, Porta, Meli, Pascarella, Barbarani, Trilussa. Giunge infine alla poesia piemontese di Nino Costa.
Gli viene spontaneo il desiderio di conoscerlo. Tramite un amico ha un appuntamento. Subito fraternizzano, scambio di recitazione di poesie. Filippo chiede a Nino aiuto nello studio della poesia dialettale piemontese. Due volte la settimana per circa un anno Costa gli commenta le più caratteristiche poesie dei suoi conterranei mettendone le bellezze in evidenza. Costa si presta a parecchie dizioni con Tartùfari di cui alcune al Circolo degli Artisti.
Tartùfari pubblica sul giornale dell'Associazione Pietro Micca venti sonetti in romanesco nei quali un immaginario Sor Totò racconta al figlio Romoletto la storia degli eventi del famoso assedio. L'Associazione decide poi di riunire in fascicolo i venti sonetti. Costa si presenta a Filippo con un manoscritto dicendo:
Sono poche parole che ho scritto per il tuo primo libro; è una presentazione ai miei concittadini torinesi de' tuoi sonetti in romanesco.
Lo scritto figura come prefazione a Pietro Micca ('Na scampagnata a Superga) del 1942.
Quando Costa passa in Piazza Carignano non manca una scappatina nel suo negozio. Faceva capolino all'uscio e diceva scherzosamente: c'è il bottegaro poeta? Ed è così che quel soprannome lo ha adottato rimanendogli cucito addosso.
Una sera i due passeggiano in Piazza Castello, sui loro capi sfrecciano stormi di rondoni nell'ora che più inteneriva il cuore di Guido Gozzano. Parlano del poeta canavesano, Nino ricorda un pensiero letto in Contemplazioni e che come Guido avrebbe voluto esser nato lontano da Torino per poterla osservare con occhi nuovi.
- Vedi Tartùfari? I tuoi sonetti romaneschi che trattano del Piemonte e di Torino, mi commuovono, perché tu guardi a queste bellezze con occhio differente dal mio, con maggiore indipendenza ed obbiettività, procurandomi nuove sensazioni e rivelandomi impensate bellezze.
Poi la guerra, gli incontri si diradano. La morte del figlio Mario sul Genevris, una delle prime vittime della guerra di liberazione. Ancora un breve incontro una sera, già minato dal male che a breve lo avrebbe condotto a incontrare Mario. Recita alcuni versi desolati. Chiede a Filippo se avesse scritto qualche cosa di nuovo. Filippo gli risponde di aver variato l'ultima terzina del sonetto Er fijo tuo
Ma tu ritroverai un antro maschietto
che te consola; er fijo de tu fijo
un giorno te dirà:«So qui nonnetto!»
A queste parole Nino gli si getta singhizzando tra le braccia: È vero, è vero! Ma io non potrò più essere consolato dal figlio di mio figlio, del mio Mario!
Luigi Olivero
La pubblicazione di Pietro Micca ('Na scampagnata a Superga) segna forse la personale conoscenza con Luigi Olivero.
Un dopopranzo mi trovavo al Pincio presso una aiuola che sovente è il punto di ritrovo dei subalpini residenti a Roma, tanto che io l’ho battezzata l’aiuola dei piemontesi, perché in tale angolo poetico, un giorno si trovava il busto di Angelo Brofferio che fu rimosso ed oggi ricollocato di nuovo.
Ero seduto su di una banchina e ammiravo dalla balaustrata il viale degli oleandri che sale dal piccolo piazzale, dov’è il monumento ai Cairoli.
Vicino a me c’era un signore piccolo, bruno, occhi neri e brillanti. Teneva sotto braccio uno scartafaccio. Accesa la sigaretta, ecco che si mette a correggere dei fogli, evidentemente bozze di stampa.
Non so resistere alla tentazione di rivolgergli la parola:
Mi racconta che è redattore politico di un giornale romano e che le bozze in correzione sono quelle del suo ultimo libro sull’America. Olivero è un uomo dinamico, pieno di brio e, quando parla, si muove come avesse dentro una molla. Io, invece, sono più pacioso e fu forse per effetto dei contrasti che simpatizzammo e ci legammo in seguito d’una amicizia sincera.
In quel periodo del mio soggiorno romano ci vedevamo quasi tutti i giorni e ci leggevamo i nostri versi. Curioso: io ho scritto dei sonetti romaneschi su Torino e lui invece, da buon Gianduja, delle liriche su Roma, in piemontese.
È un caro e fedele amico pieno d’ingegno, ma bisogna saperlo prendere per il suo verso poiché, molte volte, si lascia vincere dalla mania del sarcasmo e allora i suoi apprezzamenti divengono pungenti. Molti autori gli sono rimasti nemici, perché tutti non sanno comprendere che sotto quella ironia, forse troppo spinta, batte un cuore buono e schietto.
Nel suo volume autobiografico Un bottegaro poeta a Torino Tartùfari ci offre un bel quadretto della Pasquetta romana del 1952 con alcuni Piemontesi a Roma.
Roma è insolitamente grigia in questo pomeriggio di Pasquetta ed io tutto solo, discendendo per la via delle Quattro Fontane:
… So scocciato
senza sole me sento sconsolato!
Arrivo alla Chiesa di Trinità dei Monti, ed invece di prendere come di consueto la strada alberata che porta a Villa Medici ed al Pincio, discendo per l’ampia scalinata che porta a piazza di Spagna e mi siedo su di un pilastro della magnifica fontana, la Barcaccia del Bernini.
Mi guardo intorno e vivo per alcuni istanti nella dolce illusione di una Roma settecentesca.
Ecco là via Condotti, con il suo antico Caffè Greco, ricco di nobili antiche tradizioni, ma ahimè quanto oggi diverso.
Povero Caffè Greco è no squallore!
Me l’arivedo co la fantasia
quanno, nell’Ottocento, Roma mia
era piena d’artisti e de sprennore.
Tempi beati, tempi ormai lontani
quanno Gioacchino Belli cor sonetto
faceva gode e ride li romani.
Mi sembra che giunga dal caffè lo scoppiettio delle risate dei tranquilli romani, mentre in un cantuccio solitario il povero Giacomo, pensoso e pallido gobbetto, rimane serio ed accigliato pur prestando orecchio alle pasquinate del giorno e alle facezie rimate di Gioacchino Belli, dalla faccia arguta e dal prestante fisico in contrasto con l’esile figura del poeta.
Mi pare di udire per Piazza di Spagna lo scalpitio dei cavalli che conducono al galoppo sfrenato i signori del tempo; le voci degli staffieri annuncianti il passaggio dei loro padroni. – Largo, largo, al gran Conte di Espinosa de Valera – e sorrido alla vista di un povero scagnozzo di campagna, che a stento riesce a schivare gli schizzi di fango, mentre un altro Giacomo, veneziano, dal naso adunco, dal portamento elegante e fastoso, prodiga a destra e a sinistra il suo sorriso di geniale avventuriero.
Vedo lo sciame degli abatini attillati e saltellanti come quei cagnolini neri che deliziano le signore eleganti; ammiro gli opulenti fianchi delle floride «minenti» romane avvolte in ampi e preziosi scialli a fiorami dai colori vivaci e il codazzo dei moscardini che mormorano parole procaci, veri pappagalli dell’epoca; popolani agghindati a festa con il giubbetto di velluto, calzoni corti e scarponcini a fibbie argentate. Sento lo scampanellio degli infiorati carretti a soffietto, che, tirati da cavalli adorni sul bastio e sulle briglie di campanelli, portano l’ambrato vino dei castelli romani e vanno e vengono da Porta del Popolo.
Questi fantasmi di altri tempi mi rasserenano.
A un tratto interrompe il mio sogno una voce:
Mi volto di scatto e riconosco un antico compagno di scuola. Ma
come cambiato!
Ritrovo questo amico, fatto calvo, panciuto, con il pallore caratteristico del lavoratore intellettuale. Che differenza da allora! Lo rivedo sui banchi del Politecnico, quando, come tutti gli altri condiscepoli, anch’io lo chiamavo «signorina», tanto era biondo, esile e sentimentale.
vecchi amici se ne sono andati, dispersi dall’ala del tempo. Questo pomeriggio così grigio mi rende melanconico.
- Sei dunque diventato poeta? Andiamo dal sor Augusto qui a via della Vite e con un buon bicchierotto di Frascati riacquisterai di nuovo il buonumore.
Entriamo: il locale è insolitamente affollato per la Pasquetta. Mentre giro lo sguardo per trovare un posto libero mi sento chiamare:
È il poeta piemontese Luigi Olivero che mi fa cenno con la mano. Andiamo al suo tavolo dove egli sta con alcuni artisti, giornalisti e soci della “Famija Piemontèisa” di Roma.
Presentazioni, cordiali strette di mano.
e rivolgendosi ai suoi compagni esclama:
giornalista e profondo conoscitore della musa romanesca, ed io a lui:
Perché te meravija che un romano
baccaja sempre che Torino è bella!
È inutile che fai sta risarella,
lo strillo a tutti, bé, che c’è de strano?
sai meglio di qualunque altro che il “bougianen” sente la nostalgia della sua “bela Turin” specie in queste ricorrenze. Oggi, giorno di festa, la nostra melanconia aumenta; lassù Pasquetta è una vera giornata di gioia, ma qui per noi… Suvvia, levaci di dosso questa cappa grigia, facci rivivere per qualche istante fra i viottoletti di Valsalice e di Santa Margherita; dì a noi, poveri esiliati, qualche tuo sonetto. In compenso, io pago la merenda a tutti; mi mangio i diritti di autore che ho riscosso proprio ieri dall’editore per il mio nuovo libro.
E si batte soddisfatto la tasca della giacca.
- La cosa mi lusinga e poi mi conviene - rispondo sorridendo - ma voi capite che, più di un poeta, io sono un cantastorie e me ne vanto. Vengo dal popolo, e canto per il popolo. S’io fossi nato al tempo dell’Angiolieri, mi si sarebbe sentito cantare in mezzo alle brigate come queste, gli stornelli romaneschi ispirati dagli avvenimenti del giorno. È curioso, che io «romano de Roma» canti a voi torinesi le bellezze della Collina. Ma tu, caro Olivero, non mi hai deliziato con le tue rime piemontesi sulle bellezze delle fontane romane?
Bevo un bicchiere del buon vinetto dei castelli, indi comincio.
Piazza Castello e per Via Po, Piazza Vittorio, vi condurrò a vedere il tramonto a Superga. Prima però di cominciare, andiamo a prendere le sigarette sotto i portici di Piazza Castello, dalla famosa Gina.
Filippo recita la poesia dedicata alla tabaccaia, riprodotta più avanti, quindi il sonetto Piazza Vittorio Veneto, qualche altro verso, poi:
Vedo er Sor Augusto, che tutto dignitoso porta sopra un vassoio una grande coppa colma di vino di Frascati e me la offre mentre gli amici intorno con il bicchiere alzato m'invitano a compiere la cerimonia del «glu-glu» simile a quella che avevo celebrato nella Tampa del Circolo degli Artisti a Torino.
Il poeta accosta il calice
al suo labbro: scende giù
schietto il vino dei Castelli,
mentre ognuno fa: «glu-».
Alla fine Olivero, versandomi sulla testa una goccia di vino, esclama enfaticamente:
- Filippo Tartùfari, io qui, vate piemontese, ti consacro nella Città Eterna, Bottegaro poeta a Torino! - Bevi!
Grida, risate, abbracci affettuosi ed io rimango mezzo stordito non tanto per l'onore prodigatomi, quanto per la copiosa bevuta nella coppa tradizionale. Tuttavia riprendo
- Ed ora amici, come vi avevo promesso, vi porto ad ammirare il tramonto a Superga e così avrà termine la nostra passeggiata sentimentale
Tatrufari recita Tramonto a Superga, quindi:
Un'altra bevuta e poi ci lasciamo. Io sento il desiderio di camminare a lungo, il vino dei Castelli mi ha stordito.
Trilussa
Ecco il resoconto dello stesso Tartùfari relativo al suo primo incontro con Trilussa:
Una mattina a Roma mi incontro con Taddei, un giornalista, buon dicitore delle poesie di Trilussa. Andiamo insieme a casa del poeta a Via Maria Adelaide tra Piazza del Popolo e la sponda alberata del Tevere.
Sulla portoncina a pianterreno leggo su di una targhetta d'ottone: Trilussa. Entriamo e Taddei dice ad una donna che ci introduce:
- Si è levato?
- Si, aspettate un momento, vado ad avvertirlo.
Entriamo in uno stanzone altissimo che mi fa l'impressione di un magazzino di antiquario. Mentre attendiamo guardo incuriosito.
Due grandi pareti sono tappezzate con stoffa dipinta a guisa di mattoni. Su una specie di fregio, che corre lungo la parete di fronte, a cinque o sei metri di altezza, sono riprodotti gli eroi delle favole trilussiane. Altri animali, di svariato aspetto e in atteggiamenti curiosi, stanno disseminati ovunque. Si vedono soprammobili, scaffali di libri, ceramiche, vasi di vetro pieni di fiori e foglie, pupazzi romani, siciliani, armi e strumenti esotici e nostrani, preziose statuette di Capodimonte e di Sèvres, vecchie stoffe, terrecotte, lambicchi medievali, clessidre, damaschi.
Il soffitto, in cemento armato, fa contrasto col pavimento coperto d'un soffice tappeto rosso cosparso di pelle di tigri, leoni, orsi, zebre, rettili. Due enormi coccodrilli imbalsamati, con le fauci spalancate chiuse da tappi di bottiglie di champagne, pare che facciano la guardia sotto gli occhi ironici di un gran Budda di bronzo.
Tutto l'immenso studio è ingombro di mobili, oggetti d'arte, cianfrusaglie, quadri e quadretti di Mancini, Michetti, Dudovich; acqueforti di Roeder, Sartorio; caricature con le firme di Robida, Gandolin, Musacchio, Gec, Crespi, Bompard ecc., e anche di alcuni busti di Trilussa in cera, gesso, marmo e bronzo.
In un angolo, quasi nascosto, è il vano di una porta chiusa da un cancelletto di ferro battuto: si direbbe l'interno d'una pagoda indiana, dove un giorno deve aver regnato una strana atmosfera di galanteria e di mistero.
All'altro angolo, una scaletta di legno conduce ad una specie di ballatoio con balaustrata che gira sul fronte dello stanzone all'altezza di circa sei o sette metri dal suolo e si apre su strane cabine. Trilussa, che è un abilissimo falegname, si è fabbricato lassù, a tre o quattro metri dal soffitto, un appartamentino pensile: una cameretta da letto, uno spogliatoio, uno stanzino da bagno: qualche cosa che somiglia alle abitazioni costruite nella jungla di certe isole del Pacifico.
Vedo uscire dalla porticina del ballatoio una specie di gigante in veste da camera. Taddei lo saluta e gli dice:
- Tri, c'è qui Tartùfari, il bottegaro poeta di Torino che ti vuole dare l'ultimo suo libro.
- Va bè - risponde Trilussa in pretto romanesco - mo pijo er canestrino.
Fa scendere con una cordicella un panierino tutto a colori.
- Butta er libro dentro.
Trilussa lo sfoglia.
- Dimme quarche sonetto.
Mi accingo a soddisfare il desiderio del Poeta. Mi sembra di essere alle prove in un teatro. Trilussa dall'alto m'incoraggia. Taddei, seduto con le gambe incrociate su di un cuscino ha l'aspetto di un idolo indiano, la governante che toglieva la polvere si ferma ad ascoltarmi a bocca aperta, e Poppea la «bambaciona» gatta del Poeta, mi fa l'occhietto.
Dico li Tre crienti de montagna, poi La Società Anonima e infine Er pollo. *
Dopo di che Trilussa dice:
- Va bè, aspettateme un momento. Me vesto e vengo giù.
Taddei mormora sottovoce:
- Ahò, sei fortunato, perché in genere Tri, non fa tanti complimenti.
Dopo poco Trilussa scende. Il poeta esclama:
- Caro Tartùfari, tu sei stato per me un buon aperitivo. M'è venuta la voja d'un ber pollo arrosto. V'invito a desinare: magneremo puro le puntarelle alla insalata e se sciropperemo quarche bon bicchiere de Frascati.
Saluta la governante e le dice:
- Oggi nun magno a casa. Arrivederci.
Mi sembra di vedere incedere un principe romano, tanto il suo portamento è pieno di nobiltà.
E usciamo.
* La Società Anonima è a pag. 114 della raccolta Er cappio ar collo riportata in Un bottegaro poeta e Torino con numerose varianti. Er pollo, con titolo Er pollo de guera è a pag. 66 di Du' risate e un sospiro anche questa con parecchie varianti.
Qui di seguito Tre crienti de montagna che non fa parte delle poesie di Tartùfari raccolte in volume:
Quer cucciolotto scuro che m'abbaia
me fa le feste come un regazzino;
lo dovessi vedè com'è carino,
me smiccia da lontano e nun se sbaja.
Più giù me fa le poste un ber purcino
che becca li compagni e poi se squaja;
è un criente scontroso, viè vicino
vo robba da magnà, se no baccaja.
C'è un frate poi che viè da la montagna,
l'invito a cena, poverello, è stanco,
ma sarvete fratello quanto magna!
Dice che fa miracoli all'ingrosso:
Defatti beve sempre er vino bianco,
e invece er naso je diventa rosso.
Gli ultimi anni
Tartùfari pubblica il suo Un bottegaro poeta a Torino, da cui ho tratto moltissimo per tracciarne la vita, il 15 giugno del 1952.
Da quando ha dato sfogo alla sua vena poetica ha pubblicato Pietro Micca nel 1942, Du' risate e un sospiro nel 1946, Er cappio ar collo nel 1947, Montagna mia e La Tampa del Circolo degli Artisti di Torino nel 1948, Torino bella nel 1951.
Una breve pausa poi, in rapida successione, come se sentisse l'approssimarsi della fine, si susseguono, nel 1955 e nel 1956, Rapsodia torinese, Un gomitolo d'oro, Quadretti senza cornice e Torino in romanesco che sancisce il distacco del Poeta dal suo pubblico.
Proprio da quest'ultima raccolta ecco
L'urtimo "bogianen" ar monte de li Cappuccini
D'estate la domenica matina
va prima a sentì Messa a l'Annunziata
e fa in grazzia de Dio na passeggiata
pe le viuzze su de la Collina.
S'aggusta quel'arietta frizzantina,
se ferma un tantinello a la spianata
" dei Capuccini " e vede de facciata
la sù piazza Vittorio mattutina.
Poi guarda più lontano: " Che città,
ma come è granne, nun finisce più!
e quela Fiat dove arriverà? "
Sente ner core un struggimento fino,
ricorda er tempo de la gioventù
e ripensa a la sua vecchia Torino.
Filippo Tartùfari
Roma 1884 ~ Torino 1956
Le opere
Pietro Micca ('Na scampagnata a Superga)
Associazione Torinese "Pietro Micca" Torino, 1942
Tre edizioni tutte nello stesso anno, la seconda e la terza con aggiunta di 6 sonetti della serie Romoletto a Torino.
Volumetto in 8° piccolo di pag. 36, 20 sonetti, una presentazione di Nino Costa, una introduzione dello stesso Tartùfari e 26 disegni più la copertina di Felice Vellan.
Trattasi della prima raccolta di sonetti dati alle stampe da Filippo Tartùfari e Nino Costa ce la presenta da par suo:
Madonna poesia non soffre del mal del paese. Anzi, quando non varca i confini della provincia o della regione tanto più acquista in potenza e venustà.
Oggi noi assistiamo al curioso fenomeno di un poeta romano il quale esprime nel suo linguaggio romanesco sensazioni e, starei per dire, sentimenti schiettamente piemontesi.
Egli è Filippo Tartùfari.
Il gusto delle umane lettere gli discende per... li rami dalla tradizione familiare. All'amore della Poesia venne educato da quella nobilissima anima d'artista e di scrittrice che fu la madre sua: Clarice Tartùfari. La simpatia verso la nostra città, la nostra regione, la nostra gente, si andò mano a mano formando in lui durante i molti anni della sua dimora in Piemonte.
Filippo Tartùfari si riconobbe poeta dopo una grande sventura: la morte della Mamma. La fiamma della poesia, d'allora in poi, non si è più spenta nel suo cuore.
Studioso dei classici italiani e dei migliori poeti romaneschi, da Gioacchino Belli al Pascarella ed al Trilussa, egli condensa e fissa il suo fantasma poetico specialmente nella forma chiusa del sonetto: «breve ed amplissimo carme». La natura gli diede, squisitamente, il senso del ritmo e del metro, arricchito da una straordinaria facilità nel foggiare l'endecasillabo, tanto che di lui si potrebbe ripetere quello che di se stesso disse Ovidio nell'esametro famoso; Quidquid tentabam dicere versus erat.
....
Ora egli ha voluto affrontare, nei venti sonetti che seguono, un altissimo tema: Pietro Micca, argomento che finora nessun poeta piemontese dialettale osò compiutamente trattare.
La figura dell'Eroe biellese, nella sua semplicità scultoria, è così lineare e definita che vieta ogni lenocinio di forma, qualsiasi accorgimento rettorico e di più impone al poeta una potenza epica che fa tremare le vene e i polsi. Forse, perciò, anche i nostri migliori si sentirono impari al grande soggetto.
Filippo Tartùfari, invece, risolse il problema con una genialità spiccatamente romana. E come l'abbia risolto egli spiega in modo egregio nelle poche righe da lui anteposte al poemetto.
Noi piemontesi dobbiamo riconoscere a malincuore che, finora, il solo poeta in vernacolo che abbia cantato l'Eroe dell'Assedio di Torino con vivacità di accenti e con dignità d'arte è stato proprio lui:
Filippo Tartùfari, poeta romano, nel dialetto di Roma.
Gennaio XX Nino Costa
Ed ecco come, nei chiarimenti al lettore lo stesso Tartùfari ci narra della nascita di questa sua opera:
...Ed allora, sia per diminuire le grandi difficoltà, sia per non fare una cosa barbosa, preferii ritrarre di scorcio il Micca, inquadrandolo nella descrizione di una passeggiata sulla meravigliosa Collina di Superga piena di ricordi di quell'epoca. Introdussi il personaggio er Sor Totò, tipo di romano, colto, moderno e faceto, fervente ammiratore di Torino e nella novella rimata feci raccontare da lui al figlio Romoletto i punti salienti dell'assedio famoso.
...
Gennaio XX Filippo Tartùfari
Così Furio Fasolo, in un articolo pubblicato su L'Italiano - Gazzetta del Popolo della Sera del 27 febbraio 1943 dal titolo Torino d'oggi vista da un poeta romano descrive il lavoro del Tartùfari:
Le cose più carine e lusinghiere, e forse anche le più acute sul conto di Torino e dei torinesi sono state dette sempre da forestieri e da stranieri; giunti qui e colti dal fascino della nostra città, essi possono poi dare libera espressione al loro entusiasmo, non essendo trattenuti dal ritegno costituito dal timore (insopportabile in noi) di essere o apparire autoelogiativi.
E codesti giudizi - perché non confessarlo? - sono fonte di inesauribile compiacimento per noi torinesi.
Che Torino sia una città per cui si può fare una grande passione è ormai verità lapalissiana. I poeti poi non possono sottrarsi a questo misterioso fascino. Fra i molti esempi merita di essere citato quello di Filippo Tartùfari.
Tra parentesi, il caso è alquanto fuori del comune. Questo scrittore ormai noto e caro al pubblico in un suo scritto confessa che nello studiolo del suo negozio
quando gli affari battono la fiacca
me metto a sonettà dietro bottega;
er magone se scioje e me se slega
'na vena de poesia che mai se stracca.
Perché si tratta di una poeta che è al tempo stesso ingegnere e negoziante: Apollo, Minerva e Mercurio fusi insomma in società. Ma il paradosso appare meno sgargiante e sconcertante quando si sa che Tartùfari è figlio di Clarice Tartùfari.
Come egli senta Torino si può comprendere dalla lettura di un solo sonetto: Tramonto da Superga
Guarda: Cala la sera. Er celo piagne!
Ma Superga te fa n'improvvisata:
T'avvicina tarmente le montagne
Come Torino fosse lì appoggiata.
A poco a poco, giù pe' le campagne
Se fa scuro, ma ancora è illuminata
La punta der Monviso e le montagne
So' accese de 'na luce un po' sfumata.
Lontano da Torino che tristezza!
Tutto te sembra griggio, inconcrudente.
Che nostargia si penzi con dolcezza
A un ber visetto, a 'sti tramonti rosa!...
Quando ritorni a vive fra ' sta gente
Senti l'anima tua che s'ariposa!
E con quattro pennellate, ecco il ritratto dei torinesi ne Er piemontese:
Ch'er Piemontese, credi, fijo mio,
Ce l'ha quarche difetto: È biccerino,
È un bôgianen, je piace arquanto er vino
E cor foresto è sempre un po' restìo;
Ma di fronte ar dovere, caro mio,
Nun indietreggia mai e lotta insino
A la morte se questo è er su' destino.
Nun lo smove gnisuno, manco Dio.
Accussì Pietro Micca. Er su' dovere
Era difenne er passo. E lo difese!
Co' l'animo strazziato e cor penziere
Vidde er fijo, la moie sconsolata.
Strillò: «Pensate a la cratura!» Accese
La miccia e restò lì ne la fiammata!
Du' risate e un sospiro - Sonetti romaneschi
Fiorini - La Palatina 30 marzo 1946
Volume in 16° di pag. 160, 120 sonetti, una breve presentazione di Filippo Tartùfari, un dotto saggio di Giovanni Gargiulo Alcune considerazioni sull'ortografia e sull'ortoepia del dialetto romanesco e 16 disegni di Felice Vellan.
I sonetti datano dal 12/1/1942 al 30/7/1943.
Da Poche parole al lettore:
Questa pubblicazione rappresenta il mio primo tentativo per la realizzazione di un sogno che potrebbe essere soltanto presuntuoso, quello, cioè, di tramandare nel tempo una serie di quadretti che diano le sensazioni del nostro popolo durante l'epoca eccezionale nella quale il Destino ci fa vivere. Queste impressioni sono state da me raccolte con profonda attenzione, osservando uomini e cose, esaminando fatti e circostanze, e raccogliendo, ovunque, spontanee e naturali espressioni. ...
Ho volutamente scartato i sonetti di carattere politico, satirico, o drammatico, relativi agli ultimi periodi turbinosi della nostra vita nazionale, perché siamo ancora troppo vicini al ciclone che si è abbattuto sull'Italia per essere obbiettivi nei nostri giudizi. Questi sonetti faranno parte di altre pubblicazioni che ho intenzione di far seguire. Molti di essi, specialmente i satirici, andarono perduti in una perquisizione da me sofferta nel periodo repubblichino; ma di ciò non mi lamento, perché la satira è un'arma che si spunta nella ferita. ...
Ho prescelto la forma poetica del sonetto il breve ed amplissimo carme perché più adatto ad esprimere con rapidità i fatti che mi hanno impressionato, sorpreso o commosso.
Ringrazio l'amico fraterno Felice Vellan, pittore vivace, che ha voluto dare risalto ad alcuni miei sonetti con la sua magica matita.
Un sonetto della raccolta:
La bottega del fumo
Fra quele gabbie di Piazza Castello
c'è un bucetto a Torino, arinomato
pe' sigarette, sigari e trinciato,
pippe, bocchini e quarche giocarello.
Sto negozietto credi, è tanto bello!
Lustro, pulito, allegro e rassettato;
magari ce sarai, forse, pelato,
ma si lo fanno è in modo aggrazziatello.
Lì c'è Gina, famosa tabaccara
che 'r fumatore furbo se la deve
fassela amica e, poi, tenella cara.
Tié 'n visetto appuntito e sbarazzino,
cià li capelli bianchi come neve
co 'no sbuffo sfumato de turchino.
7/4/1942
Il negozietto della signora Gina si trovava sotto i portici di Piazza Castello in quei bugigattoli affettuosamente appellati le gabbie dai torinesi. Questi negozietti nacquero nel XVII secolo come baracche provvisorie per concessione del Marchese Ludovico San Martino d'Agliè in occasione delle due fiere che si tenevano a Torino, quella di carnevale e quella di maggio. Poco alla volta quelle baracchette occuparono sempre altri spazi sotto i portici, tra le colonne, finché nel 1832, con regie patenti, vennero riconosciute stabili. Come tutte le cose, nate provvisorie, in questa nostra Italia, eccole ancora qui oggi le gabbie da poco rimodernate per dare più lustro alla piazza per le Olimpiadi invernali del 2006.
Il sonetto dedicato alla signora Gina è stato ripreso dal Tartùfari con nuovo titolo La Gina de Piazza Castello nella raccolta Quadretti senza cornice del 1955 di cui mi occuperò più avanti. Le varianti sono parecchie pur senza modificare la fisionomia del testo. L'illustrazione di Vellan, qui sotto, proviene dalla raccolta del 1955.
Er cappio ar collo - Sonetti romaneschi
Petrini, Torino, senza data, ma 1947.
Volume in 16° di pag. 160. Contiene 104 sonetti datati dal 5/8/1943 al 30/12/1944, il saggio Scritti e forme della poesia romanesca di Vittorio Clemente, e un ritratto fotografico di Filippo Tartùfari.
I temi di questa seconda raccolta di sonetti in romanesco di Filippo Tartufari sono simili a quelli di Du' risate e un sospiro. Dato però il periodo abbracciato si affacciano poesie dedicate agli avvenimenti del 1943 Er cappio ar collo, L'armistizzio, alla guerra partigiana Er partiggiano, Partiggiani in montagna, Er bersajeretto partiggiano, Li partiggiani, La fucillazione.
Un sonetto è dedicato a Nino Costa.
A Nino Costa
Er Palazzo Madama di Torino
ne li tramonti a maggio, in quel chiarore,
pija un aspetto strano: cià er colore
d'un ber cesello antico d'oro fino.
E lì che la tu' rima, o caro Nino,
me commove deppiù, me parla ar core
e m'arilegra tale e quale ar fiore
che brilla de ruggiada ar mattutino.
Rivedo cor pensiero la collina,
er torrente che rùzzica dar monte,
la Consulà, le Steile, la Mamina.
E in quel dialetto tuo cusì marcato
sento 'sta razza forte del Piemonte
e l'arpino dar passo cadenzato.
Montagna mia
Casanova & C. Editori, Torino, 20 febbraio 1948.
Volume in 8° di pag. 48 con testo impresso, per le poesie, solamente al recto delle pagine.
Contiene 12 sonetti, dedica a stampa a Nino Costa, saggio di Vittorio Clemente Musa romanesca in montagna, 12 vignette tratte da incisioni di Felice Vellan più l'illustrazione in copertina.
Raccolta definita dalla rivista Torino "Una trovata originale".
La raccolta si apre con la dedica:
Alla cara memoria di NINO COSTA amico dilettissimo che con le sue belle liriche piemontesi rese più intenso il mio affetto per Torino e trasformò in poesia il mio amore per la montagna.
La campanella
Ar primo sole, co na voce fina
sono la sveja a tutta la vallata:
butto dal letto quarche regazzina
che se stiracchia mezza addormentata.
So ficcanasa e ciò na parlantina
che sturbo tutti! Da la chiacchierata
de le commare, so che stamattina
la pastorella bionna s'è sposata.
Guardate sta regazza co quer fiore:
ha detto ar padre che veniva giù
pe sentì messa, e invece fa l'amore.
La sera, sta qui sotto cor regazzo,
pareno appiccicati: da quassù
m'aggusto quela scena e me spupazzo.
La Tampa del Circolo degli Artisti di Torino
Casanova & C. Editori,Torino, settembre 1948
Volume in 8° di pag. 32, con testo impresso, per le poesie, solo al recto delle pagine. Otto poesie goliardico-conviviali in lingua, celebrative del torinese Circolo degli Artisti, composte ognuna da tre quartine più due versi in coda che, riuniti, vanno a comporre l'inno della Tampa, Cicalata proemiale di Arrigo Frusta, otto illustrazioni di Felice Vellan a guisa di testatine, più l'illustrazione in copertina.
La Cicalata del Frusta appare pari pari, escluso il paragrafo riguardante Tartùfari, sulla rivista Ij Brandé del 15 ottobre 1948 e verrà poi ripresa su Ij sent ane dël Cìrcol dj'Artista pubblicato da Ij Brandé nel 1951.
Due brani dalla Cicalata proemiale di Arrigo Frusta:
Più anni fa due bravi figlioli, che tornavano dalle trincee del Carso, con in gola il sogno anelante d'un piatto d'agnellotti, si dissero: - C'è qui, schiacciato tra il suolo del salone e le gran volte del pianterreno, un mezzanino di quattro stanze, ripiene di rottami di sedie e di salaccai polverosi. Nessuno ci caccia mai il naso. Perchè non leviamo i ragnateli, non diamo aria tutt'intorno, non pitturiamo muri e soffitti? E in cost'angolo non tiriamo su una gran cappa di camino? E in cotest'altro non fabbrichiamo una cassaforte, piena di bottiglie sigillate? L'Ellade, lo sai, glorificò il buon vino: è ghè melaina pinei... Così, cacciato via il buio, metteremo per tutto la luce e la gaiezza. E così nacque la Tampa degli artisti. ...
Ma io dimenticavo una cosa. Già, questa cicalata vuole un'appendice. E per questo effetto resta da dire che, oltre gli altri meriti grandi, la Tampa faceva accoglienza. Ci capitò un poeta romanesco, che aveva amore alla sua parlata e a Torino. Si crogiolò al foco, ammirò l'arguzia di Caio, apprezzò il barbera di Tizio, sgranò panini spalmati d'azzurro, ci provò gusto, non se n'andò più.
Non se n'andò più: sotto la gran cappa ruminò versi, rime e strofe. Poi certa sera diede fuori il canto conviviale della Tampa. Nella quale composizione, dabbene e saporita, dove scorre una fresca vena, lucente di festività, tre figure più specificamente risaltano sopra le altre, simbolo direi quasi, poetica interpretazione delle essenziali virtù della Tampa. E sono l'affetto fratellevole degli artisti, la tradizionale ospitalità torinese, l'amore che questi pittori hanno alle nostre belle montagne.
Dopo di ciò mi tiro in diparte.
Entri il poeta.
Nello storico quartiere
già dei nobili a Torino
sbocca ai Portici di Po
la tranquilla Via Bogino.
Nel Palazzo del Graneri,
bel gioiello del seicento,
c'è quel Circolo d'artisti,
fiore del Risorgimento.
Se tu vuoi goder la sera
fra gli artisti spensierati,
va nel Sabato alla "Tampa":
quattro stanze agli ammezzati.
Viva la "Tampa" dell'amicizia
dove l'artista vive in letizia.
E qui di fila gli altri distici finali:
Viva la "Tampa" del buonumore:
dei piemontesi cervello e cuore.
Viva la "Tampa" dell'allegria
esempio raro d'economia.
Viva la "Tampa" lieto convito,
dove la mancia diventa un mito.
Viva la "Tampa" dell'uomo colto:
si paga poco, si gode molto.
Viva la "Tampa" lieto ristoro,
viva l'artista, la Lupa e il Toro.
Viva la "Tampa" della montagna:
molto si beve, poco si magna.
Viva la "Tampa"! Viva il buon vino!
Viva gli artisti! Viva Torino!
Torino bella (Le Piazze)
Edizioni Rattero Torino, 1951.
Volume in 8° di pag. 48. Contiene 15 sonetti più uno Er Po e la Fiat con ulteriori tre versi a conclusione, Il pensiero d'un piemontese di Gigi Michelotti, Il giudizio di un romanista di Ceccarius e 15 disegni a piena pagina di Felice Vellan più uno di copertina.
Le piazze: Carignano, Castello, San Giovanni, Palazzo di Città, Porta Palazzo, Maria Ausiliatrice, Statuto, Savoia, Solferino, San Carlo, Carlo Felice, Cavour, Maria Teresa, Vittorio Veneto, Sabotino.
Così Gigi Michelotti da Il pensiero d'un piemontese:
... Le piazze sono ciò che ha di più bello Torino ed è di esse che, complice Felice Vellan, egli vuole disporre. E non contento di mirarle, rimirarle, di mettere in luce ciò che hanno di singolare, le scopre, le scruta, le interroga. le fa parlare e su ognuna dice la sua: qua una osservazione, là una arguzia, qui un richiamo, lì una impertinenza. E vuole che me ne compiaccia! Grossa pretesa e ne avrei dispetto se non dimostrasse con cosa, e mi prende, con la mente, il cuore che a Torino, la mia città, vuol bene quanto me; e certo di più di coloro che ci sono nati, ma non ne sono innamorati. E lui lo è, non meno di me. ... È un panorama, il panorama di una città, della mia città con le sue piazze, i suoi palazzi, le sue strade, i suoi uomini, la sua storia che mi si stende innanzi, e ne godo.
Torino, luglio 1951 Gigi Michelotti
La raccolta si apre con questa terzina:
Torino bella, chi l'ha vista un giorno
magara un giorno solo, ha un'impressione
che non la scorda più: sogna er ritorno.
Piazzetta Maria Teresa
La sera quanno er celo se scolora,
me fo na capatina a sta piazzetta:
è come s'incontrassi na vecchietta
co lo scuffiotto e li riccetti fora.
Adesso è decaduta e m'addolora
de vedella così, senza toletta:.
me guardo intorno e penso: "È poveretta,
ma cià quer nunsocchè de la signora".
Tante vorte seduto ner giardino,
rivivo l'anni mia de primavera,
poi m'arzo e dico come un regazzino:
"Cerea, nonnetta", e me ne vado via.
Lei pare che me risponna: "Quarche sera
viemme a trovà, se famo compagnia".
Un bottegaro poeta a Torino
Edizioni Rattero, Torino, 15 giugno 1952.
Volume in 16° di pag. 238 con prefazione di Angelo Pastore e un ritratto della madre Clarice Tartùfari con un sonetto a lei dedicato.
Il volume apre con queste parole del Tartùfari:
Pagine di vita vissuta che narrano la
mia avventura nel campo della poesia.
Di una vera e propria autobiografia trattasi. Il racconto è inframmezzato da una lunga serie di sonetti e rime sparse che ne arricchiscono il contenuto. Ne ho tratto un'infinità di notizie e riprodotto lunghi brani nella parte dedicata alla sua vita.
Rapsodia torinese
Indudtria dolciaria Ruggero & Tortia, Torino 1955.
Opuscolo in 8° oblungo di pag. 8 con 7 disegni in rosso del pittore Felice Vellan.
Piccole prose e cinque poesiole sulla città e sulla vita torinese arricchite dai disegni del pittore Felice Vellan. Opuscolo commissionato dall'Industria Dolciaria Ruggero & Tortia da utilizzarsi quale omaggio alla clientela.
Un breve accenno del contenuto di Rapsodia torinese:
La più centrale e moderna arteria di Torino, via Roma, nel primo tratto è come un filo di perle che congiunge due gemme: piazza Castello e piazza San Carlo. Di notte essa indossa una veste di gala, sfolgorante di luci, d'insegne al neon, si pavoneggia come una bella signora in «pompa magna». Forse il nostalgico torinese la troverà troppo moderna e forse un po' stridente, forse penserà che quell'abbacinante sfolgorio è come un foruncolo infiammato sul viso della
sua Torino vecchiotta in falpalà.
Ma via Roma è bella! È bella di giorno, di notte, quando è popolosa, quando è quasi deserta, quando il sole la indora o la luna l'inargenta, rendendo fantasmagorico «el Caval 'd Bronz». E quando si trasforma in una Mostra d'Arte, per la geniale iniziativa del pittore Giovanni Bussa, Presidente dell'Ente Provinciale del Piemonte, tutte le vetrine dei negozi dànno ospitalità a pitture, sculture, ceselli di qualsiasi tendenza. Tutta Torino accorre a discutere ad ammirare: è un avvenimento che rinnova quel periodo rinascimentale, quando popolo, artisti, compratori e mecenati, s'incontravano per i fondachi fiorentini.
Un gomitolo d'oro
Edizioni Rattero, Torino, 15 giugno 1955.
Volume in 16° di pag. 136 che contiene 3 sonetti e 82 poesie a metro libero con numero variabile di versi, un disegno di Felice Vellan raffigurante una monca statua a Roma ritenuta del Pasquino che si divertiva a mettere alla berlina i personaggi del suo tempo e alla quale i romani appendevano scritti denuncianti le malefatte del governo e dei potenti del tempo.
Questa raccolta di Tartùfari è introdotta da queste sue parole:
Il titolo del presente libro
e quello delle parti nelle quali
è divisa questa raccolta di versi
sono i titoli di alcuni
romanzi di mia Madre: Clarice Tartùfari
Le poesie hanno temi molto vari. In appendice 21 pasquinate, eccone un paio:
La pasquinata
La vera povesia
se forma dentro ar core;
nasce dar bonumore
e da la botta tipo romanesco.
Ma se la vòi pepata e de sapore
méttece dentro er vino
mischiato assieme cor peperoncino.
Er governo e le tasse
Marforio
C'è poco da rugà,
er cittadino è inutile che strilli
che le tasse le deve da pagà.
Pasquino
Quanno però son troppe viè la crisi:
er commercio e l'industrie vanno a male,
nascheno un mucchio de disoccupati
e fa cilecca pure er capitale.
Ma c'è di peggio assai, caro Marforio:
er Governo se becca li quattrini,
pe incompetenza se li spenne male
e se ne frega de li cittadini.
Nota. Sembrerebbe scritta oggi. Al penultimo verso oltre incompetenza bisognerebbe aggiungere malaffare.
Quadretti senza cornice
Edizioni Rattero Torino, 12 dicembre 1955.
Volume in 16° di pag. 192 con 104 sonetti, 24 disegni di Felice Vellan e la riproduzione di un sonetto manoscritto dedicato a Tartùfari da Nino Costa.
Il volume si apre con questa dichiarazione:
Nella distribuzione di questi miei sonetti mi sono attenuto a quello che scrisse a suo tempo il nostro gran poeta Gioacchino Belli in una sua prefazione:
... Distinti quadretti, e non fra loro congiunti aggiungeranno assai meglio al fine principale, salvando insieme i lettori dal tedio di una lettura troppo unita e monotona. Il mio è un volume da prendersi e lasciarsi come si fa de' sollazzi, senza bisogno di progressivo riordinamento d'idee. Ogni pagina è il principio del libro, ogni pagina è il fine.
Ed ora alcuni sonetti che Tartùfari ha dedicato a noti personaggi:
Govi
Allegro, bassottello de statura,
sgambetta e zompa come un ber grilletto
e senti in quela voce de farsetto,
una cadenza genovese pura.
Domeneddio j'ha dato p'avventura
un naso strano a forma de farcetto
che je fa ne l'assieme quel'aspetto
comico e origginale de natura.
St'attore tiè la botta ridanciana:
è spiritoso senza esse amaro
e quanno ride pare na campana.
Er su teatro è vivo, divertente,
è questa la raggione., frater caro,
perchè ce trovi sempre tanta gente.
Pare (al poeta Frusta)
Se chiama «Pare», ma Torino sa
che nun cià fiji, armeno apertamente.
Grosso, ma sverto, cor un gran da fa
dove er guadambio c'entra poco o gnente.
Scontroso, criticone, un po' saccente,
pieno de vita e de genialità,
su li «Brandè» racconta alegramente
quello che succedeva un tempo fa,
Se nato fosse a l'era mediovale,
a queli tempi de cavalleria,
quanno fra mazze, spade e martingale,
sopra li scudi se scopriva un motto,
quello che avrebbe scerto in fede mia,
sarebbe stato questo: «Me ne fotto».
Macario
Vorpe fina, ma bon piemontesone
d'una statura piuttosto bassetta,
s'avanza con na certa pretenzione
d'esse venuto su da la gavetta.
È un comico impresario e maneggione
su le scene gesticola, sgambetta,
s'impunta apposta come un tartajone,
fa du sberleffi assieme a la mossetta.
Che festa quanno viè sopra le scene,
ridi, sbatti le mano, li ginocchi
te score l'alegria dentro le vene.
Se l'incontro e se mette a ricordà
la pòra Mamma sua, vedo in quell'occhi
na lagrima e lo sento sospirà.
Un pittore de la tampa (al pittore Felice Vellan)
Capelli ar vento, viso ridanciano,
che t'aricorda con quer sorrisetto
la penna de l'arpino valdostano
e li pennacchi de barzajettiero.
St'amico è sempre pronto a dà na mano
a chi je serve: è naturale, schietto,
come quer vino gajardo, nostrano
che dà l'estro e a l'artista core in petto.
Su la faccia abbronzata e montanara
de sto pittore, ce vedi scherzà
no sguardo che sbrilluccica e s'affiara.
Ne le pitture sue, la neve, er monte,
e prati e fiori fanno ripensà
a le fresche vallate dei Piemonte.
Un artista carozziere (al comm. Pinin Farina)
Una bella criniera griggio-argento,
no sguardo fino pieno d'espressione,
piccolotto, occhialuto, robbustone,
sportivo, bocciatore e cor contento.
È un «bojanen» de quelli in movimento;
all'estero tiè arto er gonfalone
de l'industria italiana; in concrusione
è farina nostrana, è bon frumento!
Quanno se parla de carozzeria
corre er pensiero a sto lavoratore,
che s'è fatto da se, senza arbaggia.
E i n quelo sguardo franco e ridarello,
ce leggi er compagnone tutto core
er nonnetto, l'amico, er bon fratello.
Torino in romanesco (impressioni)
Edizioni Rattero, Torino. Senza data ma 1956.
Volume in 8° di pag. 50 con 16 sonetti e una poesia composta da sei quartine, 16 disegni di Felice Vellan a piena pagina più uno, in copertina, due terzine di Nino Costa (le due del sonetto che apre Quadretti senza cornice), la prefazione Il pensiero di un poeta romanesco di Vittorio Clemente.
Questa raccolta è nella veste e nell'iconografia del tutto analoga a Torino bella e ne rappresenta il complemento. Lasciate le piazze ecco il Teatro Carignano, Via Roma, Via Garibaldi, la Consolata, lo zoo di Parco Michelotti, il Monte dei Capuccini, Superga, il Salone dell'Automobile, il Po, Torino, la collina, il Parco di Cavoretto.
In antiporta la dedica:
A Pina
compagna nel viaggio della vita.
Piazza Vittorio a carnovale
Strilli, cagnare, tromme, imbonitori,
"du lire al bicchio", "guarda che torrone!"
un miscujo de soni e de colori,
du coccodrilli a mollo in un cassone.
Sartimbanchi, pajacci, scimmie, mori,
le giostre, un nano, la donna cannone,
li studenti, le "tote" arubbacori,
li sordati e qua e là, quarche servone.
Gianduja e Giacometta impimpinita
se fanno un ballo. Annamo gente mia,
scordamo qui l'affanni de la vita!
Forse domani scade la cambiale,
ma per oggi vivemo in alegria.
Viva Piazza Vittorio a carnovale!
Piemontèis ancheuj 8 puntate successive tra Ann XXXIII N° 10 Otober 2015 ~ Ann XXXIV N° 6 giugn 2016
Nino Costa
Torino 28 giugno 1886 ~ 5 novembre 1945
Nino Costa. Settant'anni dalla morte prematura del maestro di poesia per alcune generazioni di poeti piemontesi. Tracciarne un ritratto che percorra la sua vita di uomo e di poeta è impresa che richiederebbe tempi e spazi che, oggi, non ho disponiibili.
Mi limiterò pertanto ad alcuni episodi tra gli anni '20 e gli anni '40 per poi dedicarmi con maggiore attenzione alla sua vita, alla sua poesia, tra il 1943 ed il 1945.
Ma una data mi preme di sottolineare subito: 16 agosto 1944. Muore il figlio Mario combattendo da partigiano sul Monte Génévry (Pragelato, Val Chisone) contro i nazi-fascisti. Il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi consegna ai parenti la laurea ad honorem alla memoria nel giorno anniversario della morte del padre Nino, con la seguente motivazione: …caduto sul monte Génévry mentre da solo, per aprire la via di salvezza ai compagni accerchiati si lanciava all’assalto di un fortino tenuto dai nazi-fascisti. Nino non si riprende più dal colpo infertogli dall'atroce notizia. Nel gennaio successivo viene colpito da infarto che lo accompagnerà, passo passo, al 5 novembre, giorno in cui si ricongiungerà all'amato Mario e alla cara moglie Ercolina che di lì a poco lo seguirà. Rimarrà a tenerne vivo il ricordo la figlia Celestina che, da pochi anni, anch'essa, è andata a raggiungere i suoi cari.
Costa: i suoi primi versi - Na mamina
I primi versi di Costa appaiono il 23 dicembre del 1909 su 'L birichin - Giôrnal Piemônteis con la poesia Macetta 'd Natal e la firma Na mamina.
Questo pseudonimo Costa lo utilizza per parecchi anni, a volte solo Mamina, a volte le iniziali N M per poi giungere a N C ed infine al suo nome per esteso. Collaborerà con il giornale torinese fino alla sua cessazione avvenuta nel 1926. Nino raccoglierà poi parte delle poesie pubblicate su 'L birichin, ne aggiungerà di nuove e, per i tipi della Lattes, darà alle stampe, nel 1922, Mamina - Poesie piemontesi.
...Prima 'ncôra 'd fiôrì, ti 't ses passìa è la frase riportata in testa al frontespizio e, da sola, ci rivela la genesi di Mamina. Costa si mette nei panni di una giovane diventata mamma troppo presto e lasciata troppo sola. Narra le sue vicissitudini, le sue ansie e timori, ma, soprattutto, la sua voglia di redenzione da ottenersi con le cure e l'amore che riversa sulla figlia.
Annunciando l'uscita di Mamina 'L birichin dichiara: ...contrariament a tanti d'autri, anvece d'esse la racòlta 'd poesie già staite publicà, 'l volum a l'é na vera stòria d'na fija che, disgrassiatament diventà mare, a cerca la redenssion ant soa citina dësmentiand così ël mond e le soe malvagità.
Direttore e redattori del giornale ed il pubblico saranno a lungo convinti che le poesie siano dettate proprio da una mamma. Divertente l'episodio che svelerà la vera natura dell'autore. Dalle parole di Mario Albano (poeta de Ij Brandé e caro amico di Nino) pubblicate su Ij Brandé N° 114 del primo giugno del 1951, leggiamo come si svolse la presentazione ufficiale di Na mamina al direttore de 'L birichin Paggio Fernando (Ferdinando Viale) che inizia con la storia della pubblicazionie dei sonetti, della curiosità che l'anonima Mamina aveva suscitato e le pressanti richieste di rivelarne il nome:
E l'incògnita, mandand soe poesie, a rëspondia sempre ch'a la lasseisso an pas, che, dòp tut lòn ch'a l'avia passà, dòp tante disilusion a vivìa mach pi për soa creatura e che dël mond j na fasìa pi gnente.
Tuta costa manera 'd comportesse, anvece dë sfreidé la combricola birichinòira, a la scaudava ancora 'd pì, e an sel pcit coré l'insistenssa ass fasia sempre pi viva. La tiritela a l'é andaita anans parèj per pi d'un ann. Finalment, vista tanta insistenssa e dcò un pò për compassion, la misteriosa Mamin-a a l'avìa cedù, fissand n'apontament a la diression dël Biri.
Con soa barba faita 'd fresch e tut bin tiflà për l'ocasion, ël diretor a l'ora giusta a l'é trovasse pontual a spetela. Da lì a un pòch dë dnans chiel, ecco ch'ass presenta n'òm nen tant grand dë statura, con na caviera bionda pitòst raira, doi eui color dël cel, che, tranquilament, con bela grassia, ai dis: «Mi son Mamina!» E a l'era Costa.
Tablò! Col ch'a spetava a l'ha fait n'arssaut, a l'é quasi mancaje 'l fià për la sorpreisa. A la fin son presentasse, e a l'han profità dla bela ocasion për fè conossensa.
Costa a l'ha rijù 'd cheur, l'autr a l'avrà fait l'istess, ma forsse nen con tanta gòj, përchè dòp tut, a j'è poch da dije, a l'era stait bin giugà.
E parej a son dventà amis, ma Costa, an confidenssa, a l'ha dime ch'a l'ha mai përdonajla.
In anni recenti ho conosciuto un collezionista di Margarita (CN) che da parenti di Luigi Olivero ha acquistato molte carte a lui appartenute. Tra queste un piccolo fondo che ad Olivero aveva donato Tito Gantesi, al secolo Tommaso Agostinetti, poeta, saggista, giornalista, ma in particolare uno dei principali bibliofili che il Piemonte abbia avuto. Tra queste carte una poesia inedita di Nino Costa firmata Na mamina in cui la giovane mamma immagina un incontro con il grande poeta piemontese di Castelnuovo Calcea, Angelo Brofferio. Questa poesia, insieme alla sua genesi, l'ho riportata integralmente su questa rivista con il titolo Una poesia inedita(?) di Nino Costa nel N° 5 del maggio 2012.
Costa, Pacòt e Ij Brandé
A proposito della richiesta di Pinin Pacòt a Nino Costa di collaborazione per l'Armanach piemontèis 1937 e del rifiuto di Costa con le prese di posizione di Pacòt che ne seguirono, ho già scritto su questa rivista nella decima puntata di Pinin Pacòt tra poesia, prosa ed editoria dal 1926 al 1938 apparso su Piemontèis ancheuj Ann XXXIII N° 1 Gené 2015. Per non ripetermi, rimando pertanto al numero di gennaio di questa rivista chi volesse saperne di più sul dissidio tra Costa e Pacòt.
Nino Costa ed il teatro piemontese
Nel 1930 l'autore di teatro Onorato Castellino, con buon fiuto, invita Costa a collaborare con lui nella stesura della commedia musicale Rondolin-a personera. Costa accetta di buon grado e ne compone tutte le canzoni che saranno messe in musica dal M° Carlo Emanuele Croce. La commedia fu molto gradita dal pubblico e vinse anche il concorso teatrale indetto per la stagione 1930-1931 dal Dopolavoro Provinciale di Torino.
Primi interpreti a teatro furono:
La Marchesa de Villeneuve dei Conti Priocca Italia Brusasco
Jacqueline (sua figlia) Maria Luisa Filippi
Il Barone d'Isola Rinaldo Rondolino
Margritin Anna Roberti
Lafleur Carlo Vaudano
Tromlin Enrico Cancelli
L'opera verrà poi stampata dalla S.E.L.P. Studio Librario Editoriale Piemontese di Andrea Viglongo il 31 marzo del 1931 come primo volume della collana Teatro Dialettale Moderno ~ Serie Piemontese.
Nella prefazione di Onorato Castellino si legge:
All'Editore che mi chiese il parere su questa originale raccolta di produzioni dialettali italiane contemporanee, non assicurai per compenso un grande successo di vendita: sarebbe stata una ingenuità colpevole o una sciocca presunzione. Del resto, egli è troppo intelligente e generoso per aspettarsela senz'altro. Tuttavia sono assai lieto di aver contribuito a scegliere o consigliare il novissimo repertorio, incominciando intanto con questa «Rondolina personera» che egli stesso chiedeva, e mi congratulai vivamente con il suo entusiasmo fattivo e con la sua audacia del rischio. Uno di più. Un fedele, un neofita di più davanti alla stella stellina del teatro dialettale piemontese. Perchè, si, non siamo mica un esercito a volere che la nostra scena riviva, e più d'uno, o stanco o sfiduciato, è tornato indietro dalla strada maestra oppure s'è buttato alle traverse: cosicchè, ogni passo con che faticosamente si riesce a progredire è una gioia e una vittoria.
L'amico fraterno di Nino, Italo Mario Angeloni, buon poeta ligure, tre anni dopo la sua morte raccoglie, nel 1949, in un libro, «Nino Costa le pì bèle poesìe» ormai molto raro, una sua scelta delle poesie di Costa tratte dalle sue sei raccolte. Oltre ad una accurata prefazione-ricordo dell'amico, in coda al volume Angeloni aggiunge il paragrafo Nino Costa ed il folklore. Qui Italo Mario raccorda tutte le canzoni scritte da Costa con il riassunto del tema della commedia. L'Angeloni mi perdonerà se ai suoi scritti aggiungerò, sempre tratti dalla commedia, qualche altro brano di Castellino per migliorarne la comprensione della trama. Ed ecco quindi Rondolin-a personera.
ATTO I
Un grande salone nel castello della Marchesa de Villeneuve Priocca, nel territorio di Mongardino, correndo l'anno 1798, il 24 dicembre. Il Marchese de Villeneuve è stato ghigliottinato a Parigi, e la vedova, nata dei Priocca, che aveva fatto a tempo ad emigrare, vive ritirata da cinque anni nel castello dei suoi avi, unico bene del suo patrimonio e della dote che le sia rimasto. Ha una figlia, Jacqueline, delicata creatura sulla soglia dei venti anni. La Marchesa e la Marchesina sanno, ma non si rendono conto della gravità, che venendo in Piemonte dalla Francia sono cadute dalla padella nella brace: la Repubblica Francese, e per essa il suo rappresentante a Torino, il Ginguenè e poi l'Eymar. pur di dare noie e avere pretesti contro il Governo del debole Carlo Emanuele IV, insiste perchè gli emigrati siano rimandati in Francia. Per di più, come francesi, bande armate avevano l'impunità nel depredarli o ammazzarli. La marchesa ha poi il torto di chiamarsi dei Priocca omonima e parente del Primo Ministro del Re, quel magnifico galantuomo che fu il capro espiatorio di tutte le subdole manovre francesi, approdate alla caduta della monarchia.
È dunque la vigilia di Natale, e la marchesa ha, di passaggio, in visita, la sua vecchia amica, la contessa di Mombercelli, e per l'occasione ha chiamato presso di sè dal paese d'Isola, distante un'ora di cammino, il barone d'Isola, col quale essa pensa che la figliuola potrebbe unirsi in nozze tranquille e convenienti. Il barone d'Isola non è un'aquila, ma una sistemazione in questi momenti burrascosi rappresenta per lo meno un approdo. La figliuola sa e non sa. Essa si leva da una malattia per cui è stato necessario far venire da Isola il dottor Ferrero, passando sopra ai pregiudizi che dividono i nobili soprattutto dai partigiani delle nuove idee repubblicane.
Bisognava far festa alla cara convalescente e la si è accontentata nel suo desiderio di celebrare il Natale con la costumanza piemontese del Presepio. Infatti, nel salone è stato approntato in un angolo il Presepio. Margritin, la creada, Lafleur, il cocchiere, giardiniere e domestico e Cichina e Roseta, due villanelle, sono affaccendati negli ultimi preparativi.
All'ambiente piemontese, in sul finire del tragico 1798, ai casi d'amore della fragile Jacqueline, proprio nel Monferrato di Nino Costa, occorreva questa pennellata di colore locale, questo nesso di ritmi folkloristici che il Poeta, fedele al suo popolo, trovò facilmente in fondo al cuore ed in punta di penna.
Il primo di tali componimenti mèlici è una Pastorale, a due voci, in distici, a rime tronche, alternati dal corale simile alle strofe ed antistrofe della scena greca. È inserita nel quadro natalizio del Presepe, allestito a Mongardino, nel castello dei De Villeneuve-Priocca, perchè la signora marchesa madre vuole festeggiare insieme la sacra ricorrenza e la guarigione della sua Jacqueline.
PASTORAL
Questa composizione a dialogo, come gli antichi canti amebei, comporta una sua rudimentale drammatizzazione. O sei, od otto o dieci che siano i componenti del coro, essi si dividono in due schiere e procedono dal fondo fino all'altezza del Presepio: giunti alla parte corale, si volgono verso il Presepio e cantano avendo le mani giunte. Per la seconda parte, compiono una evoluzione, prima all'indietro e poi verso il davanti, e cantano la seconda volta il coro inginocchiati.
I
PRIMA VOS - J'é 'nt ël cel na steila neuva
ch'a sbaluca dë splendor
SECON. VOS - Ven porté la bona neuva
ch'a l'è naje 'l Salvator.
PRIMA VOS - Coi pastor per brich e pian-a
dova mai son-ne 'n camin?
SECON. VOS - Van cercanda la caban-a
la caban-a dël Bambin.
PRIMA VOS - Col ciairin an lontanansa
ch'a tramola sota 'l vent?
SECON. VOS - L'è 'l ciairin ëd la speranssa
l'è 'l sospir dla pòvra gent.
PRIMA VOS - Passa 'l vent an mes dle piante
con na gran cansson d'amor.
SECON. VOS - A son j'Angei ch'a la canto
per la nassita 'd Nossgnor.
La capocoro ha preceduto le compagne alzando una stella cometa tutta d'oro. Al momento del coro la tende e la innalza verso il Presepio:
CORO - Gesù bel,
Re del Cel,
ch'it ses fate nòstr fratel,
dòp l'afan ëd tanta guèra
pòrta pas a nòstra tera.
Gesà bel,
Re del Cel,
ch'i 't ses fate nòstr fratel,
't lo ciamoma an ginojon,
dane un pò 'd consolassion.
II
PRIMA VOS - Col ninin cogià 'nt la cuna
bianch e ross come na fior?
SECON. VOS - S'a l'è 'l Re 'd nòstra fortuna
s'a l'è fieul dël Creator.
PRIMA VOS - Cola santa ch'a lo vija
ch'a lo basa pian pianin?
SECON. VOS - L'è la Vergine Maria
l'è la mama del Bambin.
PRIMA VOS - Col ciairin an lontananssa
l'è dventà un brasé lusent.
SECON. VOS - L'è la fiama dla speransa
l'è 'l confòrt dla pòvra gent.
PRIMA VOS - Passa 'l vent an mes dle piante
con na gran cansson d'amor.
SECON. VOS - A son j'Angei ch'a la canto
për la nassita 'd Nossgnor.
La capocoro, memtre le altre s'inginocchiano, voltata verso di esse, alza quasi a segno di benedizione la stella d'oro.
CORO - Gesù bel,
Re del Cel,
ch'it ses fate nòstr fratel,
dòp l'afan ëd tanta guèra
pòrta pas a nòstra tera.
Gesà bel,
Re del Cel,
ch'i 't ses fate nòstr fratel,
tlo ciamoma an ginojon,
dane un pò 'd consolassion.
Segue nella sesta scena, del primo atto, la canzoncina, con cui il barone d'Isola, futuro sposo di Jacqueline, ricostruisce la salace avventura del conte Fleury e del gaglioffo suo servo. Sono quartine di ottonari piani e tronchi, alterni:
'L TONI DEL CONT FLEURY
Na contëssa un pò anssianòta
l'à sposà 'l contin Fleurì.
Chiel l'è fresch parèj 'd na tòta
chila a l'era 'n bon partì.
La Contëssa a l'è gelosa
lë sposin a fà 'l galèt.
Chiel và 'n cerca dla morosa,
chila ai pronta ìl trabucètt.
Vate scotè darè dla pòrta
se lë spos a deurm dabon;
e 'l rumor a la confòrta
perchè a ronfa come 'l tron.
Ma 'l contin ch'a l'è un disbela,
l'è rangiasse sò tran tran;
quand ch'a fa quaich marminela,
fa vnì a deurme sò traban.
Na matin për dësvielo,
chila aj fa un basin d'amor;
quand ch'a sta per ambrasselo
a dëscheurv 'l servitor.
Birichin senssa creanssa,
còsa fasto bele sì?
Ch'am perdon-a la mancanssa,
ten-o 'l post dël cont Fleurì.
Giunti alla scensa settima, assistiamo all'esecuzione della gajarda antica aria di danza, cui Jacqueline aggiunge la romanza che commenta il titolo della commedia e preludia alla fuga dal castello; oramai la rivoluzione sale anche a Mongardino. Il componimento è ritmato da quartine e terzine ottonarie a chiusa tronca.
LA RONDOLINA
Rondanina perzonera
pì nen veuja 'd fesse 'l nì.
Còsa vallo primavera
se me spos a l'è partì?
S'a l'è andait a la ventura
per i brich e la pianura
compagnà dai mè sagrin?
Mi lo speto d'an sla trassa
tuti i dì con mal al cheur;
a la nìvola ch'a passa
vad contand i me maleur.
Bela nìvola ch'it vòle,
vaje a dì le mie paròle,
va parteje i me basin.
Rondanina stembrina,
ch'it na vas de dlà dël mar,
se l'amor ch'a me sagrina
tlo 'ncontreisse për asar,
O disje 'n pò ch'a torna,
O disje 'n pò ch'a torna,
che mi ij veuj tanta bin.
ATTO II
La scena è nella piazza maggiore di Isola, a un'ora di cammino da Mongardino, cioè nel paese, di cui, come sappiamo, è dottore il Ferrero e dove Margritin ha la zia ostessa.
È passato quasi un mese dagli eventi narrati nel primo atto, e siamo precisamente nel pieno dell'infuriare della Rivoluzione Piemontese, nel momento in cui l'annessione alla Francia provocò i più pazzi disordini a favore della così detta libertà. Moti grotteschi, a considerarli a distanza, nei queli però molti nobili trovarono la morte, e sì aggravarono le miserie del popolo piemontese, ponendo i fermenti di quella reazione che doveva scoppiare di lì a sei mesi coll'avvento degli Austriaci condotti da Souvarow.
La Marchesa de Villeneuve è fuggita dal suo castello con la figlia, Tromlin si è arruolato; Margritin è venuta a Isola ad assistere sua zia l'ostessa e ad aspettarne l'eredità; il Barone d'Isola ha lasciato come d'obbligo il suo titolo gentilizio, ed ha accettato, bongrè malgrè, di far parte della Municipalità del suo paese, di cui il dottor Ferrero è presidente. Lo consigliò il naturale istinto della incolumità personale, e un poco l'amore. È segno che le de Villeneuve non sono distanti. Lafleur si è messo anche lui a fare un mestiere, quello che era più consentaneo alle sue abitudini. e l'ha cercato nella regione, in modo da non essere lontano dai suoi amici.
Carattere lirico settecentesco riveste, invece, la mattinata Obada inserita a metà della scena prima, del secondo atto. Siamo a Isola, la terra feudale del pretendente di Jacqueline; quivi si sono rifugiate la marchesa e la figliola; anche la servitù ha mutato mestiere. Il giovane Tromlin ha rinunciato al suo posto di sagrestano di S. Rocco e s'è fatto tamburino nella masnada del brigante Maino della Spinetta; giunge ad Isola, all'albergo del «Caval Gris», dove si occultano le fuggitive ed intòna la sua brava Obada in onore della diletta Margritin cameriera di casa De Villeneuve e nipote dell'ostessa. La canzoncina corre vivacissima sulla trama di quadrisillabi e settenari tronchi:
OBADA
Giòia mia
per l'anvìa
d'ambrassete 'n sël lobiòtt
mi daria
na tarina
na tarina d'agnolòtt.
O Margrita
dla mia vita
për un sol d'ij tò basin
mi daria
na marmita
na marmita 'd tajarin.
O Margrita
dla mia vita,
venme duna a fè 'n basin.
S'i të speto
s'it regreto
sai pì nen fè 'l tambornin.
Quand ch'it vëddo
con tò ghëddo
trafighè tacà 'l fornel,
mi me smija
ch'am gatia
'na furmìa 'nt ël sërvel!
S'it arsente
s'it masente
s'it ciapote 'nt ij paireuj,
mi friciolo
mi tramolo
mi vad tut an breu 'd faseuj,
O Margrita
d'la mia vita,
venme, duna, a fè 'n basin.
S'i të speto
s'it regreto
sai pì nen fè 'l tambornin.
La scena terza dell'atto secondo è tutta illeggiadrita dal duetto fra Margritin e Lafleur lo spodestato cocchiere divenuto postiglione della repubblica; la forma del duetto è una polimetria metrica:
LAFLEUR - Ai riva 'l postion,
ch'a pòrta 'l pompon
per tuti i canton!
Colett a feston,
stivaj e trombon
e un cheur da leon!
Valett e padron,
për fè 'd comission
mi valo 'n milion.
Olà dla locanda,
j'è 'd gent ch'a comanda!
MARGRITIN (Che è uscita di corsa dall'osteria)
Padron riverì,
ch'a resto servì.
LAFLEUR (Presentando un cittadino elegantemente vestito,
il quale guarda coll'occhialetto l'albergatrice e
alle sue offerte risponderà con qualche segno
disdegnoso, finchè non gli viene offerto quello
che desidera)
'L citoyen - veul mangè ben
ai va 'n menù da tranta scù!
MARGRITIN Trifole raire - trote dle giaire
fruta sernua - ròst e capon
na saladina - na geladina
con la fondua - e 'l sambajon.
Padron riverì
ch'a resta servì!
LAFLEUR (presenta ora due sposini i quali reagiscono
timidamente, guardandosi e mostrando una
conveniente soddisfazione).
Ai va në stansin - per costi sposin.
Servije, cudije, tratemie dabin!
MARGRITIN 'Na salëtta - na stansiëtta
con la porta an sël ripian
la dormeusa - la vijeusa,
l'aqua cauda e 'l suvaman
Padron riverì
ch'a resto servì!
LAFELUR (presenta da ultimo un vecchietto, il quale
appare subito molto malandato. Quando si
muove ha bisogno di essere sostenuto.
Sorride intorno tenero e un po' malizioso).
Al vejòtt - malaviòtt
stanssa cauda e bon decott!
MARGRITIN La papëtta - la cotlëtta
la traponta e 'l cuverpiè
camomila, ch'a dëstila
e la cruche al fond d'i pe.
Padron riverì
ch'a resta servì!
LAFELUR Adess che 'l servissi - l'è fait con giudissi,
porteje a'l postjon - na pinta 'd vin bon.
Giunti alla scena decima Tromlin ci regala da buon tamburino repubblicano la Tambornada sottolineata dal coro villereccio della folla raccolta intorno all'albero della libertà, sulla piazza di Isola. Metro fuggevole di quinari tronchi e distici ottonari, pur essi tronchi.
LA TAMBORNADA
TROMLIN (Questa volta entra avendo a tracolla il suo strumento, e lo fa rullare, venendo poi a salire sopra un piccolo sgabello che sarà collocato in mezzo alla scena).
TROMLIN Mi vad d'antorn,
con me tamborn,
sonand dë 'd sà
sonand dë 'd là
le volontà d'j'autorità.
Mi vad da sol,
con pieuva e sol,
per le borgià,
per le sità
portand an gir le novità.
REFRAIN (in coro) Tamborn 'd sà - tamborn 'd là.
Viva 'l tamborn dla libertà.
TROMLIN Mè rataplan
republican
s'a l'è sforsà
'd fè la ciamà
veul pà tradì la verità.
Son sempre pront
per me Piemont
e s'ai rivrà
nòstra giornà
l'è 'l me tamborn ch'av desvijrà!
REFRAIN (in coro) Tamborn 'd sà - tamborn 'd là.
Viva 'l tamborn dla libertà.
La penultima scena dell'atto si risolve con una melanconica trovata di strofette settenarie con quinari di chiusa tronchi. È imitazione di un Addio che troviamo un po' in tutti gli antichi dialetti dal Piemonte alla Sicilia e che il nostro Poeta ha amabilmente rinverdito, affidando al canto ed all'angoscia della fuggitiva Jacqueline:
L'ADIÙ
JACQUELINE Adiù, me vej castel,
cuna d'i me penssè,
ch'i tl'às vedù passè
me temp pì bel.
Adiù mia gioventù,
speranse del me cheur.
Adiù mè sol bonheur,
ch'i l'hai perdù.
Mi vad contra 'd dolor,
travers a le passion,
e i lasso 'ntl'abandon
mè seugn d'amor.
ATTO III
Nel terzo atto molte cose sono mutate. Siamo al 1810; con la vicenda napoleonica anche la marchesa De Villeneuve-Priocca è tornata in possesso del castello di Mongardino e la buona Jacqueline sposerà il barone d'Isola, trasformatosi anche lui con i tempi e divenuto «maire» di Isola. Canti napoleonici sono alla moda; nella terza scena ritroviamo Tromlin diventato sergente dei Cacciatori e quindi pronto a regalarci la sua brava arietta, seguito dal coro:
'L SOLDÀ 'D NAPOLEON
TROMLIN (attacca e gli altri con lui)
Napoleon
pronta ij canon,
manda a l'assaot i batajon.
Al bataclan
d'ij rataplan
marcioma, fieuj, contra j'Alman.
Dë 'd sà, dë 'd là,
per le contrà,
rimbòmba 'l son dle canonà.
E 'ntlë splendor
d'ij tre color
passo ij soldà dl'Imperator.
Ci s'avvia verso la conclusione e non può mancare il canto del ritorno che drammaturgo e poeta affidano ad un garbato duettino fra Tromlin e la sua ritrovata Margritin; è una gustosa contaminazione di lingua e dialetto, giocata con labili novenari ed ottonari:
IL RITORNO DALLA GUERRA
TROMLIN Quand ch'i torna dalla battaglia
con la spada, l'è 'nsanguinata.
Se ti tròvo - già maritata,
oh! che pena - oh, che dolor!
MARGRITIN Oh, che pena! oh che dolore!
che bruta bestia l'è mai l'amore.
Mi voglio fare - la monigheta
se 'l mio amore - non torna più.
A DUE Mentre adess ch'a l'è tornà,
ij daroma 'na mariolà. (bis)
Finalmente, passata è la tempesta, le nozze, come in tutte le commedie a lieto fine, possono coronare l'avventura di Jacqueline; il Poeta le dedica un coro di popolare originalità; siamo ai confetti nuziali, ovvero a:
LE GIURAJE
Entrati, le ragazze e i giovinotti, tutti vestiti a festa, chi con rami fioriti e chi con cestini, si sono disposti da una parte e dall'altra della scena, e accompagneranno il canto secondo sarà indicato dal direttore di scena.
CORO Per j'ampromësse d'j'annamorà
soma 'ndait cheuje le fior dij prà;
le nòstre cite l'han bin portà
le margherite.
Per fè j'auguri del bon umor,
soma 'ndait cheuje i pomin d'amor;
l'oma gropaje con j'autre fior
per le giuraje.
REFRAIN
Ohilì... ohilà... jë spos!
Nossgnor ch'aj daga 'd bin,
ch'ai guerna dai sagrin,
ch'ai fassa 'ndè giojos
fin a la fin del sò camin!
MARCHESA - Passoma 'nt'l salon ch'a peulo disponse 'd mei.
MARGRITIN - Dop l'aotra stròfa. Sìssgnora, marchesa.
CORO Perchè jë spos as voreisso bin,
soma 'ndait cheuje nt'i nòstr giardin,
për j'ore dosse del sò destin,
le reuse rosse.
Bela sposina, bochin fiorì,
bianca colomba del sò marì,
l'oma prontaje per fesse 'l nì,
dontrè buscaje.
REFRAIN
Ohilì... ohilà... jë spos!
Nossgnor ch'ai daga 'd bin...
ch'ai guerna dai sagrin,
ch'ai fassa andè giojos
fin a la fin del sò camin!
Non resta che un bel congedo in cui le voci di Tromlin e Margritin fanno un poco la morale al pubblico e si licenziano con strofette serene in cui vibra veramente tutta l'anima del Piemonte:
CONGEDO
TROMLIN L'è costa, Margrita,
la stòria dla vita.
MARGRITIN Seren e tempesta...
Dë 'd sà, j'è na festa...
TROMLIN Dë 'd là, j'è un magon.
Ma còsa ch'ai resta
dla pena? dla festa?
Dop tante passion?
MARGRITIN Na bela cansson.
TROMLIN Da giovnòt con tuta l'anima
l'han cantala i nòstri vej.
MARGRITIN L'è volà parèi dla rondola
sle cassine e s'ij castej.
TROMLIN E noj'autri ch'i cercoma
de slarghesse j'orizont
A DUE n'autra vòlta i la cantoma
per la glòria dël Piemont.
CANSSON FINAL
Nel momento della messa in scena si vedrà se sarà più opportuno questa canzone cantarla o recitarla.
I DUE 'Na cansson dl nòstra tera
'na cansson dël nòstr pais
ch'a l'à dane 'n pas e 'n guera
la carëssa d'un soris.
Passa 'l temp con soa faussia
passa l'òm con sò malheur
ma l'antica poesia
resta sempre 'n fond 'l cheur
CALA LA TELA
NOTA La grafia di Rondolina personera è quella originale dell'edizione S.E.L.P. del 1931.
Tre lettere di Nino Costa a Luigi Olivero
19 giugno 1941
L’hai risevù ier seira toe doe bele poesìe a la memòria ‘d te ami j alpin. Grassie.
Dë sti temp at suced spiritualment a ti lòn ch’am suced a mi, materialment.
It tramude. It cambie l’alogg dla poesìa. Dì sì n’ann ò doi i tl’avras sernuje a tua Musa piemonteisa n’alogg bin pi seren da col d’adess – ma a sarà l’alògg definitiv e i tlo cambieraj pì nen per tuta la vita. Sarà to indiriss – toa marca – tò stil. As dirà: Olivero – come ‘ncheuj as dis Costa – sensa pericòl ëd confondse. Ti magara adess i tn’ancorse nen, ma a l’é parej. E mi veui augurete ch’a sia n’alògg arios, con tante fenestre duverte sël mond, e na stansiëtta riservà, tuta toa, per j’ore triste, per j’ore grame e per la malinconia e le speransëtte.
E tanto pì bel e pur a sarà cost alògg neu, perché it tl’avraj nen da paghé ‘l fitt ma i’t saraj tì ‘l padron dla cà, e ‘l rè e l’imperator dla toa fantasia.
Corage, Olivero. Adess ti ‘t sej an prima bataja – ma i son sicur che i’t vinceraj – ansi i’t saraj d’ij primi a vince.
Mi ‘m arlegro con ti e con mi, con ti perché i tl’has l’andi e la forssa, la veuja e la costanssa, con mi perché i l’hai compagnate, fermete, conossute e vorssute bin.
Nota. Costa, in questa lettera diretta ad Olivero, scrive: Sarà to indiriss – toa marca – tò stil. As dirà: Olivero – come ‘ncheuj as dis Costa – sensa pericòl ëd confondse.
Qualche anno prima, nel 1933, in una lettera diretta ad Alfredino e dallo stesso utilizzata come prefazione alla sua raccolta di poesia Primavere, scriveva: Mi 'nvece am piasrìa che 'n dì ò l'àotr, lesend na poesia senssa firma, as podeissa dì: l'é na poesia d'Alfredino, l'istess come 'ncheuj as dis: l'é na lìrica 'd Pacòt o a l'é 'n Pero 'd Galina.
Torino, 29/8 - 41
Me car Olivero,
Grassie dla fontan-a 'd Roma. Per fete l'anghicio it mando na fontan-a 'd Turin. Quand ch'it torne a cà? Su tutt a va bastanssa bin. L'Armanach l'è quasi al complet. L'unica dificoltà per adess a l'è il permess dla carta. Ti scriverai ancora per l'òn. E 'ntant bon travaj e ricord-te minca tant dl'amis Nino Costa
Da: Le fontan-e 'd Turin
Pòrta Neuva
Sola, 'n mes ai giardin ëd Pòrta Neuva,
l'acqua a va su 'nt'në spricc: drita, aota, franca,
e peuj a casca 'nt'una s-ciuma bianca
che'n buff d'aria a smasiss parej d'na pieuva.
Sota, la vasca, adess che 'l sol ai manca,
së scuriss man a man d'na tinta bleuva;
j'ànie pàsie e domestie a fan la preuva
dë sbaciassé 'nt coi onde aote na branca.
E tutt antorn le fior d'ij bei giardin
e j'erbo e i monument son lì sospeis
per col gieugh d'acque fresch come 'n basin...
Fontan-a pien-a 'd grassia e senssa peis
- libera come l'anima 'd Turin -
- drita come 'l carater piemonteis -
Nota. La poesia Porta Neuva è stata raccolta a pag. 37 in Tempesta. Salvo piccole differenze grafiche (ad esempio ô invece di o come nell'autografo) le due versioni sono identiche. Differisce solo l'inizio della terza strofa. Ma tutt attorn invece di E tutt attorn.
Il riferimento a l'Armanach in preparazione si riferisce a quello per il 1932 che Costa collabora a compilare con la Famija turinèisa e con Pinin Pacòt.
Turin, 29 dic 1941
Me car Olivero,
la Roma dij Papa, sinchsentesca e baròca a l’ha ispirate forsse la pi bela poesìa ch’it l’abia fait…fin adess. Fòrs avia ëd doe o tre paragon un po’ baroch, lòn ch’a disdòj nen a le catedrai, specialment le Roman-e, ël rest a l’è tutt a fait bel – ansi la scond e ultima part a son pagine ëd vera e fòrta poesia. L’hai già lesula ai mè ‘d ca e a quaiche amis e a son tuti d’acòrdi con mi. A l’Epifania i la lesran ëd cò an casa Orsi – dou soma invità i solit: Baretti – Pacòtt – Talucchi ecc.
Bravo Olivero! It ses prope sla stra granda e tira ananas… ch’it rivrass dou ch’it veule. Dròlo, però, che da le Mistà pagan-e, it vade pòch per volta avsinandje a le Mistà cristian-e, ansi catoliche. Sòn am fa piasì perché i son ‘d cò mi dl’istessa idea. Forsse j’ë sponta l’alba d’un ritorn al Crist e a sò vicari an Roma e a l’è bel che noi i sio a l’avanguardia. In hoc signo…vinces!
L’Armanach a va anansi a posson, ma a rivrà ‘d cò chiel a sò temp e a soa mira. Per le copie ch’i t’ l’has dë bsògn butte d’acòrd con Viglongo…S’it peule mand-me notissie toe, e ‘d toa vita vera – val a di cola dla toa poesìa. E stame gigio. E ricord-me quaich vòlta. Bon ami, me car poeta – e …corage.
Notte tra il 13 ed il 14 di luglio del 1943
Inverno del 1942 e primavera del 1943 aono segnati da numerosi bombardamenti su Torino. Il 13 maggio Nino scrive a Luigi Olivero:
Caro Olivero,
fui bombardato – sinistrato – sfollato – malato - migliorato. Tuttavia non mi scordai degli amici poeti e godo delle loro glorie, specialmente delle tue. Di te, ora, si può ripetere il motto dell’Austria di Maria Teresa Bella gerant alii, tu felije Olviginj, nube. (Altri facciano le guerre, tu felice Olivero Luigi, pensa al matrimonio) (Parafrasata la frase autentica: Bella gerant alii, tu felix Austria, nube. Altri facciano le guerre, tu felice Austria, pensa ai matrimoni)
Viva te che ti sposi la tua bella poesia in carne ed ossa. Dio te la conservi e vi doni a tutti e due quella felicità e quella pace che meritate. Dei poeti di Torino non so più nulla. Io vivo ad Asti e viaggio su e giù tutti i giorni. Qualche volta scarabocchio ancora ma il tempo mi manca che molte sono le faccende e le croci.
Un abbraccio a te e un augurio particolare a madamin Cinci.
Se vedi Caballo congratulati per me del premio della Montagna e di tante altre cose belle che fece, fa e farà. Oramai con lui siamo a Caballo e si farà strada. Son lieto che sia dei nostri
Celestina Costa, in un ricordo del padre tenutosi ad Asti così accenna a quei momenti:
Nel novembre del 1942 i torinesi, non potendo più sopportare gli incalzanti bombardamenti sulla città, incominciano a sfollare e si distribuiscono nei paesi e nelle campagne, con la speranza di riuscire a vivere e a sopravvivere. Anche la mia famiglia decide di allontanarsi, subito dopo un bombardamento che ha distrutto, in parte, la casa di abitazione in Via Giacomo Bove 14. La località scelta è Asti, città sufficientemente comoda per viverci, per continuare gli studi e per raggiungere Torino, dove il papà aveva l’ufficio quale funzionario della Cassa di Risparmio. Da quel momento hanno inizio i nostri rapporti con la gente astigiana e si stabilisce fra noi un sentimento di reciproco affetto e di grande stima.
La RAF, Royal Air Force, nella notte tra il 13 ed il 14 luglio del 1943, mette in atto uno dei suoi più terribili bombardamenti su Torino. La Consolata, la chiesa del Carmine, la chiesa del Monte dei Capuccini, il Cottolengo, l'ospedale San Giovanni e poi la Via Po, Piazza Palazzo di Città sono solo alcune delle gravissime ferite inferte alla città.
Nino Costa tra il 16 ed il 23 luglio compone 14 luj 1943 Cômplènta per la sità 'd Turin che verrà poi proposta nella sua opera postuma Tempesta del 1946. Ecco i versi iniziali della struggente poesia:
Piôrôma 'ntl'ôra neira del destin
piôrôma gent, per la sità 'd Turin.
Quatordes Luj: na neuit ëd lun-a pien-a
e i nemis sôn rivà 'ntl'aria seren-a.
Sôn rivà côn le bômbe sôta l'ala
e la povra Turin l'han sassinala.
ed ancora le due strofe finali:
Ti t'ij cônosse j'omini dla tera
ch'a l'han prôntà, ch'a l'han vôrssù sta guera,
o Nôssgnôr so castigh ... mandijlô Ti...
E Nostr Signôr a l'ha fait segn che 'd sì...
La poesia reca in calce queste parole:
Finita di comporre il 23 luglio 1943 due giorni dopo il 25 cadeva Mussolini.
Lo stesso Costa, a proposito del titolo ci fornisce il significato di Cômplènta: canto di compianto termine derivato dal valdostano complainte. (Nota tratta dalla plaquette pubblicata dall'editore Viglongo nel 1993). Nei versi riprodotti si potrà notare un ritorno del poeta, in parte, alla grafia tradizionale che utilizzava nelle sue prime opere Mamina, Sal e peiver, Brassabosc prima di aderire alla grafia proposta da Ij Brandé e da lui utilizzata, con qualche incertezza inizialmente, con Fruta madura e poi con Roba nostra.
Verso la Tempesta
Come ci ricorda Nino Costa, il 25 luglio cade Mussolini ed il fascismo. Leggiamo ancora dal racconto della professoressa Celestina Costa:
Il tempo ad Asti, scorre senza eccessive scosse; la guerra stende le sue ombre sulla vita di tutti – pochi i sorrisi, ma nel dignitoso silenzio della gente, poche le rivolte e sopportabili le sofferenze. – La popolazione vive in trepida attesa. Noi continuiamo la nostra solita routine: mio fratello ed io gli studi, il papà i viaggi a Torino, la mamma a difenderci e a tenerci nel cerchio del suo amore.
Mio papà e mio fratello, separatamente e all’insaputa l’uno dell’altro, hanno contatti con i movimenti clandestini, ma in casa ancora si tace. Cambiamo sovente abitazione: da piazza Astesano al Leon d’Oro a casa Coffano in Via Brofferio; la censura ufficiale e prudenti controlli non ci isolano ancora e gli amici non ci abbandonano e ci confortano.
Giunge il 25 luglio… tra il tripudio illusorio e la gioia di tutti.
Ma i tempi incalzano e le speranze degli italiani vengono presto distrutte; l’8 settembre 1943 la notizia dell’armistizio fissa una pagina nera della nostra storia; si spengono gli ultimi sorrisi, ma si riaccendono le attività clandestine; troppo eccitante è stato il profumo della libertà per riuscire a soffocarlo. In casa nostra papà e Mario si confidano le loro speranze, ma la mamma ed io confessiamo le nostre paure. Papà scrive pagine di appunti nelle quali esprime i suoi pensieri più nascosti. In quel tragico inverno ’43 il sentimento più forte per lui è quello di aver scoperto in suo figlio il migliore se stesso.
Così commenta lo scoppio di pianto di Mario alla notizia dell’armistizio: “Lo sapevo buon piemontese e buon italiano, ma non supponevo ancora in lui una così ardente passione. Questo suo scoppio di pianto non è, forse, che l’ultimo e più manifesto segno di tutta una evoluzione che si veniva formando nel suo spirito. Mario non è un ragazzo loquace e tanto meno espansivo. Specialmente in casa.
Un pudore, forse esagerato, dei suoi sentimenti più intimi gli impedisce di esprimerli a parole. Alla sua età ero così anch’io, e mi ricordo di averne molto sofferto. Mario è uno di quei caratteri che accumulano in silenzio la loro carica e poi, all’improvviso, esplodono. Noi, la mamma ed io, lo abbiamo naturalmente educato all’amore della patria, ma senza particolari insistenze. Se mai, abbiamo piuttosto insistito sul sentimento religioso, e sul virile dovere della rettitudine e della dignità. Ma si vede che le vicende di questi ultimi anni e lo spettacolo, non sempre edificante, dell’Italia in guerra hanno acceso nel suo cuore la fiamma del patriota.
Tuttavia, e di questo son certo, egli non è né un settario né un partigiano. Non è, neppure, antifascista. Ignora la dottrina del fascismo e forse disprezza i fascisti. Io l’ho sempre tenuto lontano dalla propaganda del regime e sono riuscito a salvarlo dall’infezione. Egli poi ha sempre avuto un concetto fierissimo della sua libertà personale. Fin troppo. Quindi escludo senz’altro che nel suo presente dolore si insinui una punta di passione di parte. Piuttosto, come gli altri giovani della sua età si innamorano, Mario si è innamorato dell’Italia. Converrà tenerlo d’occhio perché non si sa mai dove possano condurre queste passioni giovanili. Peccato che domani io debba partire con Celestina per il Monferrato. Ma tornerò fra pochissimi giorni e allora… vedremo…”.
I tempi peggiorano; le sorveglianze si fanno più attente; gli astigiani, in guardia, attendono lo svolgersi degli avvenimenti; la loro anima fiera non si piega alle imposizioni; i bandi di reclutamento dei militari hanno poco successo. Il governo della repubblica passa alle maniere forti. Così il poeta descrive uno dei tanti momenti tristi della popolazione, che sono gli stessi vissuti nella sua casa:
“In città hanno fermato una sessantina di uomini e li hanno chiusi in un camerone di caserma; una cinquantina di donne le hanno chiuse in un seminario. Agli uomini si dà pane e acqua, però si permette ai parenti e agli amici di soccorrerli. E ciò avviene in larga misura. Le donne sono meglio nutrite, perché a loro provvede il Seminario stesso. I padri e le madri non cedono. Anzi molti genitori si presentano spontaneamente per salvare i figlioli. Tutto sommato, queste rappresaglie non servono a nulla, specialmente qui nell’Astigiano. Infatti dopo una quindicina di giorni i familiari dei renitenti vengono rimessi in libertà. Ma la voce è corsa e forse nelle altre province i giovani, per evitare a padre e madre una lunga detenzione o peggio, si presentano ai distretti. Qui però la maggior parte di loro si nasconde o fugge. Ma dove? E Mario? Urge provvedere per lui.”
E dopo lunghe discussioni, dopo infiniti ripensamenti e dopo tante lacrime, Mario riesce ad ottenere il consenso per trasferirsi in montagna con i partigiani; prima tappa la Val Sangone agli ordini di Silvio Geuna. Qui di seguito il racconto degli ultimi giorni astigiani di Mario.
“In questo ultimo mese, quando i miei doveri d’ufficio me lo consentono, Mario ed io usciamo insieme per Asti e discorriamo di tante cose. In realtà quasi sempre discorro io e Mario ascolta. Parliamo d’arte, di poesia, di musica. Mario è assai acuto nell’indagine, e sensato nel giudizio. Classico fino alla punta dei capelli e piemontese fino al midollo. Tutto quanto sa di improvvisato e di decadente gli ripugna; perciò non intende e disprezza i crepuscolari e gli ermetici. Parliamo spesso di Dio e della dottrina cristiana. Io cerco di avviarlo piano piano, verso la sorgente eterna della verità e della giustizia: il Vangelo. Egli mi segue e mi asseconda. Di certo lo spirito di Rovera veglia su di lui e lo ispira. Anche parliamo dell’Italia e delle sue avventure. Mario ora, è molto più equanime e sereno. Guarda le innumerevoli miserie morali che ci formicolano d’intorno con occhio già distante e superiore. Incomincia a comprendere quali povere anime siano le anime degli uomini e su quanta poca sapienza si regga il mondo.”
Il tempo passa, giunge l’inverno e Mario parte; così scrive il papà:
“Il 30 gennaio, (1944) domenica, Mario si è confessato e comunicato. Alla vigilia della partenza ha voluto mondarsi l’anima, per andare, puro, incontro al suo destino. Nel pomeriggio, verso le 18 andiamo tutti e due a salutare l’amico Can. Luigi Stella, parroco del Duomo di Asti. La mamma e Mario, chissà perché, lo chiamano «Monsignore». Prima di uscir di casa la mamma mi sussurra: «Prega Monsignore di benedirlo». «Va bene». Monsignore rinnova a Mario le sue raccomandazioni di prudenza, di calma, di serietà. Mario consente e promette. Prima di ritornare a casa prego Monsignore di benedire il mio ragazzo. Il sacerdote si alza, si raccoglie un istante, prega in silenzio. Sembra diventato più alto, più ascetico, più solenne. Mario china la testa, con riverenza. Il sacerdote, lentamente, pronunzia le rituali parole della benedizione cristiana.
Mi sembra di rivivere un episodio del Risorgimento. Penso ai Crociati, ai cavalieri Guelfi, a Garibaldi, a Don Giovanni Verità, alla Giovane Italia. Nella penombra della modesta saletta di Monsignore palpita non so quale altissima poesia. Dopo la benedizione siamo tutti e tre un pochino commossi. Salutiamo il canonico, la sua buona sorella, il sorridente vicecurato, e sottobraccio come due amici della stessa età, io e Mario ritorniamo a casa. Prima di andare a letto Mario chiude la sua valigia. Porta seco pochi libri: Il Vangelo, Dante e l’ultimo volume delle poesie di suo padre: «Roba nostra». Gli consegno la mia poesia: «La mia patria l’è sla montagna» e lo invito a leggerla a mezzavoce affinché io senta se la sua pronunzia piemontese è corretta. Quando giunge ai versi:
«e l’ora l’è gnanca lontan-a
ch’i vëddo s’ij brich a sta pian-a
l’Italia ch’a tôrna italiana»
la sua voce trema e Mario singhiozza. Piango anch’io con lui.”
Da allora non l’abbiamo più visto; giungevano notizie abbastanza regolari e nei modi e con le forme più impensati; passavano i mesi con una lentezza esasperante: dalla Val Sangone, attraverso varie vicende Mario era passato in Val Chisone e il 2 agosto 1944 sul monte Génévry veniva ucciso durante un combattimento mentre tentava di aprire la via ai compagni accerchiati. Di lui sono rimasti una medaglia d’argento al valor Militare e le pagine scritte dal papà ritrovate in una tasca della sua giacca.
Alla notizia della morte di Mario, gli astigiani tutti, amici ed avversari, senza distinzione di ceto sociale o di parte politica, sfidando giudizi, critiche e sospetti (che a quel tempo potevano causare gravissime conseguenze) ogni giorno sono venuti a trovare la nostra sventurata famiglia, portando un fiore, un conforto, una lacrima di solidarietà. Non ci sono state da parte di nessuno né remore, né timori; la gente di Asti veniva a salutare il poeta della libertà, il cantore della dignità dell’uomo che aveva, con l’eroica morte del figlio, dato testimonianza dei suoi principi e della sua fede. Fino al gennaio del 1945, quando la mamma ed io abbiamo riportato a Torino il papà colpito da infarto.
Tempesta
In questi mesi nascono alcune delle più belle e sentite poesie di Nino, tutte raccolte in Tempesta: La mia patria l'è sla montagna del novembre 1943 dedicata a mio figlio Mario e a tutti i partigiani della Val Chisone, Côi ch'a marciô an prima fila con dedica a Tito Dumontel, a mio figlio Mario, a Giorgio Catti e a tutti i patrioti morti per l'Italia, e ancora la poesia La nôtissia del 16 agosto 1944, eccone la prima strofa:
Sëdes d'Agost... al dop mesdì...
Côl dì l'avia mangià per tutt disnè
na mica 'd pan môjà 'nt'un bicer 'd vin...
J'era côntent l'istess. Quasi a dôi bott
ai riva 'l papà 'd Cesare 'ntl'ufissi...
Portô 'd brute nôtisse...
«Mario?»
«... Sì ...»
Seguono, scritte dopo la morte del figlio La prima sosta settembre, La maja ottobre, Le fiôr d'ij patriota con dedica a mio figlio Mario caduto sul Génévry, e ancora La spin-a primavera 1945, La piantin-a dla speranssa, La Madôna d'ij soldà dedicata a tutte le mamme che piangono il figlio caduto.
Giugno del 1945. Luigi Olivero, a Roma, cerca di dare vita alla sua nuova rivista Ël Tòr - Arvista libera dij Piemontèis il cui primo numero uscirà il 14 luglio. Chiede la collaborazione di Nino che così gli risponderà in una lettera del 23 giugno:
Torino, 23 giugno 1945
Caro Olivero,
grazie del buon ricordo, delle buone notizie e della fiducia che hai in me. Ma non hai fatto il conto:
1° con la mia età – 58 anni
2° con la mia salute – assai deteriorata dopo la morte di mio figlio Mario – caduto eroicamente in Val Chisone combattendo contro i repubblicani
3° col mio tempo – diviso e suddiviso fra l’ufficio, la casa sempre piena di gente, il Popolo Nuovo e la ricostituenda Famija Turineisa –
4° con la mia capacità di lavoro, molto ridotta da un anno in qua –
5° con la mia pigrizia che si accentua di giorno in giorno.
E quindi sono costretto a declinare l’incarico che tu volevi con tanta cortesia affidarmi.
Spero che Pacotto, cui ho cercato e cercherò di telefonare, sempre invano, ti possa accontentare.
Da parte mia, quando avrò visto i primi numeri della tua rivista, (perché io ho grande stima del tuo ingegno e dell’estro che lo infiamma, ma diffido della tua foga di bersagliere e delle tue sempre accese velleità erotiche letterarie) – spero poterti mandare qualche poesia o qualche articolo in idioma italico o allobrogo se ancora sarò capace di scrivere qualcosa che valga la pena di essere letta.
Comunque farò tra gli amici di Torino la propaganda per la tua rivista che può diventare e ti auguro diventi una gran bella pubblicazione.
Cordialmente
tuo
Nino Costa
Seguono ancora alcune poesie: J'ale bianche, Cioche, La cassôn del merlo, J'acque terbôle con dedica al comandante Piero Catti, La speranssa, A tôrno con dedica al dottor Ignazio David e a tutti gli internati, La crôs d'ij mônti, Turin '945, La dôja suita, per finire con la sua ultima poesia Crisantem .
Così Celestina Costa conclude il convegno di Asti:
Il 5 novembre 1945 a Torino, si spegneva Nino Costa; aveva 59 anni. Pochi anni dopo anche la mamma di Mario raggiungeva la famiglia. Sono rimasta io sola a custodire le memorie…
E di Crisantem eccone alcuni versi in conclusione:
E se mai da le strà d'ij simiteri
l'è vnuje 'ncôntra a l'anima dla gent
na parola, 'n cônssei, n'avertiment...
sai pà... 'n sôspir surtì dal gran misteri,
ch'a sia stavolta per i giôvô e i vei
na parola d'amôr: uman-a e ônesta,
ch'an giuta a vince st'ultima tempesta
ch'an môstra a tôrna diventé fratei.
Luigi Einaudi e Nino Costa
Nel 1955, per ricordare degnamente Nino Costa, le cui opere, sempre stampate in limitato numero di esemplari, sono da tempo esaurite, Il Cenacolo di Torino, con la collaborazione di molti Enti ed Associazioni piemontesi, da alle stampe il volume Poesie piemontesi, pomposamente definito come l'Opera omnia della poesia piemontese di Nino Costa, grosso volume di 905 pagine.
In questa sede non mi interessa valutare pregi e lacune dell'opera. Solamente l'introduzione dovuta all'allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi: Incontro con Nino Costa. Eccone la chiusa:
Poeta dunque, senza aggettivi, poeta che canta, secondo il cuore gli detta, verità e sentimenti universali. Perché dunque, noi piemontesi, gli siamo particolarmente riconoscenti? Forse perché Nino Costa non ha voluto al suo canto dare una espressione formale che egli non sentiva propria a lui? Non so; spontaneamente, istintivamente egli ha cantato in piemontese, perché questa era la sua lingua. Non un dialetto destinato ad essere a poco a poco obliterato; ma vera e propria lingua. E quanto propria, quanto adatta al pensiero! Sicché pare e forse è impossibile tradurre quella poesia dalla sua lingua natale in un'altra qualsiasi. Il pensiero di Nino Costa era paesano, familiare, melanconico, composto di brevi quadri, di problemi quotidiani, sempre gli stessi: l'amore, i figli, il padre, la mamma, i nonni, la terra, il podere, il dovere, la patria, la carità, le persone buone, i benefattori degli uomini, il coraggio, la viltà, il buon senso, don Bosco e il Cottolengo. Forseché questi uomini e queste qualità buone e cattive non sono degne di poesia e non possono essere cantate in qualsiasi lingua? La forma usata da Nino Costa era appropriata al contenuto; le parole usate furono quelle che meglio rendevano la commozione, il sentimento, la musicalità dell'idea espressa dal poeta. Al profano, che non ha mai scritto un verso, ma si annoierebbe a leggere versi italiani tradotti in piemontese, leggendo Costa sembra di vedere scorrere le parole una dopo l'altra disposte così come non parrebbe possibile disporle diversamente a chi voglia pensare e scrivere nella propria parlata materna.
Piace talvolta sognare e, riandando agli anni passati, rivedere la nonna che prepara il caffè alla moda vecchia, avanzando e ritirando sulla brace del caminetto la coccoma perché la schiuma non trabocchi e frattanto consiglia, rimbrotta e racconta ai nipoti. Il suo dialetto era la lingua propria e fine usata da Nino Costa nel poetare; epperciò ancora lo ringrazio per avermi fatto rivivere, dopo tanti anni, tra la gente vissuta alla fine del secolo scorso, e se gli uomini d'oggi paiono diversi, giova sperare serbino, mutate le apparenze, le virtù le quali fanno durare nei secoli le famiglie e i popoli.
Luigi Einaudi
Dogliani, agosto del 1955.
Lettere di Nino Costa a Luigi Olivero appartenenti al Fondo Olivero di Villastellone
che qui ringrazio per l'autorizzazione alla riproduzione
Costa, Pacòt e Ij Brandé
Pinin Pacòt nel 1930 da il via alla serie degli Armanach piemontèis che da quello del 1931 proseguiranno fino a quello del 1938. Pur senza mai aderire alla Compania dij Brandé riunita intorno a Pacòt, Costa, che fa invece parte del gruppo di poeti fedeli alla tradizione riuniti intorno al giornale della Famija turinèisa 'l caval 'd brôns, collabora con poesie scritti, recensioni.
Mè car Pacòtt.
Grassie dl'invit a la collaborassion per l'Armanach 1937.
Ti t'sas coma i l'hai sempre goardà con simpatia e cercà 'd giuté an tute le manere vòstr moviment d'i Brandé - per lòn ch'a rigoarda lë slanss dla gioventù e 'l desideri ëd fé 'd poesìa bela e neuva.
Ma j'ani a passo, purtròp, e con mia età e mia fasson ëd vëdde le còse (ch'a l'é, forsse, na conseguenssa dl'età) adess im sento nen d'esse nì d'i vòstri, nì d'j'aotri.
Per lòn iv prego, per cost'ann sì, ëd lasseme an dispart, bin sicur che l'Armanach 1937 a sarà na pubblicassion viva e interessanta bele senssa mia colaborassion.
Con na streita 'd man e tanti auguri.
NINO COSTA
Ritorna qui la vecchia diatriba tra i seguaci di Pinin Pacòt aggregati nella Companìa dij Brandé (i vòstri) e i poeti rimasti fedeli alla tradizione rappresentata dal giornale della Famija turineisa: 'l caval 'd brôns attorno al quale altri poeti si raccolgono (gli aotri).
Pacòt la prende veramente male e così risponde sullo stesso Armanach riferendosi anche alla lettera ricevuta da Giovanni Gianotti che si offiva lui stesso per collaborare:
Vous l'avez voulou, George Dandin, vous l'avez voulou
Ste doe létere a l'han pa dë bsògn ëd coment. A son così ciaire, ant lë spirit e ant la forma, ch'a basta lesje per capì ch'as peul esse ancora giovo a 70 ani e meno a 50. E noi ringrassioma Giovanni Gianotti, - ël poeta 'd «Fërvaje d'ànima», ch'a festegia cost ann i sò stant'ani, - che da soa bela autura d'ani a sa guardé con tanta simpatìa i giovo ch'a marcio a metà còsta, coma s'a l'aveissa ancora 'l boneur ëd marceje ansema, ansi sentendlo, col boneur, ant la frësca gioventù 'd sò cheur.
E i ringrassioma 'd cò Còsta. Na paròla ciaira a l'é sempre un regal da amis.
Giumai chiel a l'é vej (j'ani a passo, purtròp!) e con soa fasson ëd vëdde le còse chiel adess a peul pi nen esse nì di nòstri nì dj'autri. Verament noi i savìo nen ch'a j'esisteissa d'autri. Aj na sarà magara, ma noi ij conossoma nen. Anvece Còsta a treuva ch'a l'é bel esse amis con tuti, fin-a con i fantasma. Ansi! E così sia!
E a sarìa bele finì, con n'ùltim ringrassiament a Còsta per i sò auguri, bin sicur 'd cò noi che l'Armanach 1937 a sarà na publicassion viva e interessanta, bele sensa la soa colaborassion.
Ma i duvoma recité 'l confiteor:
Fin-a al 17 otober ëd cost ann, Costa i l'avoma sempre consideralo coma nòst Maestro, con tanto d'M maiùscola; e i l'oma fait bin, perchè ch'a l'é bel che i giovo a rispeto i vej, prima 'd tut perchè ch'a son vej. Ma i l'oma avù tòrt.
L'oma avù tòrt perchè Costa a l'era nen e a pudìa nen esse un maestro per noi. Chiel a rapresenta la fin d'un temp e noi i l'oma la preteisa d'esse 'l prinsipi 'd n'autr. Chiel a l'é la continuassion, e, disomlo sùbit, pi artìstica e pi dignitosa, di Viriglio, di Fasolo, di Rico, di Solferini, etc. etc.; e a sti modei a sa nen rinonsieje; l'istess coma a savrìa nen rinonsié a la spassgiada da ses a sèt sota i pòrti 'd Pò, ant la veja religion dla faseusa e dla sartoriëtta. Poesìa dialetal per ecelensa.
Un òm sol, ant ël torment ëd soa granda ànima inchieta, a l'ha avù 'l coragi 'd ribelesse a la fum 'd mese toscane ch'a lo sofocava: Fonso Ferrero. E bele mach an passand i s'inchinoma dnans a soa memòria.
Ma Costa a peul nen dëstachesse da tuta soa nostalgìa bicerina e a resta, per lòn, ancora, Esposission Universal 1911.
Sì, l'oma amparà da chiel ël bel piemontèis, pur, armonios, sgnor e polid; l'oma amparà da chiel coma ch'as martela 'l vers e coma ch'a s'antërsa ant la stòfa pien-a e legera, armoniosa e fòrta. Ma l'é nen stait un maestro 'd vita, nen un maestro 'd poesìa. Coma ch'i s'iludìo noi ch'a fussa.
Nòstra gioventù l'é staita sùbit tròp provà, e la vita i l'oma conossula tròp prest ant lë splendor ross dla tragedia, per nen rivé 'd colp a capì che la poesìa, coma la vita, a l'é quaicòsa 'd pi profond ò 'd pi aut, 'd pi sutil ò 'd pì grand, che i pòvri sonèt e le maire strofëtte dla poesìa dialetal piemontèisa. E se la poesìa i soma nen rivà sempre a fela nòstra, ant l'ingenuità 'd nòstra arte, i l'oma però avù 'l sens 'd lòn che la poesìa a l'é, ò, almeno, 'd lòn che la poesìa a l'é nen.
Questo scritto, violento, ed anche cattivo, rappresenta, probabilmente, uno sfogo dovuto più che altro all' orgoglio ferito dal rifiuto di Costa a collaborare.
Nel secondo numero della sua nuova rivista, la seconda serie de Ij Brandé, del primo di ottobre del 1946, con Costa morto l'anno prima, Pacòt rivede nettamente quei suoi giudizi dettati con tutta probabilità da uno scatto d'ira:
La poesìa 'd Nino Costa a l'é vnua al moment giust. Quand che jë scritor dël temp ëd Viriglio, e ij sò imitator, a l'avìo ormai dit soa ùltima paròla neuva, e quand che le tendense giovo 'd nòstra poesìa, preanunsià da Alfonso Ferrero e da Giovanni Gianotti, a l'avìo ancora nen trovà la tonalità giusta për esprimse: ant col moment che la poesìa piemonteisa a smijava ch'a stèissa për finì, Nino Costa, cujend lòn ch'a j'era ancora 'd viv ant l'eredità dël passà, rimontand ansi quaich vòlta pi an su, fina a Brofferio, fina a Calvo, e interpretand le aspirassion 'd rinovament ch'ancaminavo a fiorì d'antorn a chiel, a l'ha savù fonde ant soa ispirassion, ël vej con ël neuv, e tnisendse bin atacà a nòstra tradission nostrana, sensa arneghé la viva esperiensa poética moderna, a l'ha dane cola soa poesìa, così piemontèisa e così soa, che partend da na manera squasi popolar a l'é rivà, travers a na decantassion interior e sutila, a d'espression liriche da gran poeta.
Rispondendo poi a chi gli ricordava del suo ripudio di Costa nel 1936, va ancora oltre:
... për noi Nino Costa a l'é stait un maestro 'd poesìa; un gran maestro, i l'avoma dilo e i lo ripetoma, liberament sia pure con tute le riserve che an sede crìtica i chërdoma bin ëd fé. Gnente a peul sgrisé 'l sentiment 'd riconossensa e d'amirassion che noi i l'avoma për col che, malgré certi moment d'incomprension e 'd dissens, recìproch, a l'é stait për noi n'amis e n'esempi. I ricordoma l'ùltima visita ch'i l'avoma faje, pòch temp prima ch'an mancheissa, e soe paròle serene e soa streita 'd man afetuosa a son staite për noi coma un pegn d'amicissia e 'd poesìa. I dësmentiroma mai pi sò ùltim salut!
In altra occasione ancora ( 1 dicembre 1946) aggiunge:
E adess i podoma afermé tranquilament, dòp che la mòrt a l'ha portalo via, che tuta soa òpera 'd poeta a resta coma n'esempi magnifich, al qual i dovoma ispirese noi-autri pi giovo ch'i së sforsoma d'esprime an bela forma 'd poesìa col pòch ò tant, che 'l cheur an deta. E për lòn i lo ciamoma maestro.
Per concludere
questo omaggio al Poeta Nino Costa avrebbe dovuto concludersi con le parole di Luigi Einaudi.
Però Michele Bonavero, contrariamente a quanto scritto nella prima parte a proposito dei burrascosi rapporti tra Costa e Pacòt, e cioè al rinvio a quanto già pubblicato in Piemontèis nel gennaio 2015, repetita juvant, ha voluto riproporre il brano.
Mancava così una breve conclusione. Abbiamo appena festeggiato i 90 anni di Camillo Brero. Chi meglio di lui avrebbe potuto fornirmi un degno epilogo? Ecco pertanto, da Le magnifiche vos dla leterarura piemontèisa pubblicato nel 1975 da Fiorini, indimenticato e compianto editore di Piemonte in bancarella, quanto Brero ha premesso alla raccolta di poesie di Nino Costa.
Naturalmente, istintivamente «Poeta», Nino Costa, sin dalle sue prime composizioni pubblicate sul «Birichin», si discosta e si eleva per delicatezza e nobiltà di sentimenti sul prezioso compitare dialettale degli scrittori suoi contemporanei, tesi alla ricerca della poesia di effetto, romantica o umoristica.
«Mamina» (1922) parla un linguaggio nuovo, preannuncio di quella che sarà l'opera poetica futura di Nino Costa.
Con «Sal e pèiver» (1924) prima e con «Brassabòsc» poi, il poeta è già universalmente ritenuto il migliore ed a lui guardano molti come ad un esempio da imitare.
La carica poetica e la ricchezza di ispirazione del poeta riesce a tradurre liricamente il suo amore alla vita ed a cantare, con forza epica, il suo amore alla terra. E diviene il poeta della gente piemontese, che si entusiasma e si riconosce nella sua voce.
Ed egli dialoga col suo popolo con la eterna filosofia della favola o, con più modesti accenti poetici, rivive ricordi e canta elegantemente i tradizionali, cari motivi popolari.
Ma quando canta i valori morali e spirituali della gente piemontese, quando la sua voce freme della fierezza della terra di Piemonte, egli diventa il grande poeta.
Poeta, dunque, nell'intimità dell'anima; poeta nella vita civile torinese e piemontese, nei sogni, nelle aspirazioni e negli ideali; poeta in cui tutte queste cose vengono filtrate nel soffio della bontà della sua anima.
Ed in «Tempesta» (1945) tutta questa poliedrica ricchezza del suo animo confluisce e si trasforma nell'unità meravigliosa della «Poesia» senza altri aggettivi.
Con questa «Poesia», Nino Costa realizza in se stesso l'«Uomo». Quel grande Uomo-Poeta che l'amore e il dolore stroncò quel 5 novembre del 1945.
Piemontèis ancheuj ,Ann 35N° 5 magg N° 7/8 luj/agost 1917 (3 puntate)
Pinin Pacòt e la Famëja Anunèisa
Qualche tempo fa, approfittando di una bella giornata di sole preprimaverile, sfogliavo all’aperto, un libro di parecchi anni fa. Dell’Editrice Edilibri di Andrea Viglongo il volume Invito al Monferrato di Remo Grigliè del 1965. Il volume, presentato da Marziano Bernardi, fa parte di una collana di altri tre Invito alle Langhe, Invito al Canavese, Invito alla collina.
Da poco iniziato, a pagina 28 trovo un inciso redazionale Eleganze monferrine di un secolo fa. È accompagnato da una bella incisione che mi salta subito all’occhio, vedo la firma: è quella di Felice Vellan, notissimo pittore piemontese ed illustratore di tante raccolte di poesie di autori piemontesi. A questo punto leggo con maggiore attenzione e scopro che l’incisione è tratta da un quaderno edito nel 1959 dalla «Famëja Anunèisa», presieduta da Pinin Pacòt.
Nessun’altra indicazione bibliografica. Con i mezzi d’oggi, breve la ricerca e quasi subito ecco l’edizione: trattasi di Ai pe dal Casté Scartari dla Famëja Anunèisa pèr la Madòna dal Carmi dal 1959. Ancora breve ricerca e trovo che esiste solo in tre biblioteche pubbliche: Asti, Firenze e Roma. Fortunatamente abito vicino ad Asti. Vado alla Fondazione Biblioteca Astense e trovo che gli scartari in possesso della biblioteca sono due: quello che cerco ed il numero due pubblicato nel 1980.
Il primo scartari è di 32 pagine, edito dalla Famëja Anunèisa e redatto dal suo presidente Pinin Pacòt. Il secondo, di una quarantina di pagine, è pubblicato An onor dël grand poeta anonèis Pinin Pacòt anno 1980 e contiene brevi lavori dei ragazzi delle scuole locali dedicati a Pacòt, a Castello d’Annone e ai costumi locali.
Il primo scartari
la “ Famëja Anunèisa”.
Avvicinandosi il primo Anniversario della sua fondazione, la «Famëja Anunèisa» ha voluto festeggiare la lieta data con la pubblicazione del presente Scartari. In tale occasione i Soci si sono riuniti a banchetto al Ristorante della Stazione, dove già lo scorso anno avvenne la solenne inaugurazione della nostra Famëja con la partecipazione fraterna della Famija Turinèisa.
Al banchetto anniversario, nella impossibilità di partecipare, a causa della distanza e di molteplici impegni, la Famija Piemontèisa di Roma, in persona del suo illustre Presidente S. E. l’Onorevole Giuseppe Pella, ci ha inviato il seguente telegramma, che ci è gradito riprodurre, come segno di onore e di alto riconoscimento della nostra modesta ma disinteressata attività, in capo a questo quaderno, che del nostro amore per la piccola e per la grande Patria vuol essere sincera e fervida testimonianza.
Pinin Pacòt. Castello d’Annone.
Alla festante Famëja Anunèisa et a Lei suo animatore sia gradita la cordiale adesione un fraterno saluto et il fervido augurio della Famija Piamontèisa di Roma e del suo Presidente
Giuseppe Pella
Segue una Presentazione:
Questo primo e, speriamo, non unico «scartari» («quaderno», per chi abbia dimenticato il gustoso piemontese dei nostri padri) vuol essere il contributo modesto e, ci auguriamo, intelligente della «Famëja Anunèisa» alla festa patronale della Madonna del Carmine. …
Quindi la rievocazione della serata inaugurale, l’anno precedente, della Famëja alla presenza della Famija Turinèisa con Giandoja e Giaconëtte e, riprodotto integralmente il discorso tenuto da Pinin Pacòt in stretto dialetto di Castello d’Annone. Ne estraggo alcuni passaggi:
Lassé che, per la prima vira ch’as truvoma ticc ansima, noi dla Famëja Anunèisa, lassé ch’av parla con al côr, n’atra vira pô a parlroma da festa.
Ma sta sèira bsògna ch’as trôvu dabon ticc an famëja, e ch’a sentu ch’a soma ticc amis, ch’a soma ticc fradé. Per su-lë vanta ch’av parla ant al dialët di nòstri vegg: an cul parlé ch’a j’ô amprèis quë da masnà, quand ch’a passavu tit l’istà a giuè cmé di fòi au raz du su ch’u n’anciucava, an curënda cmé ‘d sassën travers al vigni dal culën-ni per i pra e ant i camp dla Pian-na ò ‘d Tani mòrt, ò longh a Tani an mez al guri e al cani, ò an si geron a tiré dal preji ant l’eua. E cul parlé l’era per noi la vus dla tèra ch’a pistavu, dla tèra ch’un dava l’iua pi bon-na e i persi pi duss ch’u i fissa, issa frita ch’ l’ava ‘l ghist dla nostra età pi bela. …
Ma smëja ancora d’essji an cul bel Anon d’ mez sé cul fa, ch’ l’ava ancora cui doi arbrun an sla poncia dal Casté, ch’in salitavi da luntan quand ch’s vnivu da fôra; quand ch’ i era ancora la gésia di Batì, quand ch’ i era ancora nen al scòli nôvi, ma au so pòst is avghivu ancora ‘l tombi du cimiteri vegg, e ‘l scòli i eru ant la ca dla Cmën-na, che anlura l’era ant la stra ‘d mez, sìbit dòp la buteja ‘d Vitu bel.
Cmé ch’l’è cambià is Anon ant na sinquanten-na d’agn, ò zë da lë! Pr’andé a la Ròca us passava ancora an sal Pòrt ad barchi, lë an fàcia a la Stassion, e in po’ pi an zë, ansima Tani, i era ancora i Mulën, con al so ròji gròssi che girando i favu dal zuassi ch’i favu pàu. E pira i era di fanciòt chi avu u stòmi ‘d tressi an drenta, e che nuanda suta al ròji i passavu da l’altra. …
Ma pi che tit cui temp – atri temp! – i eru temp ad tranquillità e, forsi, ‘d felicità. Perchè la felicità l’è prima ‘d it ant l’essi tranquil e ant u savèi cuntentessi. Fa nen bsògn ad curi tant luntan per serchela, perché l’è mach ant noi ch’a pudoma truvela. …
…la gent us contentava ‘d pòch. Us contentava du so travaj, a la travajava con amur, fina ch’la s-ciarava; e pô la sèira, prima d’andé a durm’ uj bastava ‘d passé chèica ura a vgé ant la stala, al calur dal béstji ch’i rimiavu, antant che ‘l vegi i filavu con al fis e la ruca, e j’òm i favu dla tèila con u tlé a man, per pronté i fardé dal mati ch’i andava spusi, e ‘l masnà, i fanciutën e ‘l matëti, quaciunà antorn a chèica nèna vegia, i stavu lë ancantà a scuté dal cuëntaji, ch’ij purtavu luntan ant al paìs di sôgn e dla fantasëja, l’istëss cmé adess con la radio e la television. E chissà? Forsi mej!
E ben sa gent, ch’i vivivu acsë, i eru dla brava gent. I eru i nòstri pari, al nòstri mari, i nòstri amsé e al nòstri nòni, cui ch’i son nà prima ‘d noi, e che tanc i son za mòrt, e ch’i n’han dà la vita ant is paìs, e ch’i n’han lassà is paìs con la so blëssa e la so richëssa da manteni, e con n’unur da difendi. Perché anlura Anon l’era in gran paìs. …
… E pô sa gent l’ava na gran qualità, na qualità che cui d’Anon i j’han ancora adess, e i l’auran sempra: i eru dla gran brava gent, dla gent sèmpia, onesta e alegra, ch’i savu vivi e ch’i lassavu vivi, e che is aurivu ben tra ‘d lur cmé di fradé.
E adess ancora l’è acsë. L’è per su-lë che noi oma pensà ‘d fondé ista «Famëja Anunèisa», an uanda ticc i bon anunèis i pôrit truvé u so post, per travajé ticc ansema per al ben du nòst paìs.
Ancora introdotto da Pinin Pacòt, con firna G. P. il capitolo che Goffredo Casalis nel 1833 ha dedicato a Castello d’Annone nel suo Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna.
Seguono due liriche in italiano di Annamaria Salanitri delle quali la prima dedicata ad Annone: Sera al mio paese e Sogni.
Poi un pezzo dedicato Agli Annonesi sparsi nel mondo a firma F. V. e le due poesie di Pacòt in dialetto annonese:
ut rëj ant j’òcc, ch’i son csë sclènt e pir
e ch’im uardu pi dricc e pi sighir
che ant l’ària blòra ‘l vòl d’na rundanën-na.
Quand ch’a son stanch am ferm a la fontan-na.
e am bèiv u sel ant l’eua ciara e pian-na,
uanda ‘l me sôgn sempra pi àut al vòla,
parëgg d’na cita rundanën-na fòla.
L’è nivu là an sla Ròca,
l’é sclènt ansima a Non :
ina stèila la dròca,
us leva ina canson.
Al stèili i son là d’ sura,
e i giuvu an mez al pra
i cantu per la sgnura
ina canson ch’la va,
ch’la va së fina al stèili
ch’i rëju an mez dla nòcc,
cme a l’ombra dal parpèili
i rëju i tò bei òcc.
Quindi, sempre di Pinin Pacòt, firmato G. P. un ritratto del pittore annonese Padre Angelico Pistarino. Tralasciando un paio di pagine di interesse locale, arrivo alla bella poesia, sempre di Pacòt, in schietto dialetto annonese dedicata al suo paesello:
A Non u i è in castè,
u i è in casté ch’l’è bel,
Tani u ja scur ai pe
e d’ sura uj rëj u sel.
L’è dricc an s’u so brich
dnans a in parfond d’ culën-ni,
is bel casté antich
sfiurà dal rundanën-ni.
L’è dricc an sla me mènt
s’ caste sensa castlan-na,
d’antorn uj bifa ‘l vent
ch’al monta së dla pian-na.
Casté senza miraji
piantà an mez dal drucheri,
uanda ch’i son sarai
titi ‘l me bel driveri.
Me bel casté d’Anon,
s’vigromli ancù na vira?
I son luntan, i son,
j’istà dla giuventura,
quand che travers al vigni
curivu tit u dë,
a rubé i pèrsi e ‘l brigni
s’i brich d’antorn a të,
ò andavu an riva a Tani
a nué ze di mulën,
ò an mez ai bòsch e al cani
sparivu cme di fuën;
me bel casté, passaja
l’è sa giurnà fiurëja,
cme ‘l sôgn d’ina cuëntaja
che ‘nt in nen l’è finëja.
Adess son in pòvr òm
e a sô pi nen còs fé,
dal viri a digh in nòm
e u ma smëja ‘d turné…
Turné! Ma quand? Ma uanda ?
Pudissa, ch’a sô nen!
Quand che më rjiva andanda
e ticc m’aurivu ben.
Së! Ch’a turnrava ancora
me bel casté d’Anon,
a cui bei temp d’anlura,
ch’i son passà, ch’i son…
I é mi msé, i é mi nòna
ch’i dromu vsën a të,
ma quë i è la me dòna
ch’la marcia ansima a më.
Sô nen uanda ch’andoma,
uanda ch’la va la stra…
sô nen se al fond s’ truvroma,
casté di sôgn passà.
Dopo una paginetta di storia locale La miraja a firma Luigi Rasetti, ecco ancora una poesia di Pinin del 1917, questa volta in lingua, sempre dedicata al suo paese:
dilegua, ove sol più muòvonsi ai venti
gli snelli pioppi in larghi ondeggiamenti,
io riveggo l’antica ghibellina
rocca innalzar sulla scoscesa china
le rosse torri, simili a possenti
braccia protese contro le fuggenti
nuvole e i neri uccelli di rapina.
Vaniscono le forme nella luce
del vespro incerta: il sogno lievemente
la tristezza dell’ora riconduce,
e un’incantata io sogno ariostesca
rocca, dove si svolga una ridente
bellissima epopea cavalleresca.
Di Luciana Brusisco segue il pezzo da cui ha preso spunto questo scritto L’angolo della donna: La moda femminile annonese di un secolo fa accompagnato dal disegno di Felice Vellan
e a proposito del pittore Vellan, l’amico Giovanni Bevilacqua mi ha fatto notare che un suo vezzo è di inserire in ogni disegno un animaletto, come ben si può vedere nelle incisioni che ornano questo scritto.
Due brevi racconti ancora di Annamaria Salanitri e, quindi, a concludere il quaderno, Un amico di Annone: Mario Soldati di Pinin Pacòt:
Mario Soldati si è fermato ad Annone. Nulla di straordinario per un qualsiasi altro viaggiatore. Che si sarebbe ristorato, avrebbe pagato, lasciata la mancia e sarebbe ripartito, riverito o insalutato ospite, per Torino o per Genova. Mario Sodati invece è un poeta. Un poeta che non scrive versi (o che almeno non ne pubblica), ma la cui opera di scrittore e di regista tutta si svolge sotto il segno della poesia.
Ebbene, i poeti vedono le cose in modo diverso dai comuni mortali, e a volte ciò che per questi è assolutamente insignificante, acquista ai loro occhi una straordinaria importanza. Ciò che può anche far sorridere. Così per il buon annonese, la cui attività è tutta concentrata nel lavoro e nei suoi desiderati frutti, la fantasia di un Mario Soldati, che, diretto in macchina a Torino, dopo aver sorpassato il paese, sorpreso dalla bellezza di quel piccolo avvallamento della collina, tra la statale e Tani mòrt, che è l’Anchërna, si ferma, ritorna in Annone e, parcheggiata l’automobile, se ne va a passeggiare solo solo in riva al Tanaro, e di colpo si innamora del nostro paese, come di un luogo a lui caro da molti anni: può ben sembrare una fantasia da poeta. Poeta nel senso popolare, cioè di strambo, di bizzarro, di tocco. Chiel-lì a l’è un po’ poeta, si dice appunto in Piemonte.
Veramente un po’ di questa stramberia c’è in tutti i poeti. La poesia non è cosa comune, non è normale. Però, c’è qualcosa di più, nell’autentica poesia: c’è il senso magico della vita che trasforma le cose, le fa grandi se sono piccole, le rende belle quando non lo sono, e dà loro un valore che non avevano. Magìa bianca, che rende bella la vita, e degna di essere vissuta, perché in ogni minima cosa che la natura o l’uomo o le vicende ci offrono, scopre un conforto e un aiuto.
Così Mario Soldati, viaggiatore errante da continente a continente, a volte smarrito in questo mondo moderno, ch’egli domina, ma non è il suo, e che lo assilla, lo spinge e lo costringe ad un lavoro senza tregua, trascinandolo nel giro dei suoi impegni: d’un tratto è colpito dalla dolcezza georgica di un fondale naturale, e sente il bisogno di fermarsi, anche per poco, e godere della serenità di un’epoca ormai passata, e qui ritrovata, miracolosamente, per caso. Ondeggiare di colline, qui dense di gaggie e castagni, là ornate di vigneti e di prati e di campi, e il fiume lento a pigri meandri nella valle deserta nel sole, e il paese tranquillo, eccezionalmente silenzioso, e molta ombra sotto il pergolato, nella calda giornata estiva. Ecco l’incantesimo. Ed ecco il poeta adagiato nella tregua inaspettata. Poi, riprenderà la sua strada verso le vertigini allucinanti dei grattacieli ondeggianti come alberi di navi sulle città tentacolari.
Intanto il suo istinto di poeta l’ha fermato nel luogo propizio alle sue fantasie. Fantasie che, innestandosi nella realtà, permettono alla sua intuizione di penetrare più a fondo nella vita, districandone la matassa con la sua acuta penetrazione psicologica e, soprattutto, con la sua viva simpatia umana. Basta scorrere (ma sarà meglio leggere) l’ultimo volume di Mario Soldati, «La Messa dei villeggianti» (Edizioni Mondadori), vivace raccolta di elzeviri di terza pagina, ch’io non chiamerei bozzetti, per quanto un po’ di De Amicis sia rimasto in questo libro fondamentalmente buono, ma poesie in prosa, petits poèmes en prose, per il loro ritmo segreto e la loro suggestione penetrante; per avere la conferma delle qualità di Soldati, qualità che convergono verso quel senso magico della vita, che ho detto, e che è il sustrato appunto della sua poesia, nella quale si placano le intime contraddizioni dell’uomo, e il rimorso di ciò che non è stato si trasforma in dolcezza.
In Annone egli si trova come in casa sua, questo autentico piemontese, sempre in esilio, ma non mai estraniato, e le persone che incontra diventano suoi amici. Scalarini che per primo lo inizia alla vita segreta di Annone; e poi il povero Ettore Perlino, la cui ricca anima educata allo studio e alla riflessione, viene subito intuita dallo scrittore che lo comprende e istintivamente con lui simpatizza, mentre «sotto l’ombra verde e gialla del pergolato, nella quiete meridiana e campagnola, davanti alla tovaglia lietamente macchiata di barbera, guarda negli occhi azzurri, nel volto del suo interlocutore, luminoso di onestà e di intelligenza».
Magìa della poesia, che non soltanto rivela la bellezza, ma scopre e illumina la verità; per virtù rabdomantica. Onesto, intelligente, colto, geniale, era veramente Ettore, che Mario Soldati aveva capito, nella semplice conversazione che si aggirava intorno al pane di Annone, al suo modo di cuocerlo e alla bontà del suo sapore quando è raffermo da un paio di giorni: «Pan ëd doi di, bota ‘d doi ani, fija ‘d vint ani». E a conclusione la saggezza proverbiale del popolo.
Il ritorno alla terra, per le anime ricche di bontà e di poesia, è sempre fonte di sorprese sentimentali e spirituali. Mario Sodati, era ritornato nel suo Piemonte, e se ne era commosso. Ascoltiamo le sue parole, veramente sue: «E pensavo che il mio paese è il paese più umano e più giusto del mondo. E che bisognerebbe girarlo umilmente a piedi, o tutt’al più in bicicletta: e scoprirlo così, conoscerlo così, fermandosi in ogni villaggio, senza seguire nessun programma, nessun orario, nessuna pubblicità, nessuna moda: guidati soltanto dalle genuine curiosità, mossi soltanto dall’amore».
Il secondo scartari, come anticipato, contiene piccole ricerche, poesiole che i bimbi delle classi elementari di Castello d’Annone e di Rocchetta Tanaro hanno dedicato a Pinin Pacòt ed al loro paese.
Dalle parole di introduzione dell’allora sindaco di Castello d’Annone Francesco Mai estraggo qualche brano a migliore comprensione dello scopo di questo secondo opuscolo annonese.
Con il titolo di questo libro ci si è voluti riallacciare simbolicamente a quello «scartari» che per volere e sotto la direzione di Pinin Pacòt, fu pubblicato più di vent’anni fa e che sicuramente si trova ancora adesso in molte case di Annone.
Pacòt dunque, sempre Pacòt.
… nel giugno del ’77 fu lanciato l’invito a tutti a collaborare, con poesie e scritti, per rendere omaggio a Pacòt, e fu altresì un invito a rivedere il dialetto non più come un modo di esprimerci superato ed anacronistico, ma come un linguaggio vivo che non si può abbandonare se non si vuole perdere per sempre una cultura fatta magari di piccole cose, ma che racchiude in sé l’essenza delle nostre tradizioni.
La raccolta contenuta nelle pagine seguenti vuole dunque essere innanzitutto questo e non una gara di poesie dialettali o un’esibizione di componimenti e notizie riguardanti fatti del paese di Annone.
È facile infatti rendersi conto di come canoni e metrica poetica siano del tutto assenti da queste poesiole, che spesso risultano addirittura scritte in un dialetto ibrido o perlomeno alquanto impuro, mentre è sempre dominante la spontaneità, l’immediatezza e il candore con cui i bambini hanno saputo esprimere impressioni e sentimenti. Ricordiamo che nessuno di questi fanciulli ha conosciuto personalmente Pinin Pacòt e che solo una ricerca minuziosa e accurata può aver loro consentito di raccogliere notizie così disparate sul paese e sulle sue tradizioni; per non intaccare minimamente freschezza e genuinità, nelle pagine che seguono si è voluto perciò lasciare integri i testi così come i bambini stessi li hanno composti, anche se a volte verrà da sorridere per alcune inesattezze o banalità che senza dubbio arricchiscono, anziché sminuire, l’originalità delle composizioni.
Riporto qui di seguito alcuni dei brani che i bimbi di Annone hanno dedicato a Pinin Pacòt, scelti tra quelli che offrono qualche piccolo ragguaglio sulla vita di Pacòt in quel di Annone. Tralascio volutamente, anche se più ricchi di particolari, quelli che risultano, con evidenza, di farina non tutta appartenente allo scolaro.
Il poeta Pinin Pacòt durante la guerra sfollò in Annone e qui si costruì una casa. Essendo un uomo molto serio, riservato e studioso, faceva spola fra Annone e Torino e qui fondò il giornale «Ij Brandè»; peccato, perché quando morì lui il giornale cessò di essere scritto.
Scriveva anche molte poesie in dialetto. Fu apprezzato in tutta Italia per le sue poesie; solo nel paese che lui prediligeva non aveva la stessa stima che gli davano tutti gli altri.
Fu tenente dell’esercito Italiano e fu anche ragioniere della banca San Paolo di Torino. Fu sindaco di Annone dal 1960 fino alla sua morte avvenuta il 16-12-1964.
In questi giorni ho ascoltato delle poesie di Pinin Pacòt, che mi ha letto la mamma.
Sono tutte belle e piene di sentimento. Nelle sue poesie il poeta ricorda spesso con nostalgia, i giorni della sua fanciullezza che trascorreva ad Annone, nella casa dei suoi nonni.
A me piace tanto la poesia intitolata «Ant côla casota tranquila» che incomincia così:
«Ant côla casota tranquila,
ch’a deurm ans ij pe dla côlin-a,
anssema a mia bela nôniña
i l’ai vivù ‘l seugn d’ mie pi care giôrnà.»
(la grafia della poesia l’ho riportata a quella originale di Pacòt a pag. 45 di Arssivoli pubblicato nel 1926. Quindi non con la grafia cosiddetta Pacòt-Viglongo che utilizzerà a partire dal 1930)
Pinin Pacòt nacque a Castello d’Annone; suo padre era un modesto orologiaio. Egli portava nelle vene il delicato sangue torinese del padre e quello robusto, campagnolo di Mamma Adorno.
Fabio Agostinetto – Roberto Pederzani – Cristian Bella
Sua mamma si chiamava Margherita Adorno ed era Annonese. Abitava, al borgo, in via XX Settembre n. 25, ed era appassionato di piante, e passava molte ore nel suo giardino.
Pinin Pacotto aveva un cane che si chiamava Frida, con esso andava a passeggio lungo il Tanaro e per lo stradale verso Alessandria.
Per la sua cultura e bontà ha avuto dal ministro Pella la medaglia d’oro.
Per onorare la sua lingua si faceva chiamare Pinin Pacòt, e la gente gli dava del tu.
Sua figlia si chiama Maria Speranza e sua nipote si chiama Paola. Sua figlia abita a Padova. Egli morì d’infarto nel 1964, sulla sua lapide vi è scritto in piemontese
«O seugn mi it desfeujo parei ed na reusa»
Romilda Pappano
Uno dei più illustri personaggi di Castello d’Annone, è stato Pinin Pacòt.
Egli era un uomo saggio e molto intelligente; abitava nella città di Torino, ma trascorreva ogni vacanza nel nostro piccolo paese. Era amico di tutti, amava la pace e voleva che anche gli altri come lui fossero sinceri.
Per lui Castello d’Annone era una piccola Patria; e conosceva ogni cosa che lo interessava. Sapeva che la gente del luogo aveva molto sofferto specialmente dopo la guerra, ed ha voluto farlo sapere alla nuova generazione, scrivendo racconti e numerose poesie in dialetto piemontese.
Era organizzatore di divertimenti e sport. Faceva divertire così i giovani e gli anziani.
Purtroppo, però, ora non è più con noi. La morte lo ha colto all’improvviso, ma ci ha rivelato i segreti di questo paese.
Piemontèis ancheuj, Ann 35~36 N° 9 stèmber 2017 ~ N° 6 giugn 2018 (10 puntate)
Teresio Rovere
Torino 22 giugno 1891 ~ 6 maggio 1964
Introduzione
Un poeta piemontese, purtroppo poco noto, facente parte della originaria Companìa dij Brandè è Teresio Antonio Evasio Emilio Rovere. Dal numero 14 della rivista di Luigi Olivero Ël Tòr del 27 aprile 1946, traggo, dalla rubrica I nòstri poeta coma ch'as vedo, questo Autoritràt. Ad onor del vero l'autoritràt, a giudicare dallo stile della composizione, sembra più di Luigi Olivero che di Teresio Rovere; sia come sia, eccolo:
Teresio Antonio Evasio Emilio Rovere, nato a Torino il 22 giugno del 1891 e non ancora morto. Non possiede nessun titolo di studio, e, come libero studioso, studiò sempre - e continua - regolarmente fuori della scuola. Vita semplice, sovente durissima, sempre limpida, senza fatti sensazionali. Fisso il chiodo nel cervello di avere qualche cosa da dire: soprattutto un incitamento ai compagni bipedi sotto la luna perché si comprendano e si tòllerino, non si idòleggino l'un l'altro e perché si rendano degni del fenomeno vita.
Figura nell'ultima edizione del Chi è? (Dizionario degli Italiani d'oggi, Roma). Nella gaia terra delle gazzarre e dei limoni, dove tutti vogliono più parere che essere, ha anche scritto - come negro della penna - una dozzina di monografie d'arte con la firma di altri e collaborato «in incognito» all'Enciclopedia Italiana Treccani. Collaborò a Dizionari, Enciclopedie, Riviste e Giornali... Pubblicò anche una Storia universale dell'Arte (Editori Associati, Torino, 1938) Vol. I 640 pagg. e parte del II ed ultimo volume, ed a tutt'oggi incompiuta, non come stesura ma come stampa. E pensa di pubblicare altro.
Riproduco la poesia di Rovere che affianca l'articolo:
Autoritràt
Né 'l pericol, né 'l malheur
A l'àn mai cambiame 'l cheur.
ANGELO BROFFERIO
Na facia smòrta che mes secol 'd vita
e ij magon e le lòte a l'han scavà;
un seugn che gnun malheur l'ha cancelà,
gnanca ij luv ò ij pajasso ampastà 'd nita.
I l'hai sempre marcià 'n sla stra pi drita,
pòver e silenssios, e l'hai studià
për conòsse pì a fond l'umanità,
për nen sgairé 'l regal divin dla vita.
Anche adess che 'l tramont ormai s'avsin-a
e a pòch a pòch svanisso ij desideri,
carësso 'l seugn d'amor, 'd fraternità...
e l'ilusion che, quandi seur Catlin-a
am porterà dë 'd là 'nt ël gran misteri,
na fiama 'd poesia am survivrà.
8~14 febbraio 1946
Teresio Rovere nel 1961 ottiene la cittadinanza onoraria da parte del Comune di Castellamonte per la decisione di donargli la sua biblioteca di oltre 4.000 volumi, tutte le sue carte e la raccolta d'arte contemporanea
(pittura, incisione, disegno e scultura) contenente tra l'altro molte opere dell'amico fraterno Ercole Dogliani (tra le quali, catalogate, tutte le incisioni realizzate). Decisione maturata per le pressioni di Ferruccio De Marchi che l'aveva accolto a Castellamonte dopo la sua fuga da Torino per evitare l'arresto da parte dei militari tedeschi e della milizia repubblicana quale membro del secondo C.L.N piemontese, e sotto la stimolo dello scrittore e giornalista Carlo Trabucco, al momento sindaco della città. (2)
Più volte mi sono recato a Castellamonte per consultare parte della Donazione Rovere. Questa contiene un piccolo carteggio con l'amico Nino Costa ed uno, consistente, con la zia Maria Dessy e i cugini che poi emigreranno in America Latina. In quest'ultimo carteggio come per tutta la corrispondenza conservata, cartoline escluse, si affiancano alle lettere ricevute le copie, dattiloscritte, di tutte le risposte di Rovere. Una miriade di notizie che permettono di tracciare un profilo umanissimo delle sue vicissitudini terrene.
La vita
Poco nulla sui primi anni della sua vita. In pratica solo quanto da lui scritto nel suo autoritratto. Nessun titolo di studio salvo il suo grandissimo amore ed interesse per tutto quanto è cultura che lo accompagnerà sempre. Vita semplice e spesso molto dura come vedremo.
Inizia la sua opera poetica intorno al 1908 e in una lettera del 19 novembre del 1916 diretta alla zia Maria Dessy scrive:
A te, che sola, forse comprendi ed apprezzi i miei lavori, invio questo frammento d'un mio poema incompiuto. Dico te sola, perché tutti i miei parenti sono a riguardo delle mie tendenze letterarie irriducibili, vale a dire che non le prendono sul serio, a cominciare da mio padre. Solo mie sorelle si sforzano di comprendermi ed hanno un pò di rispetto per i miei lavori. Questi versi che ti mando li ho corretti e stampati a macchina, ma sono del 1911. Puoi vedere di conseguenza, com'io già sin d'allora prevedessi, o meglio, non escludessi l'odierno misfatto, l'odierno fiume rosso. Questi pochi endecasillabi costituiscono il documento tangibile di un mio progetto caduto: "IL POEMA DEL MACIGNO", ideato appunto nei primi mesi del 1911. Anche questo un sogno, che tirannia di tempo e piccolezza tormentosa di eventi m'hanno vietato di realizzare, e perciò s'è infranto come tante cose mie. Adesso che siamo nell'agonia del 1916, ricordo i due sonetti ch'io scrissi per l'anno in corso e constato, non senza un intimo e doloroso compiacimento, come il mio monito e la mia previsione si siano avverati. Lavoro molto, ma sinora ho fatto pochissimo per la fine del Poema di guerra.
tuo nipote Teresio Rovere
Chiamato a servire la patria, scrive alla zia, a guerra finita, il 13 marzo del 1919, ancora militare al lavoro in fureria:
Sono gli ultimi giorni che posso usufruire della macchina e puoi comprendere facilmente com'io la usi e tiri copie di lavori vecchi e nuovi, correggendo, rivedendo, ordinando. Prima della fine di Marzo spero d'essere definitivamente a casa in licenza illimitata che è uguale ad un congedo, specialmente per me che sono inabile permanente alle fatiche di guerra. ... Ho corretto gli ultimi versi che avevo ancora da correggere (roba del 1908 e 1910) fra i quali v'ha un sonetto sull'ultimo meriggio che abbiamo passato a Trofarello con mamma. ... Vedrai da questa lettera com'io non sia più il Teresio d'un tempo, come non sia più capace di correggere le mie lettere di qualche verso sia pure mal riuscito. Ma se non ho più l'entusiasmo di un tempo, conservo sempre la mia volontà ferrea, e se non faccio del nuovo, tento almeno di divulgare il già fatto. Indubbiamente sono un pò stanco, gli ultimi fatti della mia vita, anche se non capitali, (servizio militare - ombra consueta - l'incognita del domani), m'hanno prostrato qualche pò.
Proprio come scrive alla zia inizia a collaborare con riviste e giornali quali Il venerdì della contessa, Torino (Rassegna del Comune di Torino), Rivista d'Arte A B C.
Dà alle stampe alcuni suoi lavori poetici dedicati a coppie di sposi amici di famiglia: Nuptalia del 1922, Visioni del viandante del 1925. Queste sue prime opere sono pubblicate presso lo Stabilimento Grafico Foà in seguito L'impronta, dai torchi del quale usciranno praticamente tutte le opere successive del Rovere. Un breve cenno è d'obbligo per lo stampatore e proprietario, Terenzio Grandi (1884~1981). A Valenza come apprendista tipografo, poi a Torino alla tipografia Risveglio per ben 18 anni fino alla fondazione della sua casa editrice nel 1919 che tenne, dal 1938 con marchio L'impronta, fino al 1963 quando la cedette per dedicarsi più completamente alla sua attività di storico. Fin da giovane, mazziniano convinto condividendone l'ideale repubblicano e l'internazionalismo, aderì al Partito Repubblicano di cui fu spesso segretario della sezione torinese. Fu militante attivo secondo il motto mazziniano pensiero e azione. Pacifista, accettò come ineluttabile la partecipazione dell'Italia alla guerra nel 1915 per l'affermazione della democrazia e della pace in Europa. Si dedicò sempre alla pubblicistica e agli studi risorgimentali; fondò e diresse parecchi giornali, tutti chiusi in breve per questioni finanziarie (L'emancipazione, La ragione della domenica, La risposta, La Nuova Coscienza. Dal 1946 diresse Il Pensiero mazziniano che alla sua morte dedicò l'intero numero del luglio-agosto 1981). Tra Rovere e il Grandi nasce una grande amicizia testimoniata dal folto carteggio tra i due esistente presso la Biblioteca del Museo del Risorgimento di Torino dal quale ho attinto numerose notizie. (3)
Di questo periodo è la conoscenza e la collaborazione con Pinin Pacòt e La Companìa dij Brandé.
Il suo primo contributo poetico al lavoro di Pacòt si trova nell'antologia A Mistral (Diciasette "sic" poeti piemontesi) pubblicata dalla S.E.L.P. Studio Librario Editoriale Piemontese di Andrea Viglongo nel 1931. Così viene presentato:
Nà a Turin 'l 14 giugno dël 1891. A l'ha stampà an italian Le Visioni del Viandante, ses sonèt con di bòsch d'Ercole Dogliani e tre plaquettes, fòra comersi, d'cò d' sonèt: Al tempo e alla speranza (In morte di Luigi Rovere); I sonetti delle colline; I sonetti della morte e delle rose. An piemontèis a promèt un volum ëd poesìe. Collaborassion a vaire giornai e arviste.
Due sono le sue poesie qui presenti. La lunghissima La Sagra d' San Michel (An slë scalon di mòrt) (15 quartine per un totale di 60 versi) in coda all'articolo e Montagne qui sotto:
Montagne
A la memòria d'Ercole Dogliani
Ò bele e candie an vers al cel, montagne,
seure d' pera di seugn dl'anacoreta,
canson eterne che n'etern poeta
a canta an sla dësteisa dle campagne.
Solitarie ant la neuit, pure montagne,
regn dj'àquile e di vent, ùnica meta
d' chi ch'a veul andé d' sora dla sospeta
vita dla bassa e d' tute le mangagne.
Coma n'inmensa catedral tajà
'nt la pera, con j'autar fait ëd giassé
e con i rag dla luna për candèile;
mi v'adòro ant le neuit ciaire d'istà,
quand che dj'òmini a tas ël bustiché,
e ansema a mi i ciaciare con le stèile.
8 d'agost dël 1930 - Aosta
Trovo poi una sua poesia nell'Armanach piemontèis per il 1931:
Invern
Son le giornà d'invern piovose e scure
che a riciamo a la ment le veje stòrie,
e le faule dle streghe e le memòrie
pì bele dël passà, lontane e pure.
As sente travers a l'aria ùmida e trista
come un përfum sperdù d' violëtte e d' reuse...
Le fòsse, sot la fiòca, as smio pi creuse,
e 'n cel ël gris a massa l'ametista.
J'erbo a fan pena. A l'han pi nen na feuja;
a strenz ël cheur a vëddje patanù
ant l'aria freida, con i brass stendù
parèj d' n'invocassion. La tèra speuja
a l'è la mama bona che a prepara
ant sò segret ël pan, regal etern,
mentre, a la sosta 'nt lë sciopé dl'invern,
sentoma 'l bòsch che d' sora al feu ciaciara.
Fòra, an campagna, a smìa ch'a piora 'l rol;
con chiel, tute le piante dëspujà
a ciamo, a crijo, a prego disperà
ant sò linguagi: dene un rag ëd sol.
Nell'Armanach piemontèis per il 1932 è la poesia Aniverssari 1900-21-XI-1931 con dedica alle due sorelle Ninin e Maria. La lunga (60 versi in 15 quartine) e struggente poesia è tutta dedicata all'infinito amore che Teresio provava e prova per l'adorata mamma e alla riconoscenza per le due sorelle che per lui da mamma hanno fatto.
Aniversari
1900~21~IX~1931
A Ninin e Maria
Trista memoria, Stember dël neuvsent,
prim dì d'autunn pien ë côlôr ëd fruta,
ancôra dop tant temp a seufr e a sent
me cheur côla giôrnà për mi tant bruta.
Mama, vôrrïa scrivte una canssôn
côla che a viv an mi, che l'hai mai scrit,
dite la sempre pura mia afessiôn,
parlete ancôra côma fussa un cit;
parlete pian, côntete i me tôrment
che ti sôla 't pôdrïe cônfôrté,
carëssa 'd mama a pasia i sentiment,
parola 'd mama anvita a perdôné.
Pochi dì... poche neuit...Una carëssa
ùltima, côn 'd man caôde 'd frev e 'd mal...
«Ciaô gioia», ùltim salut côn tenerëssa...
peui ël deliri e l'agônìa fatal...
Povre sôrele trasôrmà 'n mamiñe,
pover papà, 'n mes al dôlôr tant fort,
oh, l'hai prôvaje prest, mi, le ruviñe,
la tragedia 'd l'assenssa e 'l freid 'd la mort.
A j'è pi nen tôa tômba, o povra mama,
ma j'è 'nt l'aria ël lament d'un arsigneul,
ma an mi l'è sempre viva la tôa fiama,
la tômba 'd mama a l'è 'nt ël cheur dël fieul.
E ti 't vive , memoria 'd le memorie,
spirit e sangh, amôr e devôssiôn,
dzôra 'd le crôs ëd marmô, inutii borie,
aôta dë dlà d'i dubi e dle passiôn.
Quand pi la vita am grôpa, e a massa an mi
côla veña 'd canssôn che ti 't l'has dame,
o mama, o mama, i tôrnô sempre a ti,
e 'l to pensè am desvïa 'd neuve fiame.
Quand le tempeste e i crussi am piegô e a smija
che a sïa neir ël cel e veuid ël cheur,
l'è ancôr la tôa memoria, o mama mia
che am dà la forssa a cômbate ogni maleur.
E seugnô che t'ëm teñe ancôr për man
ant le crôsiere për pareme ël mal,
e seugnô che t'ëm taje ancôra ël pan
ant la scudela un lôntan dì 'd Natal...
O mama, che 't l'has nen cônssù mia spôsa,
o mama, che vorrïa avei davsin,
côsì sentrïa menô fatigôsa
la bataja 'd la vita e dël destin;
côme anlôra ogni seira mi 't salutô
«o mama, ciaô, deurm bin», e lôngh la neuit
quand che tut a l'è pasi, tut l'è ciutô,
côme côl dì mi sentô ancôra ël veuid...
Ogn'ann, a Stèmber, sôta tôa figura,
j'ùltime reuse at pôrto me tribut,
côl dì l'anima mïa as sent pi pura,
e la parola am seurt côme un sangiut.
La Magna d'or, la môstra che at piasìa,
l'ha batù l'ôra trista 'd la tôa mort,
jë vnirà un dì che a batrà 'd co la mïa,
fa, mama, che côl dì mi sïa fort.
E quand côla che tut a piega e a scianta
am sarerà 'nt i ripôsant so brass,
o mama bela, o mïa mama santa,
mi lô sentô, lô sentô, it tôrnerass.
27 settembre 1931 Teresio Rovere
d'la Companìa d'ij Brandé
Interessante la precisazione che segue la firma in calce alla poesia: Pinin Pacòt per la pubblicazione dell'Armanach piemontèis per il 1932 si è trovato in ristrettezze finanziarie tanto da dover ricorrere all'aiuto, per la pubblicazione, della Famija Turinèisa che in cambio ha preteso l'inserimento dei suoi poeti ed il ritorno alla grafia classica del suo giornale: il Caval 'd brons. Per distinguersi i poeti della cerchia di Pacòt hanno aggiunto in calce al proprio nome d'la Companìa d'ij Brandé. Nella grafia della poesia ritornano pertanto le ô, le ñ ed altre diversità con la cosiddetta grafia unificata Pacòt-Viglongo già adottata da Ij Brandé.
Qui cessa la collaborazione con Pacòt. Nei successivi Armanach più nulla di Rovere che scriverà nuovamente per Pinin alla rinascita della rivista Ij Brandé molti anni dopo, nel 1949.
Di questo periodo altre lettere indirizzate alla zia:
Torino, Pasqua di Resurrezione del 1935
Carissima zia,
Rompo il mio annoso silenzio senza scusarmi. Ho sempre avuto nel cuore te e i tuoi, se non ho più avuto l'animo di scriverti, seppure ho dovuto scrivere moltissimo - vero facchino della penna - per Enciclopedie, Dizionari e Riviste, con risultati pecuniari sconfortanti. ... Ho attraversato - e continuo ad attraversare - giornate durissime. Non mi perdo d'animo, ma certe volte ho l'impressione che la forza d'animo non mi basti più. La finale d'un mio sonetto:
solo conforto fra la sofferenza:
l'ala del canto eterna ed infinita.
(seppure la fonte è pressoché inaridita) risponde ad una verità palpitante. Non ho nulla da rimproverarmi, salvo che d'aver avuto molta sfortuna e d'essere stato troppo ingenuo tra i lupi. Mi sono improvvisato collaboratore enciclopedico, articolista, revisore tipografico, spedizioniere, archivista; ora vegeto - o più propriamente - soffoco quale aiuto di un avvocato nell'UFFICIO LEGALE della Casa Editrice UNIONE TIPOGRAFICO EDITRICE TORINESE, con uno stipendio pietoso e un orario da manovale. Non per me ne soffro ma per la mia Emilia che ha virtù di adattamento eroiche e fa miracoli di acrobazia economica e nulla chiede; e per le mie sorelle che mi furono e mi sono larghissime d'aiuto, privandosi loro stesse. Quando potrò, non rendere, ma compensare affettuosamente e tangibilmente tanto sacrificio?... Molti artisti e scrittori che conosco e hanno per me deferenza e ammirazione, si interessano per trovarmi una sistemazione dignitosa, più rispondente al mio temperamento (come viaggiatore o scrittore) che mi permetta di vivere e di assolvere le promesse, e faccia sì che il vocabolo riconoscenza non abbia ad essere lettera morta nel mio dizionario. Attualmente, purtroppo, tutto ciò non è che allo stato di pie intenzioni, di quelle buone intenzioni di cui è lastricato l'inferno. Da quattr'anni, salvo la vicinanza della mia sposa e delle mie sorelle per le quali vivo, nessun raggio di sole s'è acceso sul mio cammino. E non dispero ancora.
Rovere chiude la missiva con due richieste alla zia. La prima di cercargli ed inviargli un qualche dizionario degli artisti di Spagna e dell'America Latina od anche una storia dell'arte possibilmente ricca di buone riproduzioni, il che sarebbe prezioso aiuto per la collaborazione a dizionari ed enciclopedie sull'arte. La seconda richiesta accompagnerà molte altre sue lettere. Il marito della zia, Vittorio Dessy ha composto un'edizione del Decameron di Giovanni Boccaccio in ottava rima. Teresio ha parte del manoscritto che gli interessa dare alle stampe in ricordo dello zio. Gli mancano però i testi di otto giornate che continuerà insistentemente a richiedere.
Altra lettera alla zia il 7 settembre dello stesso 1935. Ha ricevuto 5 delle giornate mancanti del Decamerone in rima dello zio Vittorio. Chiede ancora insistentemente le ultime tre giornate. Invia alla zia due suoi articoli:
... uno sul GATTO NELLA POESIA E NELL'ARTE e l'altro sul PONTE IN PIETRA SUL PO ED I SUOI ANTENATI. Il primo è una specie di apologia dell'animale da me prediletto, il secondo è una rievocazione della vecchia Torino, dove faccio anche parola di quel sobborgo del MOSCHIN che indubbiamente tu ricorderai. (Rivista d'arte A.B.C., Torino, luglio e settembre 1935, Il gatto nella poesia e nell'arte; ottobre 1935, Torino or è molt'anni...)
Di me nulla di sostanzialmente nuovo. Lavoro con freddo sforzo di volontà per districarmi dagli arretrati di pigione e d'altra natura....
La poesia è più soffocata che estinta. Dopo quella per mia madre, scritta in vernacolo nell'autunno del 1931 non ne ho più scritte. (Pubblicata nell'Armanach per il 1932 con titolo Anniversari a ricordo dei 30 anni trascorsi dalla morte della madre - N.d.A.)
Un piccolo epistolario con Nino Costa mette in luce i rapporti tra i due poeti. Rovere invia a Costa per averne un giudizio il suo Carme eroico per il folle impuro. Costa scrive in data 10 gennaio 1937 su carta intestata della Cassa di Risparmio di Torino:
Ho ricevuto oggi il suo carme e la ringrazio d'essersi ricordato di me in una forma così gentile e significativa. Ho letto e riletto i suoi versi meditati e pensosi. Il tema arduo e singolare è stato affrontato con audacia e svolto con piena conoscenza di quell'altissimo spirito ancora mal noto o ignorato affatto a tanti che presumono ancora per la maggiore.
Atmosfera lirica non consueta alla maggior parte dei versaioli odierni che pure osano nominarsi poeti.
Tormentosa e vibrante l'invocazione alle alpi dolomitiche, le sole degne nella loro dantesca maestà di raccogliere l'anelito di poesìa che fu la fiamma e la luce di quel grande infelice.
Mi auguro di poter un giorno, non lontano, incontrarla e parlare con lei a lungo delle nostre speranze tramontate, e delle nostre speranze risorgenti. Mi conservi la sua amicizia, molto per me più cara di quanto forse lei creda.
Suo Nino Costa
In data 17 gennaio Rovere risponde:
Egregio e caro Prof. NINO COSTA
Fra le molte lettere e consensi che ho ricevuto per il CARME EROICO PER IL FOLLE IMPURO, Le dico molto francamente che la Sua, oltre all'essermi particolarmente gradita, è stata la più comprensiva. A tutti, o quasi, è piaciuta l'Invocazione alle montagne, ma anche nessuno o quasi ha, come Lei, capito che le altezze dolomitiche erano, nel pensiero dello scrittore, l'unico termine di paragone con lo spirito di Nietsche.
Anch'io ho desiderio di incontrarLa e di conversare di molte cose. Anzitutto dirLe il mio disgusto per certe inconsiderate pagine (per non chiamarle con più crudi ed appropriati vocaboli) che ho lette su una pubblicazione che non torna certo ad onore della letteratura vernacola. E per constatare che alle speranze tramontate è possibile sostituirne altre, che è ventura dei poeti il non estinguere mai la spirituale sorgente della speranza. E per dirLe che sono sempre stato comprensivo e apologeta della Sua poesia e che, seppure senza frequenza di incontri, Le sono sempre stato schiettamente amico.
E malgrado i velenucci e le blaterazioni dei bulinisti e dei bisantineggianti, e malgrado la lotta per la vita (che per me, più che quotidiana è oraria), io sono del parere - e sono certo che Lei è d'accordo con me - che le strade maestre sono ancora e sempre le nostre, e che la nostra cetra ha ancora delle corde da far vibrare.
Rovere cita il suo disgusto nel leggere certe pagine: trattasi di quanto scritto da Pinin Pacòt nell'Armanach piemontèis per il 1937. Pacòt che aveva invitato Costa a collaborare all'almanacco ma ne aveva ricevuto un garbato rifiuto. Da qui l'invettive che scaglia contro Costa da quelle pagine.
Ancora in una lettera alla zia carissima, buona sorella di mia madre del 13 febbraio 1938 a proposito del suo lavoro:
... Io continuo a lavorare senza essere retribuito come so di meritarmi e come la vita richiederebbe. Purtanto lavoro e la mia STORIA UNIVERSALE DELL'ARTE va avanti.
Come precedentemente detto la collaborazione agli Armanach di Pacòt, che proseguiranno fino a quello per il 1938, si interrompe con quello per il 1932.
Il 10 giugno del 1940 (lo stesso giorno della dichiarazione di guerra dell'Italia fascista alla Francia e alla Gran Bretagna!) Nino Costa scrive a Rovere:
Caro Rovere
Quest'anno si pubblicherà nuovamente l'Armanach piemontèis. Gradirei una sua poesia e un suo articolo, naturalmente in dialetto piemontese. La poesia, a sua scelta; l'articolo, preferibilmente, di carattere artistico, storico - cioè biografia di artista piemontese morto da tempo - illustrazione di monumenti piemontesi, castelli ecc. presentazione di piccole industrie a carattere artistico piemontese, artigianato artistico ecc
La prego ancora di unire all'articolo una o due fotografie o disegni (non di più perché i cliché sono assai costosi).
Purtroppo debbo avvisarla che la collaborazione è gratuita - spero tuttavia nella sua amicizia e nel suo disinteressato amore per la nostra letteratura e il nostro Piemonte.
In data 20 luj 1940, su carta intestata dell'Armanach piemontèis, segue l'invito ufficiale, inviato a tutti i possibili collaboratori. L'amministrazione è presso la Libreria Viglongo e si chiede di rimettere la corrispondenza direttamente al Prof. Nino Costa.
Eccone qualche stralcio:
L'Armanach piemontèis '941 a l'avrà un carater popolar alegher e nostran - come i "Lunari" 'dna vòlta - ma con na splùa 'd modernità e na fiamada 'd poesia. A sarà leger - arios e facessios - senssa polemiche regionai nè politiche nè leterarie - duvert a tuti i vent e a tute le fragransse come na fnestra spalancà sla campagna. A podran leslo e tenlo da cont tant ël vejòto ch'a tramonta come la totin-a ch'a fioriss. L'Armanach '941 - e coi ch'a vniran dòp - as propono nen mach e'd rende pi larga e numerosa la conossenssa dla parlada e dla leteratura nostrana ant'ël Piemont e 'ntl'Italia - ma prima 'd tutt ëd deje d'aria e dë splendor a la fiama che per adess a cimiss.
Stranamente, tra queste carte presenti nel fondo Rovere di Castellamonte in una apposita cartellina indicata Nino Costa, non appare alcuna risposta del Rovere. In ogni caso, dalla mancanza assoluta di suoi scritti sia nell'Armanach per il 1941 che in quello per il 1942 (gli unici ad essere pubblicati), arguisco che la risposta sia stata negativa.
In una lettera a Terenzio Grandi, datata 28 dicembre 1940 notte, oltre ad un accurato conteggio dei debiti da lui contratti con l'amico, aggiunge:
Otto anni di vita "difficile" non mi hanno consentito di essere, come lo sono stato per il passato, puntuale. Ma se la vita non mi vien meno, nel decorso di sei o sette mesi, penso di rimettermi in carreggiata. Così, a fine anno, in attesa che corrispondano gli straordinari di Dicembre, e la gratifica extra deliberata dal Consiglio del Federagrario il 27 c. m. per me e due altri (il che non avverrà prima del 15 Gennaio), mi trovo a cercare 5 o 600 lire. Non le chiedo a te, ma ti prego semplicemente di sondare il terreno se tra i comuni amici esiste qualcuno idoneo alla bisogna.
Cinquantenario (mio): si compirà nel prossimo anno, alli 22 di Giugno alle ore 5 antimeridiane. E per celebrarlo degnamente, ricorrerò a' tuoi torchi per un volumetto di tre canti cui sto sin d'ora applicando la lima oraziana. E ricorrerò anche per qualche po' di carta da lettere portandoti lo zinco e forse anche la carta.
Visioni. Ricorrerò pure a te anche per queste, e cioè, perché, come hai già fatto altra volta, mi saldi insieme con qualche punto metallico una copia dattiloscritta con relativi stamponi di xilo, per vedere se mercè Servolini, Travaini e altri, mi è possibile dare alla luce i miei poveri e vissuti e - qualcuno almeno - robusti sonetti.
La seconda guerra mondiale incombe, trovo la famiglia Rovere sfollata in quel di Castellamonte nel verde Canavese. Di questo soggiorno mi occuperò in seguito.
Da tempo Rovere ha stretto fraterna amicizia con il pittore Pier Demetrio Ferrero. Tra i due un fittissimo scambio di missive. In un paio di queste si precisa il pensiero politico dei due. In una lettera del 7 febbraio 1945 così Piero si esprime:
... Durante il periodo della prigionia di Roma ho corso una mia avventura di carattere politico ed in seguito ho dedicato largo tempo, troppo tempo, alla vita politica. ...
In una successiva del 25 novembre 1945:
...ricorro alla tua cortesia per un segnalato favore, di una certa urgenza e di carattere DELICATISSIMO.
Mi sarebbe utile che, prima possibile, e da qualche esponente torinese del suo partito, il Commissario e Direttore Generale del mio Istituto, Avv. Gian Carlo PAJETTA (padre dell'On. Giancarlo Pajetta), fosse informato dell'indirizzo del mio pensiero politico. Non solo ma che, sull'affidamento che Tu puoi dare di me a tale riguardo, egli sapesse che tale indirizzo non è certo di oggi, ma risale a manifestazioni di pensiero di qualche lustro.
Benché, non intendendo dedicarmi compiutamente alla vita politica, almeno per ora, io non sia regolarmente iscritto al partito, tu ben sai come, per forma mentis e per preciso modo di vedere il mondo, le mie simpatie non possono indirizzarsi che al comunismo, dal quale se non imminente ma almeno nel tempo della mia vita, io attendo una revisione di valori ed una riorganizzazione su piano di maggior giustizia dei rapporti sociali ed economici.
Nell'ordine di tale simpatia io ho svolto la mia modesta attività politica, pagando anche di persona, in epoca in cui ritenni che tanto rispondesse a preciso dovere civico.
Tutto ciò premesso, espongo esplicita la preghiera. Personalmente, se hai contatti diretti di partito, o a mezzo di qualche amico tuo militante, mi obbligherai facendo sapere all'Avv. Pajetta quanto, come detto, mi è utile che egli sappia in questo momento. ...
Come Dio vuole, la guerra termina. Comincia la ricostruzione di questa nostra povera Italia. Con fatica riprendono le attività quotidiane. Luigi Olivero, il grande poeta piemontese che vive a Roma, è il primo a rilanciare la letteratura del suo Piemonte iniziando l'avventura de Èl Tòr, arvista lìbera dij Piemontèis il cui primo numero esce il 14 di luglio del 1945 proprio nella Città Eterna.
Sul finire del 1945 riceve a Torino, in una delle sue periodiche visite, l'amico Luigi Olivero. Gli consegna ben settantadue pagine antologiche da lui raccolte da consegnarsi al fraterno, e comune amico, Pier Demetrio Ferrero al suo ritorno nella capitale. Incontrato Olivero, Pier Demetrio il 7 novembre scrive a Rovere:
Olivero mi ha recato le settantadue pagine di antologia dedicatami dal tuo costante ricordo. Le ho gradite come nuovo segno di fraternità ma non ti nascondo che ben più avrei desiderato leggere qualcosa tua di recente creazione.
Ho avuto la visita graditissima di Luigi Olivero, scrittore, giornalista, che mi ha proposto la collaborazione in alcune sue pubblicazioni; mi è dispiaciuto non poter aderire al suo desiderio in quanto non amo frammentare i miei scritti su giornali o riviste.
Pier Demetrio Ferrero, a Roma, qualche tempo dopo assume la responsabilità del lancio e della segreteria della rivista di Olivero. In data 30 marzo 1946, su carta intestata della rivista scrive a Rovere:
... Olivero ti avrà detto come io abbia preso in mano "El Tor" per quanto riguarda il suo lancio e ti avrà pregato a mio nome di occupartene anche nel senso di procurare su larga scala abbonamenti e di cercare qualche possibilità di sostenere le finanze con inserzioni pubblicitarie.
Al riguardo io ti confermo il mio pensiero che una rivista come la nostra debba essenzialmente fare affidamento su tali introiti in quanto il costo della medesima è elevatissimo, le rese sono in percentuale notevole e i rivenditori si assorbono il possibile utile.
Necessita quindi che, se Voi amici di Torino volete far sopravvivere la rivista, la aiutiate non solo con pregevolissima collaborazione letteraria ma anche ed in questo momento essenzialmente con la ricerca di fondi. Compiaciti di renderti interprete di queste assolute esigenze con tutti i collaboratori suggerendo tra l'altro, dato il carattere formativo del giornale, la possibilità di cercare presso ditte, uffici ecc. abbonamenti cumulativi a carico delle direzioni. ...
Molto presto Teresio collabora alla nuova rivista con poesie e articoli, infatti il suo primo contributo appare nel numero 8 dell'otto dicembre del 1945. Trattasi di un lungo articolo dal titolo Sette secoli avanti la fondazione di Roma nasceva nella leggenda TORINO EGIZIANA. Il pezzo è accompagnato da questo linoleum di Orfeo Tamburi:
Per rendere meno oscuro il titolo, ecco un breve brano:
Peregrinazione storico-sentimentale, potremo mettere per sottotitolo alla passeggiata che stiamo iniziando, nella Città che Gabriele D'Annunzio, in un messaggio a un condottiero della Grande Guerra, definì «l'altissima Torino», che Giovanni Pascoli celebrò in uno dei suoi più ispirati carmi latini, che Giosuè Carducci cantò nell'ode saffica al Piemonte; nella Città che ospitò fra le sue ben guarnite mura il cantore della Gerusalemme liberata forse contemporaneamente a Giordano Bruno e che vide nel suo glorioso Ateneo l'umanista Erasmo da Rotterdam; nella Città che è prima autòctona e poi romana.
Ma prima di ricercare in una riposante notte estiva o in una prealba autunnale i segni cesarei a piè delle Alpi, vogliamo abbandonarci alcun po' ad una fascinosa leggenda secondo la quale l'industre Città che si specchia nell'Eridano vanta favolose origini egiziane. Fascinosa leggenda, ché le argomentazioni di Emanuele Tesauro nella sua Historia dell'Augusta Città di Torino furono abbandonate dai successivi storiografi e non ebbero, sino ad oggi, almeno, conforto di documenti probatori.
Secondo articolo, questa volta la presentazione di un giovane poeta, suo grande amico, Attilio Spaldo nel numero doppio 9/10 del 22 dicembre 1945. Dopo una lunga introduzione Rovere giunge ad Attilio:
Lo Spaldo, temperamento volitivo e perseverante, dotato indubbiamente di una facile vena, è ai suoi primi componimenti poetici. La trentina, che ha appena varcato, ci dice che non è un ragazzo prodigio, dei quali, salvo eccezioni, è sempre bene diffidare. La sua poesia è quindi un'attività in sviluppo, è poco più che allo stato potenziale, tuttavia, se pur non ancora individuata, spiegata, ampia, ha già una voce sua. ...
Ogni plaga del vecchio Piemonte, e particolarmente la montagna di cui è appassionato e Torino la sua città natale di cui è innamorato, sono altrettante corde della cetra che egli sta tentando per trarne accordi di più vasto respiro, di più alta musicalità, di più meditato pensiero.
La produzione attualmente al suo attivo, forse una ventina di liriche, seppure rivela un temperamento emotivo, un animo aperto ai richiami perenni della natura, è ancora incerta nella veste formale ma è già poesia e cioè stato di grazia.
Una più accorta elaborazione formale, una più intensa applicazione del LABOR ET LIMA oraziano, e magari una più vasta conoscenza dei poeti dialettali piemontesi dal Calvo al Brofferio, all'Alarni, ad Alfonso Ferrero, a Viriglio e ai viventi; un accostarsi alla più pura fonte della poesia vernacola; alla dolcissima poesia Mistraliana, consentiranno allo Spaldo di sprigionare appieno la sua poesia e di renderla vitale.
Questo primo saggio che viene ospitato sulle colonne di «Ël Tòr» è un pegno cui, ne sono certo, il poeta terrà fede.
Dedicato ad Attilio Spaldo è un sonetto di Rovere che accompagna la presentazione:
La mòrt dij seugn
ad Attilio Spaldo
Tuti portoma ant noi, fin da masnà
ël regret ëd quaicòs ch'a sarà mai;
e ògni sèira as na va, con ji stërnai,
un dij seugn che 'l destin a l'ha brusà.
Tuti, ant la vita grama e mal forgià,
vëdoma, dì për dì, 'n mes tanti guai,
dëstissesse ij pi pur nòstri ideai
e 's sentoma pi soi an mes dla stra.
Amor e poesìa, seugn d'artista,
ale d'òr strivassà da la bufera
ch'a tormenta la vita fin-a al fond...
tut l'é mach stait un gieugh dla nòstra vista.
La realtà scancela la chimera:
le creature 'd seugn son nen 'd cost mond!
Nel successivo numero 11 del 16 marzo del 1946 compare il seguito di Torino egiziana: «Figlia di tua figlia Roma - madre di tua madre l'Italia» Torino romana, accompagnato ancora da un linoleum di Orfeo Tamburi:
Ecco l'inizio:
Nella chiarità plenilunare la Città ci appare nella sua millenare e tangibile forma. Lontano vegliano le
Itale vergini, Alpi dal bel velo
bianco...
vicini mormorano il Po e la Dora che dalle montagne scendono verso il mare. Siamo nel cuore di Torino. Usciti dalle nebbie della leggenda, siamo entrati in pieno periodo storico ed eroico. Le strofe che Giovanni Pascoli, il poeta della Grande Proletaria, dedicò a Torino nell'anno cinquantesimo dell'unità italiana, fremono sulle labbra:
Toro divino, c'oltr'a due fiumane
giaci e, fiso nel gran murmure, guardi
l'Eridano, che passa e che rimane...
Salve o città forte di vallo e fosso!
salve, o bivacco italico di scelte
anime! o campo che non fu mai mosso!
o insegne mai dal loro suolo svelte!
Te la dea Roma disegnò quadrata,
qual essa fu, premendo il solco a fondo,
col grande aratro dalla prua ferrata,
con cui fendé fecondatrice il mondo.
Ancora su Ël Tòr di Olivero l'Autoritrat di cui ho già scritto. Quindi la collaborazione si interrompe. Dissapori tra i due? Chissà. Forse anche il prossimo ritorno della rivista di Pacòt Ij Brandé seconda serie, cui Rovere invierà suoi lavori.
Il 5 novembre del 1945 a Torino, dopo lunga malattia, muore Nino Costa.
In data 26 novembre Rovere scrive:
Alla Vedova di Nino Costa
Gentile Signora,
Molte schiette parole di conforto e di solidarietà io voleva dirLe quando Nino chiuse gli occhi. Ma non volli turbare maggiormente il Suo animo e seguii silenziosamente la salma del Poeta.
A testimoniare a Lei ed alla Sua Figlia la mia vicinanza spirituale al caro Scomparso, Le invio ora il testo della commemorazione che terrò in settimana nella Sede del mio Partito in Corso Moncalieri. ...
Creda, gentile Signora, alla mia schietta partecipazione al Suo cordoglio e accolga, insieme a Sua Figlia, il cordiale saluto del Suo
devotissimo
Il 29 novembre Ercolina Costa risponde a Rovere:
Egregio Signor Rovere
profondamente commossa per le sue tanto nobili espressioni nei riguardi del mio amatissimo Nino, la ringrazio di tutto cuore, anche a nome di mia figlia.
Soltanto un amico e un cuore gentile di poeta quale il suo poteva esprimere con tanta delicatezza di sentire tutta l'anima, la rara sensibilità e la diuturna e preziosa opera dell'uomo integro, del patriota consapevole e del poeta quale fu il mio amatissimo!
Le sono tanto grata d'avermi inviato copia della rievocazione che terrò preziosissima e che sarà certamente molto apprezzata dal suo uditorio.
Sono convinta che lei continuerà (nel ricordo e per l'amicizia del carissimo scomparso) a tenere sempre viva e alta la fiaccola della poesia nostra che fu tanta parte della vita del nostro Poeta.
Col rinnovo del mio riconoscente grazie le porgo cordiali saluti.
Devma Ercolina Costa
Una nuova lettera, questa volta indirizzata alla cugina Evelina, è del 29 ottobre del 1946, gli è appena stata segnalata la morte della cara Zia Maria:
Dalla lettera inviata a mia sorella ho appreso la dipartita della tua buona mamma, sorella di mia madre: con Emilia, Ninin e Maria sono vicino con il cuore a te Mariuccia e Simone, solidale con il vostro grande dolore. Dall'arrivo della mia lettera sarai a conoscenza della dolorosa condizione di Ninin e Maria e della semplice vita di Emilia e mia. Purtroppo Ninin va sempre declinando ché la sua infermità (emiplegia) non comporta miglioramenti ma solamente peggioramenti, o, tutt'al più, lunghi periodi stazionari che ne prolungano le sofferenze. Anche Maria, dopo quasi sei anni da che Ninin è stata colpita e dopo 8 mesi da che tiene il letto, è anch'essa scossa nella salute. Sin dal 5 giugno ho iniziato le pratiche e cercato appoggi per fare ricoverare Ninin al Cottolengo ma, sinora, senza esito. E l'inverno è ormai imminente e la situazione si fa ogni dì più insostenibile.... Certo che stringe il cuore dovere assistere impotente al lento inesorabile tramonto di questa creatura sororale e materna che tanto ha fatto per gli altri, tanto si è sacrificata...; sì che si resta perplessi davanti agli imperscrutabili disegni del destino.
In successione muoiono prima Ninin e qualche tempo dopo, nel maggio del 1956, Maria, notizia che riporto da una lettera inviata alle cugine Evelina e Mariuccia del 29 luglio 1958. Nella missiva scrive anche:
Da qualche tempo, e precisamente dalla fine del 1957 non avrete più ricevuto la rivista di poesia piemontese Ij Brandé, che regolarmente vi facevo spedire in abbonamento. La colpa non è mia, ma bensì del Direttore e fondatore (insieme a me) che ha creduto bene (per conto mio è male) di finirla. Peccato, perché era una voce schietta e simpatica che portava anche al di là dei mari e dei monti la voce del nostro vecchio Piemonte. Pazienza! Purtroppo tutto ha una fine a questo mondo, e segnatamente le cose belle.
Rovere aggiunge poi di stare per iniziare una collaborazione con il quotidiano torinese Il popolo nuovo. Segnala di essere dal 1 luglio 1956 in pensione dal Credito Agrario presso cui ha prestato servizio per 18 anni. Arrotonda la magra pensione per conto della Banca con la propaganda del Credito Agrario recandosi mensilmente alcune volte in Canavese e con altre attività come da un suo biglietto pubblicitario:
Teresio Rovere
Trascrizione e collazione manoscritti ... Stesura di articoli letterari, artistici, pubblicitari e di recensioni.
Compilazione cataloghi, indici e lavori diversi.
CORREZIONE E REVISIONE DI BOZZE TIPOGRAFICHE
Serietà e sollecitudine nel lavoro ... Mitezza di prezzi
Del 3 maggio del 1961 è l'ultima lettera del carteggio diretta alle cugine in America Latina. Segnala l'avvenuta pubblicazione de La novella di Griselda augurandosi di poter in seguito proseguire con altre parti dell'opera dello zio Vittorio. Così prosegue:
Sin dal 2 giugno del 1959 sono stato insignito della Croce di Cavaliere al Merito della Repubblica, sembra in riconoscimento della mia passione di studio.
Nel 1960 sono stato 35 giorni in clinica. Il 1° di giugno sono stato operato di prostatectomia. Solamente ora, a quasi un anno di distanza, posso dire di essere quasi completamente rimesso.... Quasi ciò non bastasse, dal 27 marzo, prima una dolorosa nevrite e poi una perfida influenza mi hanno costretto a letto, sì che ho anche perduto quel poco che ricavo dal lavoro che svolgo nel Canavese per conto dell'Istituto presso il quale ero impiegato.
Nell'ottobre del 1960 la Radiotelevisione Italiana ha messo in onda un Processo al gatto dove io interloquisco come difensore del grazioso felino e ne ottengo l'assoluzione!
Ho provveduto a sistemare i resti di mia sorella Caterina nelle Collette cinquantenarie e a dare dignitosa sistemazione alla tomba di Maria, e sin d'ora mi propongo, se mi dura la vita, di sistemare anche lei, nel 1966 nei loculi cinquantenari. Quando vado al Camposanto passo sempre da zio Vittorio il cui loculo scade nel 1968. ...
Quanto prima, durante l'estate, mi sarà offerta la cittadinanza onoraria di Castellamonte Canavese, sia in riconoscimento de' miei studi sia per riconoscenza della donazione (post-mortem) che delle cose mie ho fatto: libreria, archivio, quadri, incisioni, bronzi e ceramiche per fondare in quel centro e, idealmente per tutto il Canavese, le basi di una biblioteca e di un museo che invoglieranno altri ad accrescerli. Sono stato indotto a questo dal fatto che desideravo che tante cose, radunate con amore, che, come hanno servito ad un povero ignoto studioso, possano servire ad altri, ammesso che in questi curiosi tempi nascano ancora individui appassionati per la poesia, per l'indagine filosofica e per lo studio in genere....
Dal canto mio mi impegno di scrivervi più frequentemente, malgrado la soma di anni (il 22 giugno prossimo compio il mio quattordicesimo lustro). Non sono più il birichino che tirava le trecce ad Evelina a Trofarello, ma sono ormai un vegliardo...
Come preannuncia più sopra il Rovere, il 25 giugno del 1961 gli perviene l'invito a Castellamonte per la nomina a Cittadino Onorario. Così annuncia l'evento il Comune di Castellamonte nella sua Lettera N° 3 del terzo trimestre ai cittadini di Castellamonte:
Abbiamo un cittadino di più: Teresio Rovere poeta e saggista, povero e modesto ha donato a Castellamonte la sola ricchezza di cui dispone: oltre 4.000 volumi, sculture, incisioni, ceramiche, dipinti, una ricca ed organica emeroteca (giornali e riviste), migliaia di "schede" per orientare gli studiosi (136 attorno al solo D'Annunzio), centinaia di monografie. Il nostro paese acclamandolo suo "cittadino onorario" sente di dover prendere un impegno: costruire un edificio il quale sia a un tempo biblioteca, pinacoteca, museo: esso sarà il monumento più idoneo per onorare Chi ha speso tutta la vita nel lavoro e nello studio.
Nel discorso introduttivo il Sindaco traccia la storia che ha portato a questo evento:
Debbo andare indietro di parecchi anni e precisamente al tempo infausto della guerra: il sig. Rovere, allora era un cittadino che pagava egli pure il tributo di disagio richiesto dalla guerra; volendo sfuggire ai rischi di morte che regalavano le bombe a coloro che abitavano la città, cercò rifugio per sè e la sua signora, nel nostro paese. Qui egli si trovò bene e debbo aggiungere che si trovò ottimamente soprattutto per l'affettuosa ospitalità e l'affettuosa accoglienza che tributò ai coniugi Rovere il nostro non abbastanza compianto cav. Ferruccio Demarchi.
Egli fu un amico per i "rifugiati" Rovere e non solo per essi. Ora noi dobbiamo a questo nostro Amico, che fu qui accanto a noi per tanti anni come assessore, la scintilla di affettività che indusse il cav. Rovere a legarsi sempre più a Castellamonte e a donare al Comune la sua preziosa biblioteca. ... E non solo di libri si tratta ma anche di dipinti e altri pezzi d'arte. Così Castellamonte che ancora non ha un Museo della ceramica, che non ha una pinacoteca e men che meno una biblioteca, ha trovato nella generosità del cav. Rovere il punto di partenza per dar vita a questa triplice iniziativa che, prima o poi, dovrà essere realizzata....
Alla chiusura del discorso del Sindaco, Teresio Rovere chiede di poter leggere una sua comunicazione: Ringraziamento ai Cittadini di Castellamonte per il conferimento della cittadinanza onoraria.
Questo suo discorso è, purtroppo, molto lungo. Pubblicato esclusivamente sulla citata Lettera N° 3, quindi a scarsissima diffusione, è praticamente, ai più, sconosciuto. Mi vedo costretto a citarne solamente alcuni passaggi.
Nel lontano 1917, uno studioso, cui avevo dato in lettura alcune mie lettere e poesie, trovò pochissimo di buono e molte imperfezioni nelle poesie e, poiché in qualche lettera ebbi l'ardire di qualificarmi poeta, biasimò le mie epistole definendole «alla Petrarca». Allora la desinenza dei miei anni era in «enti», venne poi quella in «enta» e dopo quella che spaventava Guido Gozzano, quella in «anta»; ed infatti io sono un vinto, che non ascrivo a vittorie i libri di poesia, la Storia Universale dell'Arte e le altre cose date alle stampe; un vinto che fra molte sconfitte, prima fra tutte la mia carenza culturale, annovera solamente due vittorie: quella di avere a fianco nella vita una buona e comprensiva compagna; l'altra di vivere, da oltre mezzo secolo, fra i miei libri che sono la mia ragione di vita e la mia unica ricchezza; cui oggi se ne aggiunge una terza: quella di essere Cittadino di Castellamonte, e quindi idealmente di tutto il Canavese, cosa che per me, ignoto studioso, vale come una affettuosa laurea conferitami, Coram Populo, per la mia poesia e per un mio atto d'amore. ...
L'età cupa dei vinti non mi ha prostrato: la passione dello studio e dell'indagine, il desiderio di ampliare sempre il mio orizzonte culturale nel tentativo di colmare le lacune, l'ansia della conoscenza mi hanno salvato dal naufragio. Ed anche se posso, come il castellano Renato della Partita a scacchi dire;
le larve
svaniron tutte, i moti del mio
cuor fur muti,
e i miei sogni di gloria non
erano compiuti!
La realtà di oggi è per me la traduzione in atto di un sogno, quello cioè di proiettarmi nel futuro, senza esibizionismo che non è nella mia natura, con la mia offerta - non venale ma spirituale - affinché quanto ha servito ad un pressoché ignoto studioso, possa domani servire ad altri studiosi più di me fecondi di nuove e sane opere.
Io desidererei, come scrisse quello spirito caustico e corrosivo di Paul Leautaud; «Essere compreso da un piccolo numero di persone e ignorato dagli imbecilli». Non cercai mai lodi o consensi, anzi diminuii o persi la stima di quanti, in buona o mala fede, mi definirono - illusi! - poeta dei tempi nuovi. Il clangore delle buccine, la grancassa della piazza o i compiacenti "soffietti" della stampa quotidiana od eddomadaria non mi annoverano tra i loro questuanti.
Le mie convinzioni spirituali, filosofiche e sociali, ora che mi avvio ai confini della vita, mi fanno dire, parafrasando il Carducci, che «aspetto imperturbabile l'ultima ora». Ed agli amici che, compiendosi il mio quattordicesimo lustro di peregrinazione sotto le stelle, mi augurano chi dieci, chi venti, chi trenta anni ancora, rispondo come il Papa umanista Leone XIII al Decano del Sacro Collegio, che in occasione del suo genetliaco gli augurava di raggiungere il secolo: «Non poniamo limiti alla Divina Provvidenza». ...
Non so se quel che mi rimane di vita mi consentirà di pubblicare ancora qualche mia pagina non indegna di essere tratta dall'ombra. Affido quindi - senza vincolo alcuno - a chi riordinerà e sistemerà le cose mie, di realizzare in tutto od in parte il mio desiderio. Fra tanti errori e tanta zavorra può darsi gli accada di trovare qualche cosa. ...
(Forse, anche se in piccolissima parte, qualche cosa spero di aver fatto, con questo mio lavoro, per incontrare il suo desiderio)
Le riviste Selezione ed i libri condensati, da noi pedissequamente imitati dal Talassocrate d'oltre oceano - povero di cultura umanistica e straricco di conquiste scientifiche e di beni naturali - sembrano iniziare il declino ed il tramonto delle vetuste biblioteche della vecchia ed inquieta Europa. Le biblioteche del futuro saranno ridotte a dischi, nastri magnetici, a rotoli microstampati, dalla Bibbia alla Divina commedia ed ai capolavori in pillole? Le previsioni non sono allettanti. Lo spirito del Cantore di Laura che nel 1362 donava alla Repubblica Dogale parte dei preziosi manoscritti da lui radunati, i quali costituiscono l'origine di quella Biblioteca Marciana ancor oggi fiorente, freme nei Campi Elisi. ...
Lo scibile umano non aumenta come numero di discipline che sono ancora oggi impostate da Aristotile. Si tratta tutt'al più di perfezionamenti e di ramificazioni che si dipartono dal ceppo primitivo. Le basi delle arti sono antiche e sempre attuali, e cioè eterne. Nessuno può aggiungere verbo alla perfezione del breve e pur amplissimo Cantico delle creature. Aumenta, purtroppo il numero delle cosiddette opere intellettuali, fra cui scarsissime quelle veramente vitali; aumentano in misura impressionante gli scrittorelli, i poetastri senza ritmo e senza idee e, soprattutto, senza ispirazione; aumenta lo sciame dei parolieri, dei musicanti, dei cantori le cui offese all'arte vera sono quotidianamente e generosamente diffuse dai microfoni delle radio nostrane e straniere; ed i pochi superstiti depositari del sacro fuoco dell'arte vanno a poco a poco scomparendo. ...
Consentitemi di chiudere con i versi che Vittorio Alfieri nel 1797 dedicava alla sua Asti esprimendo il desiderio di legare la sua biblioteca:
Nè in dono io già, ma in filial tributo,
spero, accetto terrai questo util pegno
d'uom che tuo cittadin s'è ognor tenuto.
Quindi, se in modo vuoi di ambo noi degno
contraccambiarne un dì il mio cener muto,
libri aggiungi ai miei libri; esca all'ingegno.
Vi ringrazio di avermi voluto accogliere come concittadino e, stringendo la mano del Sindaco Dottor Carlo Trabucco la stringo idealmente ed affettuosamente a tutti i Castellamontesi.
Rovere prosegue con il lavoro di riordino dell'opera dello zio di cui dai cugini d'America, finalmente, ha ricevuto le ultime giornate. Ha ancora il tempo di farne pubblicare, nel 1963, La novella di Chichibio che pochi mesi dopo, il 6 di maggio dell'anno successivo, lascia una vita per lui avara di soddisfazioni, ma ricchissima, purtroppo, di disagi, miserie, lutti e malattie.
Nostra consolazione le poche opere che ci ha lasciato in vita e l'enorme mole di materiale che ha raccolto che per nostro beneficio si è concretizzato nel lascito al Comune di Castellamonte che ancora una volta ringrazio per avermi accolto nella sua biblioteca ed avermi concesso libero accesso tra le carte del Fondo Rovere.
La Sagra d' San Michel
(An slë scalon di mòrt)
Ò Sagra d' San Michel, seugn ëd mia mama,
ritir su la montagna, antich e bel,
sota toe pòrte l'ànima a s'anfiama,
e n'orassion a s'aussa vers ël cel.
A la sima dla rampa fatigosa
it ses bela an sla ponta al Pirchirian;
pi che na catedral it ses gloriosa,
fior ëd mè vej Piemont, rùstich e san.
Armitagi dla fede e dl'orassion,
la pas a l'ombra d'tò profil as sent,
lë spìrit a va d'sora dle passion
e la carne a dësmentia ògni torment.
It ses bela con toe muraje ardìe,
ch'as drisso an sima ai ròch, con le ruvine
ch'a domino la Dòira e le fiorìe
valade pontinà da le cassine.
Guardo j'afresch antich su le muraje,
arvivo le legende misteriose,
arvëddo ant la pianura le bataje,
che ant ël passà l'han tenzù d'ross le rose.
Scalon di mòrt! Vision d'inmensità,
ch'a smìa ch'it sèrche d'arivé là su,
dova la vos ëd l'òdio a taserà,
dova che 'l tradiment l'é sconossù.
I contemplo, scurpïe an dura pera.
le stèile an sima dla grand scala scura:
dë dnans a costa veja arte sincera
pi sempia as treuva l'ànima e pi pura.
Peui dòp i guardo an aut. L'hai l'impression
che, an slë scalon scavà su la montagna,
aj sïa quaich misteri, n'emossion
dròla am frissona e mè pensé a guadagna.
Là su, ant l'ombra, darera d' cola fra,
còsa, còsa ch'a son cole figure?
Pòvri viandant ch'a son cascà an sla stra?...
Schéletri bianch ëd pòvre creature.
Ò fratei trapassà ch'a smìa ch'i rije,
la piena versé an mi ch'av rusìa 'l cheur,
òh, dilo a mi da dova ch'i vnisìe,
confidelo al poeta vòst maleur!
Voi-autri i tase, ò pòvri avans uman,
e mi v'arvëddo ancora, an slë stradon,
ch'i vnisïe da tant, da tant lontan,
a la Sagra për vot, për redenssion.
E 'l vent, ò la tormenta, ò na man trista
l'ha massave an sla pòrta dël confòrt,
seve cascà con la speransa an vista,
seve ancora an sla stra bele dòp mòrt.
Requiem aeternam, mumie sconossùe.
fërme ant la posission ëd l'agonìa;
Requiem aeternam, ànime sperdùe
an mes dla fiòca su la stra 'nfinìa;
Requiem aeternam, mè pensé sì d'sora
a 'nbrassa tuti i sensa-sepoltura,
tuta la pòvra gent che gnun a piora
an sità, sla montagna, ant la pianura.
Ò Sagra d' San Michel, i torno a bass,
sento d'esse pi fòrt e pi seren;
s'i torneissa da ti për serché d' pas,
l'antica pòrta d' fèr saramla nen!
6 aprile 1927
(1) GABRIELE CENA Chivasso 1907 - Roma 1992
Frequentò l’Accademia Albertina di Torino e poi quella di Belle Arti a Roma dove fu anche insegnante. Pittore con esperienze classiche, ma anche cubista e astrattista. Collaborò con suoi linoleum alla rivista di Luigi Olivero Ël Tòr.
(2) CARLO TRABUCCO Biella 1898 -Torino 1979
Giornalista, sindacalista, scrittore e politico. Ginnasio Balbo a Torino, poi anni dopo diploma liceale ed in seguito laurea in legge. Dovette rinunciare nel 1929 al posto presso La Stampa di Torino non avendo voluto la tessera fascista. Richiamato alle armi nel 1941 fu all’Ufficio propaganda dello Stato maggiore dell’Esercito. Durante l’occupazione tedesca di Roma visse in clandestinità e nel primo dopoguerra pubblicò un suo diario: La prigionia di Roma, importante documento storico,.
Fu quindi al Popolo di Roma, poi al Popolo Nuovo di Torino di cui assunse in un secondo tempo la vicedirezione. Scrisse per L’Osservatore Romano, il Gazzettino, il Tempo, la Gazzetta del Popolo e molti altri fogli.
Dal 1960 al 1965 fu sindaco di Castellamonte e dal 1964 al 1969 fu alla Provincia di Torino come consigliere.
(3) Dai Fondi Rovere, Grandi e Ferrero custoditi presso la Biblioteca del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, ho attinto numerose notizie e qui sentitamente ringrazio la Direttrice per la sua disponibilità e cortesia.
(4) La poesia è pubblicata nell'Armanach Piemontèis per il 1932 con titolo Anniversari a ricordo dei 30 anni trascorsi dalla morte della madre.
(5) Su PIER DEMETRIO FERRERO (1906-1991) lo scritto di Luigi Olivero da Ij Brandé N° 161 del 15 maggio 1953:
Che un pitor, anche ‘d valor, a sia pòch conossù, a-i-è gnente dë straordinari: a l’è mach na question ëd propaganda. Che un pitor turineis a sia pòch conossù a Turin, gnente ëd pi natural. L’arte a l’è nen na merce corenta, almeno cola vera.
Però quand che l’ocasion as presenta d’arcordé queicadun che a në val la pen-a, a vanta nen lassela perde. E cost a l’è ‘l cas ëd Pier Demetrio Ferrero, pitor turineis che a viv a Roma, e che, an costi di, a l’ha presentà a la Galerìa «Il Camino», an via del Babbuino, la classica contrà dj’artista ‘d Roma, na soa anteressanta esposission personal.
Ferrero a l’è nen neuv a la vita artistica nassional. Dal 1932 fin-a adess a l’ha esponù vaire vòlte a la Promotris turineisa e a j’Amis ëd l’Arte ‘d Turin, a la Mostra d'Arte dla Galerìa ‘d Roma e la Quadrienal d’Arte roman-a; e la critica sovens a l’è occupasse favorevolment ëd chiel. Mach che a l'é nen un mestierant, che a vada an serca d'aprovassion autorévoi e 'd riconossiment académich, sia d'avanguardia che tradissionalista. Coma che a l'é formasse da chiel (da giovo a l'ha frequentà jë studi dël pitor Mennyey e dlë scultor Alloatti); così a pitura prima 'd tut për chiel, sercand ant l'arte cola consolassion, che d'autri a serco ant la poesìa. Per lòn soa pitura a l'é così sincera e përsonal, bele travers a le arsonanse lontan-e 'd motiv e 'd manere. che a peulo nen manché ant na civiltà artìstica, così tormentà e complicà coma la nòstra.
Ël sucess dl'esposission roman-a a l'é pi che merità; speroma che, prest, soa pitura a peussa 'd cò esse presentà e apressià ant costa nòstra sità che a l'é 'd cò la soa.
ERCOLE DOGLIANI (Torino 8 dicembre 1888 – Torino 12 ottobre 1929). Da giovane lavora come fattorino prima e quindi come correttore di bozze a La Stampa. Nel contempo coltiva la passione per il disegno eseguendo numerosissime vedute di Torino. Inizia l’apprendimento della xilografia e del 1921 è la sua prima esposizione alla Promotrice delle Belle Arti di Torino. Significative le silografie di ex libris propri o destinati all’amico Teresio Rovere. L’attenzione di personalità autorevoli come Terenzio Grandi e Luigi Servolini, autore di un famoso manuale sulla silografia, ne attesta l’importanza nel panorama culturale della prima metà del Novecento. (Francesco de Caria)
Torino 22 giugno 1891 ~ 6 maggio 1964
Le opere
Nuptialia
Stabilimento grafico Foà Torino - 22 maggio 1922 - pagg 16 in 8°
Plaquette dedicata agli sponsali di Albertina Conti e Renzo Campeggi in Torino il 28 maggio 1922. Contiene le 6 poesie, in italiano, de I sonetti delle colline, ognuna accompagnata da una xilografia di Ercole Dogliani.
(I 6 sonetti saranno ripubblicati, accompagnati dalle relative xilografie, nel capitolo Paesaggi della raccolta Visioni del viandante del 1951) Oltre la copertina (anch'essa incisa dal Dogliani), ecco la xilografia che affianca la poesia Autunno a Santa Margherita (Località della collina torinese).
Visioni del viandante
Xilografie di Ettore Dogliani
Stabilimento grafico Foà - Torino - 2 settembre 1925 - pagg 12 in 8°
Libretto cartonato per le nozze di Gianna Morej e Corrado Filippa del 3 settembre 1925 a Torino. Contiene 6 poesie, in italiano, accompagnate da 6 xilografie di Ettore Dogliani che incide anche la copertina ed il suo stemma sul piatto posteriore. (Anche questa volta i 6 sonetti saranno ripubblicati, accompagnati dalle relative xilografie, nel capitolo Paesaggi della raccolta Visioni del viandante del 1951). Qui sotto la xilografia di Dogliani che accompagna la poesia Notte a Santa Margherita.
Alessandro Antonelli architetto
Casa editrice A B C - Torino - 1934 estratto - pagg 5 in 8°
Artisti della xilografia: Luigi Servolini
Estratto da Cultura moderna - pagg 5 in 8°
Carme eroico per il folle impuro: Federico Nietzsche
L'impronta - Torino - 21 ottobre 1936 - pagg 13 in 8°
In copertina i versi da La Rochefoucauld:
"La plus subtile folie se fait
de la plus subtile sagesse"
In coda al Carme, Rovere aggiunge:
Il CARME vuol essere una intuizione della follia di Federico Nietzsche, accesasi sulla fine del 1888 a Torino e spentasi a Weimar il 25 agosto del 1900. I fatti materiali: l'abbraccio al cavallo in Via Carlo Alberto a Torino, l'inganno per indurlo a partire, le ultime lettere a Giorgio Brandès, ad Augusto Strindberg, a Cosima Wagner, a Peter Gast sono di dominio comune come pure il "Concerto delle risposte eterne" da Talete a Socrate; inutile quindi la narrazione dei primi e la trascrizione delle seconde. Il titolo FOLLE IMPURO, indica chiaramente come il Nietzsche sia inteso agli antipodi della creazione wagneriana del Parsifal: il folle puro. La follia di Nietzsche, e cioè la follia di un uomo di genio, avrebbe potuto essere preziosa fonte di aforismi e di ammaestramenti, se chi fu a fianco del filosofo negli anni delle tenebre avesse avuto l'animo di chi fu a fianco del Goethe. Il CARME tenta, con l'ala della poesia, di celebrare la tragedia dello spirito insaziato, e di intuire il tormento estremo del genio sommerso, tormento che, come quello dei grandi martiri, può / e deve / essere incitamento di maggiore conoscenza e di migliore impiego del fenomeno vita alle generazioni venture.
La massima di Francesco VI, Duca di La Rochefoucauld, è la XXIV delle 64 soppresse dall'autore nelle ultime edizioni (134 nell'edizione del 1665).
Un Acquafortista: Giuseppe Moreno
Casa editrice A B C - Torino - 1936 - Estratto pagg 3 in 8°
Storia dell'arte
1) Dalla preistoria al rinascimento (Unico volume pubblicato)
Editori Associati - Torino - 1938 - pagg 640 con 276 ill in 8°
Quest'opera monumentale era prevista in due volumi. Rovere vi ha lavorato ininterrottamente per molti anni raccogliendo il materiale necessario in migliaia e migliaia di schede. Il secondo volume, completo in tutte le sue parti, giace, con tutte le sue schede, in diversi faldoni conservati presso la Biblioteca Comunale di Castellamonte.
Lauro Mainardi
L'Armenia e gli Armeni nella poesia italiana - Giosuè Carducci - Mario Rapisardi - Mario Garea - E. G. Boner - Teresio Rovere - Sante Sottile Tomaselli - Giuseppe Cartella
Edizioni HIM - Roma - 1939 - pagg 16 in 8°
La poesia di Teresio Rovere dedicata all'Armenia:
Armenia eroica
Viatrice del martirio, gente armena,
tu che sai il ferro della mezzaluna,
e la viltà che striscia e si scatena;
che sai solo il sudario e non la cuna
e la casa divelta e violata
che a la fiamminga stirpe t'accomuna;
che sai la preda vergine immolata,
e il pargoletto ucciso e dilaniato
da chi a le tue calcagna spia e guata,
scopri l'avello dell'Inabissato
e ch'egli balzi ed il suo voto sciolga
e sia l'armeno sangue vendicato...
Lauro Mainardi dedica la raccolta Al Grande Poeta Hrand Nazariantz a Nor Arax, Villaggio Armeno di Puglia, con queste parole:
Illustre e caro amico,
Permettete che la "HIM" dedichi a Voi, nostalgico cantore e vigoroso profeta dell'Armenia, questa prima raccolta di Poesie Italiane dedicate al Vostro grande e sventurato Paese.
Quanti Poeti Italiani hanno sfiorato le corde della loro lira per cantare il velario di sangue e di gloria che, a guisa di un sudario trionfale, è disceso sulla Vostra Patria! ...
Io ho voluto penetrare un po' nel mistero poetico di tutte queste opere, ho voluto comprendere il segreto di questa vasta risonanza lirica nei cuori italiani dell'eroico martirio armeno. Ed ho capito, o mio grande Amico, che non soltanto il grido dei bimbi e dei vecchi sgozzati, che non soltanto il gemito angoscioso delle vergini violate, che non soltanto le gesta stupende degli eroici Armeni ha colpito l'immaginazione poetica dei nostri lirici; ho compreso che non è stato solamente un senso di lodevole e commossa partecipazione ai dolori altrui quello che ha spinto i Poeti d'Italia a manifestare la loro umana solidarietà al cruento dolore armeno!
Qui interrompo la trascrizione del testo in quanto la breve parte restante è tutta un'apologia del duce e del fascismo di cui, per il Mainardi, l'Armenia sarebbe la sentinella avanzata della Civiltà Romana in Oriente.
Perché questa divagazione, tra le opere di Teresio Rovere, sull'Armenia e i suoi drammi vissuti? Come più volte ha scritto, Rovere si è sempre occupato, per quanto in suo potere, delle popolazioni oppresse. Ha collaborato ai quattro anni (1915~1918) della rivista L'Armenia. Eco delle rivendicazioni armene. Rivista, questa, diretta dal poeta, scrittore, critico letterario Corrado Corradino (1852~1923). Fu proprio quest'ultimo ad indirizzare Teresio Rovere alla conoscenza e collaborazione con Hrand Nazariantz che a Bari pubblicava le due riviste Graal e Graalismo. (Per la prima conoscenza tra i due vedere la lettera che Rovere scrisse come presentazione a Nazariantz riprodotta più oltre nella descrizione della più completa opera di poesia del Rovere Visioni del viandante.) Non ho certezze in merito per mancanza di documenti probanti, però immagino che sia stato il Rovere a mettere in contatto Luigi Olivero con Hrand Nazariantz, sulle cui riviste, tra il 1957 ed il 1966, compaiono parecchie sue poesie e scritti.
A sottolineare gli stretti rapporti tra Hrand e Teresio, in una lettera del 25 luglio 1940, Rovere chiede a Terenzio Grandi, come in tante altre, un aiuto finanziario, il ritiro di un effetto da 100 lire. Interessante il paragrafo:
Nazariantz mi scrive che prossimamente sarà a Torino di passaggio (può darsi che in un secondo tempo mi precisi il giorno e l'ora) e mi prega di avvisare il "buon Grandi" e il "buon Cerutti". (Siete proprio buoni? almeno ne' suoi confronti?).
Dalla documentazione che ho potuto consultare nel Fondo Rovere a Castellamonte, non ho trovato altro che si riferisca ai rapporti tra Rovere ed il problema armeno. L'argomento meriterebbe però di essere scandagliato.
Su per l'aspra via: Poesie
L'impronta - Torino - 22 giugno 1941 Edizione non venale limitata a 300 copie - pagg 32 in 8°
Contiene cinque poesie in italiano con cinque xilografie originali di Ercole Dogliani, una di Luigi Servolini, la riproduzione di un ritratto ad olio del poeta di Luigi Boffa Tarlatta, un fac-simile. (Le poesie, anche con titolo differente, verranno riprese in diverse sezioni della raccolta Visioni del viandante) e sono introdotte da queste parole:
Dai "Canti dell'angoscia e del cimento" e dalle "Visioni del viandante" queste testimonianze di vita e di pensiero, tratte dallo scrigno dei libri ignoti, l'autore - compiendosi il suo X lustro - offre ai comprensivi.
Su Ce fastu? Bollettino della Società filologica friulana anno XVII N° 4 del 21 ottobre 1941 appaiono queste frasi:
Una delle prime copie di tale opuscolo ... è stata mandata in omaggio ad un Friulano con questa dedica: "a Ros di Vilès comprensivo spirito fraterno, offre il viandante Teresio Rovere". E il nostro ha risposto subito, dal Friuli, col seguente sonetto:
Tu se' poeta da la vena sciolta
resa a la nota che sommove l'alma:
sempre dal fondo gode chi l'ascolta
ed ammirando con amor la impalma.
Come più leggo questa tua raccolta
sento lo spirto che con lei s'incalma
su ne la luce d'un'immensa volta
ov'arte giugne a la serena calma ...
Attimi intensi di raccoglimento
or che l'umana povera fatica
più non ha pace nel suo gran tormento:
dono felice di ricchezza antica,
caro Teresio, dato, come sento,
con la più bella tua larghezza amica.
... il commento collima con quanto anche noi abbiamo sentito e goduto leggendo la poesia classicamente sana e pur fresca, viva d'immagini e d'amore della natura e delle cose belle, forte di sentimento e di passione: testimonianza luminosa di colloqui con la Musa del forte poeta torinese.
L'edizione non si vende ed è limitata a trecento copie, commentata con la finezza squisita di sei ricche xilografie del compianto artista Ercole Dogliani e del vivente Luigi Servolini, mentre s'apre con la riproduzione di un olio di Luigi Boffa Tarlatta e si chiude con un fac-simile dell'autore.
Il libretto è un vero gioiello tipografico e rappresenta una preziosità per il bibliofilo, tanto per la carta e i nitidi caratteri, quanto per l'accurata tiratura delle xilografie.
Mama
L'impronta - Torino - 1950 - pagg 4 in 8°
Opuscolo contenete la poesia in morte della madre già inserita nel testo con titolo Aniversari.
Visioni del viandante (1909~1929)
L'impronta - Edizione numerata di 600 esemplari - Torino - 22 giugno 1951 - pagg 237 in 4°
Contiene 86 poesie in lingua italiana accompagnate da 43 xilografie di Ercole Dogliani
La dedica:
Alla mia terra natale
A' miei morti che vi riposano
Al tempo e alla speranza
questi aneliti di poesia
consacro
La raccolta è preceduta dai versi del Carducci scritti per il trasporto delle spoglie di Ugo Foscolo in Santa Croce a Firenze:
Meglio trascorrer gli anni
Ne l'ombra de l'oblio, che vender l'arte
A cui d'ignobil fama aure dispensa...
In una sorta di prefazione diretta al lettore scrive:
Amo pensarti amico e, a soddisfare quella che potrebbe essere una tua legittima curiosità, ti trascrivo, da una lettera del 20 giugno 1927 al poeta armeno Hrand Nazariantz esule in terra d'Italia, queste linee autobiografiche:
Sono, per quanto è possibile fra il tormento dell'arte inconseguita e la fatica diuturna che affranca la piccoletta vita, solo. Sono nato nel 1891. Mio padre e mia madre erano persone semplici ed oneste (qualità in sott'ordine al tempo nostro). Mia madre mi lasciò quando avevo nove anni, mio padre quando ne avevo ventinove. Per me sono sempre vivi nella parte più viva del mio cuore. Da mia madre derivai l'amore alla poesia, da mio padre quello della semplicità e dell'ordine. Nacqui irrimediabilmente miope (non già di spirito). Non fui un ragazzo prodigio, e quel poco che so non lo devo alla scuola. Nel 1903, a dodici anni (ero apprendista nell'arte celliniana e spianavo le pietre a mola in un sottoscala), leggevo clandestinamente Virgilio, Orazio, Dante, Monti, Foscolo, Metastasio e, attraverso la dizione di un artigiano orafo, la poesia mi si rivelò e mi affascinò. Non la concepii mai come una ricreazione per le digestioni borghesi o come un diversivo per le domeniche plebee; ma la intesi sempre, seppure artefice rudimentale e imperfetto, come elevazione spirituale e come missione.
Sono italiano senza fare della politica. L'amore e lo studio mi fanno comprensivo e partecipe delle passioni e delle tragedie de le genti strappate a' loro focolari, degli umili, dei sofferenti.
L'arte mi rende accettabile la vita. I fantasmi di gloria non mi seducono. L'ultimo dei Sonetti de la morte e de le rose ti dirà lo stato consueto del mio spirito. I cartolari delle mie poesie recano, a mo' di epigrafe, questo distico dell'Intermezzo di Giosuè Carducci:
«E il mio canto miglior sempre è quel desso,
Quel che non feci mai».
Non ho mai dimenticato le parole di Enotrio su la mania letteraria che infierisce ne la Penisola, e cioè che qualunque ragazzo che si rispetti, a vent'anni ha già scritto per lo meno un dramma e qualche sonetto, e, unendole idealmente a quelle che si leggono sul cartiglio sovrastante lo stemma quattrocentesco murato nella ora demolita Casa degli Antonelli presso la porta Romana a Teramo (oggi conservato nella biblioteca teramana Melchiorre Delfico):
«A lo parlare agi mesura»
vado cauto nel pubblicare le cose mie.
Eccoti spiegato l'esser mio. Aggiungo che ho molti libri, e che questi sono il mio conforto e la mia sola ricchezza.
Ave!
Per i caduti : Carme
L'impronta - Torino - 1953 - pagg 4 in 8° - Edizione limitata a 200 copie
Il carme è dedicato a Giovanni Taverna
Statuario
che il sacrificio de i Caduti
serenamente
plasmò ne la creta
eternò nel bronzo
Trittico delle fate
L'impronta, Torino (1955)
Tre poesie in italiano: Ricciutella, Chiomabruna, Fiordineve. Incisione in copertina di Giovanni Taverna.
Chiosa su questo lavoro di Rovere. Nel Fondo Pier Demetrio Ferrero, presso la Biblioteca del Museo del Risorgimento di Torino, c'è un biglietto di auguri diretto a Emilia e Teresio Rovere per il Natale 1955. Pier Demetrio e la moglie Ele inviano anche alcune bottiglie di liquori abruzzesi che accompagnano con una lunga poesia scritta su tre pagine del biglietto. Rovere restituisce gli auguri accompagnandoli con questo scritto:
A questo Trittico delle fate - ed alla tradizionale ghiottoneria giandujesca - sono affidati gli auguri di - Teresio ed Emilia - deliziati dagli abruzzesi d'Annunziani liquori - e dalla pentarchia felina - per Scarabocchio e Bella - per la studiosa Lauretta - per la signora Ele - e per il Dottor Pier Demetrio Ferrero - auguri di ogni bene - che contengono il solenne impegno - di una pagina per Presentimenti e Illuminazioni - e anche una vaga - molto vaga promessa - di un soggiorno romano - dopo l'equinozio di primavera - del viandante - Teresio Rovere - Noël, 1955
Rubâiyât occidentali: fiori colti nei giardini della poesia e offerti a Nicoletta Panizzi e Giorgio Gnudi nel loro di nuziale il 27 luglio 1957 in Bologna dal giardiniere Teresio Rovere.
Stabilimento Grafico L'impronta - Torino 25 luglio 1957 - pagg 16 in 8°
Nella copia inviata al poeta Luigi Olivero, appartenente al Fondo Olivero presso la biblioteca del Comune di Villastellone, si legge la dedica:
A Luigi Olivero
con l'animo de la
vecchia amicizia. bene augurando.
Teresio Rovere
Alba del 1958
Nel proemio indirizzato a Nicoletta, Rovere spiega il significato del termine inconsueto utilizzato come titolo:
A chiarirti la parola esotica ti dirò: semplicemente Rubâyât si intitola una raccolta di poesie, ognuna di quattro versi, del persiano Omar Khayyâm fiorito nel secolo XI.
Scrive Mario Chini, nella sua introduzione alle Rubâyât di Omar, secondo la lezione di Edoardo Fitzgerald, G. Carobba, Lanciano, 1919: «Tali quartine stanno a sé; racchiudono ognuna un concetto completo, un'immagine svolta in tutte le sue parti e si potrebbero paragonare all'epigramma nostrano per la loro brevità e concisione; ma solo per questo, poiché l'epigramma non ha, presso di noi, una formula metrica stabilita, non carattere lirico come le quartine di Omar. Il quale di tali quartine scrisse una collezione molto grande, e la sua filosofia fiorisce in essa come la primavera fiorisce nelle rose».
Modesto studioso della poesia e del pensiero orientale, ho voluto cercare una rispondenza ad Omar nella poesia occidentale. Idea bizzarra che mi ha portato ad isolare strofe (non tutte quartine) di illustri e di ignoti, ciascuna delle quali, a simiglianza di quelle del poeta persiano, racchiude in sé un pensiero, una sentenza, un monito.
Vittorio Dessy
La novella di Griselda
L'impronta - Torino - 1959 - pagg 30 in 8°
Saggio della versione in ottava rima di tutto il Decameron, preceduto da una notizia e pubblicato a cura di Teresio Rovere - Incisione in copertina di Giovanni Taverna.
La Novella di Griselda
tratta dallo scrigno dei libri ignoti
pubblicata in edizione per nozze
è offerta agli Editori italiani
per richiamare la loro attenzione
su un'opera degna
Il viandante
Teresio Rovere
La Novella di Griselda, l'ultima delle cento novelle di messer Boccaccio, vede oggi la luce, dopo oltre sei secoli dalla composizione in prosa (il Decameron è stato scritto fra il 1348 e il 1353), nella veste ariostesca datale da mio zio. L'ultimo foglio della riduzione reca questa data: 18 ottobre 1890, ore 1 pomeridiane. Si tratta di centinaia di fogli oblunghi, legati a quadernetti, scritti minutamente e nitidamente su ambo le facciate, dalla moglie e dalle figliuole cui il volgarizzatore, afflitto da una malattia agli occhi, dettava i versi a mano a mano che gli leggevano i brani di prosa. Così, in due anni, l'opera venne voltata in agili ottave dove della freschezza e della sapidità dell'originale nulla era andato perduto, ma anzi vi si erano aggiunti il sapore eroicomico tassoniano e la maestria delle ottave ariosteggianti, senza mai venire meno alla fedeltà al testo.
Ho scelto questa novella perché rappresenta il coronamento della singolare fatica, ed anche perché, essendo forse l'unica di ambiente piemontese in tutto il Decameron, ho voluto farne omaggio al mio vecchio Piemonte che così sovente è misconosciuto nei campi delle lettere e delle arti.
Questa novella che nel passato (quando per leggere il Boccaccio ci si chiudeva a chiave nella biblioteca domestica), figurava fra le trenta che erano ammesse nei testi scolastici, giudicandosi le altre settanta troppo «boccaccesche» per lasciarle in mano ai giovinetti (oh ingenuità del buon tempo antico!), non dispiacerà agli amici sposi per i quali è stata tratta dall'ombra.
E penso anche che possa interessare agli Editori italiani cui pure è offerta, sì che questa nobile e geniale opera di un vecchio soldato del Risorgimento veda meritatamente e integralmente la luce.
Hoc est in votis.
Quand ël cheur a parla: poesie piemontesi
L'impronta - Torino - 1961 - pagg 14 in 8°.
Contiene 5 poesie già pubblicate, tutte in piemontese, le uniche raccolte in volume autonomo e una xilografia di Ercole Dogliani in copertina.
La pubblicazione delle poesie: La Sagra 'd San Michel su Ij Brandé Prima Serie - Torino 30 giugno 1928 ripresa nel volume collettivo A Mistral, Antologia di 17 poeti piemontesi, S E L P Torino 1930; Mama (Dedica A mie sorele) con titolo Aniversari su Armanach piemontèis, Torino 1932 e ancora con titolo Mama su Ij Brandé Seconda Serie Anno II n. 27, Torino 15 ottobre 1947; Autoritrat su Ël Tòr Anno II n. 14 Roma 27 aprile 1946; Còsa i son su Ij Brandé Seconda Serie Anno III n. 41 Torino 15 maggio 1948; An riva al Lagh Magior (Dedica A Mila) su Ij Brandé Seconda Serie Anno V n. 99 Torino 15 ottobre 1950.
Il proemio è tutto dedicato alla moglie:
MILA,
si compiono otto lustri dalla nostra alba nuziale. Nei versi sgorgati nella parlata materna, che affido alla tua comprensività, a quella dei pochi e all'indifferenza dei molti, troverai qualche eco degli anni vissuti insieme.
La mia vita, non brillante né esplodente, ma contenuta, rettilinea, quasi negletta; si compendia nell'amore al lavoro, allo studio, alle creature; nell'avversione all'esibizionismo e all'arrivismo; in sintesi: povertà dignitosa.
"Nozze di rubini" secondo la tradizione, quelle che celebriamo nello stesso umile nido nuziale che le avversità non hanno consentito di fare più bello, più degno di Mila.
Abbi fede in me come io l'ho in te e nella poesia. Siimi ancora e sempre vicina.
Vittorio Dessy
La novella di Chichibio
L'impronta - Torino - luglio 1963 - pagg 16 in 8°
Saggio della versione in ottava rima di tutto il Decameron - dedicato agli sposi Panizzi ~ Degli Esposti e pubblicato a cura di Teresio Rovere - In copertina un'incisione di Giovanni Taverna.
La Novella di Chichibio
tratta dallo scrigno dei libri ignoti
è offerta
insieme agli auguri di ogni bene
a
Leandra Panizzi e Giancarlo Degli Esposti
nella loro alba nuziale
dal viandante
Teresio Rovere
Giustificazione
Tutti i brani delle lettere di Teresio Rovere trascritti, provengono dal Fondo Rovere conservato presso la Biblioteca Comunale di Castellamonte (TO) che qui ancora ringrazio per la liberalità concessami nel controllo e raccolta dei documenti necessari a questo mio saggio e, di concerto, Adolfo Camusso di Castellamonte per avermi guidato tra la massa delle carte del Fondo Rovere e aver controllato il mio scritto con conseguenti consigli e suggerimenti.
Le riproduzioni delle copertine e delle incisioni delle opere illustrate, nonché estratti dalle prefazioni e quant'altro, sono tratte dalle raccolte presenti nella Biblioteca Storica della Provincia (oggi Città Metropolitana) di Torino e da quelle del Fondo Terenzio Grandi, Teresio Rovere e Pier Demetrio Ferrero presso la Biblioteca del Museo Nazionale del Risorgimento di Torino.
Ringrazio sentitamente entrambe le Biblioteche ed in particolare la Direttrice della Biblioteca del Museo Nazionale del Risorgimento che con me è stata di una gentilezza squisita.
Giovanni Delfino
delfino.giovanni@virgilio.it
Piemontèis ancheuj, Ann XXXVI N° 11 novèmber 2018 ~ Ann XXXVII N° 9 Stèmber 2019.
La bela companìa dij Brandé
Da quel primo di marzo del 1927 sono passati ormai 91 anni. Quanti ricordano oggi le vicissitudini che hanno portato alla nascita de La bela companìa dij Brandé e alla sua originaria composizione?
Mi propongo di rinverdire quei fasti con una breve sintesi dell’iniziale avventura (1927~1931) e, quindi, attraverso la poesia dei primi Brandé, ripubblicando, per ognuno, alcune delle poesie, scelte tra quelle che più mi hanno emozionato.
Ij Brandé
1915, Parma. La prima guerra mondiale incombe. Pinin Pacòt vi si trova per il corso allievi ufficiali. Incontra per la prima volta Oreste Gallina. A Pinin la parola, tratta dalla prefazione che detta per la raccolta di poesie di quello che diventerà suo grande amico Freidòline:
Parma, la vecchia città ducale, piena di silenzi e di ricordi, dal grande parco abitato d'ombre, ove la sera sognavamo dolcissimi convegni di dame e cavalieri; Parma, dai grandi palazzi austeri e sonnolenti, risvegliati improvvisamente dal rintronare dei passi in cadenza sotto gli atri profondi.
Gallina, l'occhio vivissimo sul bronzo del viso incoronato dalla folta chioma corvina, portava dai campi che lo videro nascere quella naturale sicurezza, ingenua e disinvolta, che dà la terra ai suoi figli; io, dalla città piena di multiformi artifizi, la mia timidezza. C'incontrammo e diventammo amici. Allievi ufficiali nella stessa compagnia, passammo insieme i mesi di corso, inondando di sogni e di canti la triste monotonia della vigilia di guerra.
Ricordi, Oreste, le lunghe marce, sotto il dardeggiare del sole, per la campagna emiliana, attraverso alla densa e rigogliosa vegetazione, dal fogliame stancamente accasciato nella calura? Ricordi le interminabili esercitazioni, l'ordine sparso agile e snodato, il solenne e coreografico ordine chiuso, sul greto arso e infocato del torrente sotto la canicola d'agosto? Ricordi? In quelle ore monotone e pesanti, in quella fatica estenuante ci era conforto l'eguale sogno, la comune aspirazione, lo stesso amore per il Piemonte lontano e per la poesia; e allora la poesia, informe e spontanea, fluiva a ondate dai nostri cuori, e nelle nostre parole, per quanto povere e umili, era sempre un riflesso luminoso del nostro sogno di bellezza.
Le diverse destinazioni ci separarono; subimmo la stessa sorte, e ritornati, dopo l'immane tragedia, dagli squallidi Kriegsgefangenenlager, ci ritrovammo, fedeli sempre allo stesso sogno e con lo stesso amore.
Passano alcuni anni e, tra la fine del 1926 e l’inizio del 1927, i due, con un altro amico, Alfredo Formica, scrittore e, soprattutto, editore, danno vita alla pubblicazione, il primo marzo del 1928, del quindicinale Ij Brandé Arvista piemontèisa. Alfredo Formica, fratello di Remo, anche lui scrittore ma, in particolare, recensore (autore del saggio sulla poesia piemontese In Beozia 1929), nella direzione della rivista, insieme a Pacòt e Gallina, si firma Vigin Fiochèt.
Dal primo numero la dichiarazione d’intenti dei tre:
I scrivouma 'l piemonteis perchè ch'i lou parlouma, e i lou parlouma e i lou scrivouma pròpi 'd cheur, ades ch'a smija ch'a vada perdendsse, dëspresià e dësmentià da jë stess piemonteis ch'a lou arnego.
Sa l'è vera ch'a staga per meuire, e bin, noui i vorouma nen ch'a meuira! Coun tut nòst sentiment e coun tuta nòstra fòrssa i s'oponouma.
Nòstra arvista, pcita e pòvra couma ch'a l'è, a nass apòsta per difendlo, nòst parlè e con chiel nòstra tradissioun, nòstra stòria, nòst caràter, perchè noui, italian e piemonteis, i savrouma esse 'd boun italian quand ch'i l'abio 'mparà a esse 'd boun piemonteis.
L'è sòn lòn che noui i vorouma: salvè nòst parlè. Salvelo sercand ëd rendje soua finëssa e soua fòrssa, soua serietà e soua blëssa, sercand ëd rendje sò patrimòni 'd paròle e d'espressioun nostrañe, sò found d'ideje e 'd sentiment piemonteis. E parei, senssa tema e senssa gena, i sercrouma 'd fé arvive le veie paròle bele ch'a peusso smijene dròle, perchè ch'i l'avijo desmentiaje: i finirouma per arconòssie e i tornerouma a sentije nòstre, naturale e frësche couma 'nt ël linguagi ch'a parlavo i nòstri vej, piemonteis ëd na vòlta, travajeur an pas e coragious an guera.
Senssa blaga, a l'è coust 'l dover ch'i s'imponouma, sperand che l'aprovassioun e l'agiut 'd coul ch'an capisso, a peussa permëtne dë riesse an cousta nòstra fatiga.
Sempre nella prima pagina del primo numero il pezzo a firma Pinin Pacòt Dialèt o lingua:
Dialèt o lingua, l'un e l'àutra; basta metsse d'acòrdi ant ël sens ëd le paròle.
Per noui, un dialèt as diferenssia da na lingua, pi che tut perchè, avend un vocabolari pòver, adatà mach a jë bsogn 'd na regioun e destinà a la conversassioun, a peul nen serve aj fin motoben pi àot d'una lingua: un dialèt a l'è mach 'n parlé local.
Dialèt fiña a quand ch'a serv mach per esprime jë bsògn pi comun, un parlé as trasforma ant na lingua quand che, chitand d'esse mach na fonssioun ëd la vita 'd tuti i dì, a dventa l'espressioun coletiva 'd l'ànima d'un pòpol. Antloura coust parlé a pija 'n valour spiritual. Sentiment, aspirassioun, penssé, ideai ëd na regioun ò 'd na nassioun a s'esprimo 'nt soue paròle, e coul che prima a l'era mach ël parlé d'un pais ò 'd na sità, dëspresià 'n comparassioun d'un'àutra lingua pi nòbil e dignitousa, a dventa 'l ségn ëd arconossiment ëd tuti coui ch'a lo parlo, an simbolisand la rasoun d'esse d'un pòpol.
Per coust sò neuv valour ël dialèt dventa lingua.
Se dë scritour a lou dòvro servendsse ëd soue soule arssousse, aj na vnirà fòra na leteratura ch'a sarà 'd sicura locala, tant per l'ispirassion che per la fourma. Le scritour ëd rassa, coul ch'a peul nen contentesse 'd coust pòvr utis, a deuv për fòrssa completè sò vocabolari, piand pa mach dai parlé dëvsin, ma 'd cò da coui pi lontan 'd l'istessa famija, le paròle ch'aj manco: parei a peul creé, ò fè arvive, la lingua ch'a esist an potenssa, divisa ant tuti i sò dialèt e sout-dialèt.
E parei 'd cò, nòst dialèt piemonteis a peul aossesse a lingua: basta ch'a sija sincera ant chi ch'a scriv, la cossienssa 'd la dignità dël linguagi ch'a dovra; basta che coun l'amour e lë studi a l'abia capine profondament la natura, e a l'abia la veuja e la forssa d'adatesse a 'n travaj ëd passienssa, che, s'a peul parësse ridicol, a l'é 'd cò 'l soul ch'a peussa permëtie 'd realisé sò seugn.
Per lòn a bsògna podei liberé 'l parlé e le composissioun leterarie da tute j'idéje malsañe ò grossere, da tuti j'italianism d'importassioun e da toute le fourme guaste ò forestere: a bsògna fè arvive tute l'espressioun nostrañe, tute le paròle an tute le manere verament ch'a veui d'essi conservà per tradissioun ant le campagne, lontan dal soufi e dal countat dla sità douva 'l parlé l'è vissià da l'arvisinanssa continua coun 'l linguagi nassional.
Ma se scrive 'n piemonteis a l'è 'l prim dover dlë scritour piemonteis, costi a l'à 'd cò n'àut dover: coul ëd fé nasse ant ël pòpol ch'a lou circounda sò istess amour për ël parlé, che i nòstri vei a l'àn lassane, coul ëd deje al pòpol ël senss ëd nostra rassa, l'orgheui 'd nòstre tradissioun e 'd nòstra stòria, ël sentiment dla blëssa 'd nòstre tere.
Perchè ch'a bsògna nen che lë scritour, ël poeta, as sara ant la tour d'avòri 'd la poesia; ma bsògna ch'a intuissa e ch'a spiega chiel coul ch'a l'é lë bsògn popolar; a bsògna ch'ai mostra a j'àutri lòn ch'a l'é sta lingua ch'a sèrco, a bsògna ch'ass fassa chiel ël difenssour ëd le tradissioun, l'ilustratour dël passà e 'l maestro 'd l'avnì. Perchè ch'a bsògna che al seugn di poeta a corispounda lë bsògn del pòpol. Un a l'è necessari a l'àot.
Na lingua, per raire e soasije ch'a sijo soue manifestassioun leterarie, a l'é artifissial peui mach fiña a na sèrta mira. A l'é na fioritura 'ns la pianta patanùa dël dialèt, e a bsògna ch'as nutrissa sprofondand le radis ant la tera. E la tera l'é la cossiensa dël pòpol ch'a la parla.
Mach antloura, quand ch'a sija formasse cousta cossienssa 'd nòstra perssonalità regional, a podrà nasse na vera poesia piemonteisa, e coun la poesia na leteratura, e 'l piemonteis esse lingua.
L’impresa dei tre, per questioni finanziarie, si ferma con il quinto numero. (Il contenuto dei cinque fascicoli è ampiamente descritto in Pinin Pacòt tra poesia, prosa ed editoria dal 1926 al 1938 pubblicato tra il marzo 2014 e il febbraio 2015 su questa stessa rivista)
Nel frattempo a Torino, su iniziativa dell'Avvocato Eugenio Rastelli, Direttore Tecnico per il Folclore dell'O.N.D. Opera Nazionale Dopolavoro, nell'inverno 1929~1930 si tengono una serie di riunioni nella sede provinciale di Torino per giungere ad uniformare la grafia del piemontese. I lavori avranno poco tempo a disposizione e si concluderanno con la presentazione della grafia messa a punto sul primo volume della appena nata collana Scrittori Dialettali Piemontesi della S.E.L.P (Studio Editoriale Librario Piemontese). Alle riunioni partecipano, oltre l'Avvocato Rastelli, Matteo Bartoli, Nino Costa, Alfredo Formica, Ferdinando Neri, Luigi Olivero, Giuseppe Pacotto, Leo Torrero e Andrea Viglongo.
Da quel momento la grafia prende il nome di Pacotto~Viglongo e, tutte le volte che se ne parlerà, scientemente si tralasceranno i nomi degli altri che hanno contribuito al lavoro. Lavoro che poi, in pratica, si limitò all'eliminazione della ô e della ñ, all'introduzione di qualche accento grave o acuto e al trattino di separazione tra la n faucale e la vocale che segue (lun-a).
Attorno a Pacòt iniziano a raccogliersi altri giovani poeti ed ecco come Pinin fa cenno a Luigi Olivero della consistenza della Companìa in una lettera del 29 luglio 1930:
I l’hai trovà n’apassionà (29 agn) d’ nòst folclòr, ch’a l’ha cujì e ch’a l’ha contà ant na manera delissiosa le stòrie, le faule, le legende d’soa region alessandrina, ant un bel piemonteis pien ëd saiva e pien ëd calor. Aj publicrà prest e a sarà na bela còsa. (Nino Autelli, Pan 'd coa)
Alfredino a më scriv ch’a l’ha decidù un sò amis a scrive an piemonteis: n’autr prosator!
Mi l’hai decidù Rovere; Tòta Rocco a scriv ëd poesiòle ch’a son delissiose; Signorini a l’ha d’ bona intension (a l’halo fait quaicòsa a Vilastlon?). E peui t’jë ses ti, j’é Alfredino, j’é Brero, j’é Galina, j’é Motura, modestament d’cò mi, e chissà vaire d’autri ch’i troveroma, amis e scritor piemonteis. Coma ch’it vëdde, mal contà, na desena già.
Nella prefazione che dedica a Pan ‘d coa di Nino Autelli del 1931 da Pacòt vengono brevemente tratteggiati i componenti attuali del sodalizio:
Così, accanto a chi, come Teresio Rovere, dalla meditazione raccolta e dalla contemplazione trasfigurante, sa trarre ritmi larghi e sereni, percorsi da un intimo tremito di commozione e illuminati da un pensiero nobile e grave; o accanto a chi, cercando in se stesso (Pacòt), dopo essersi avidamente inebbriato della bellezza delle cose, lungo le strade percorse e nelle lontananze sognate, vorrebbe esprimere, nella desiderata e non mai raggiunta rara musicalità del verso, la preziosità di un pensiero in cui si fondessero le misteriose corrispondenze fra l'anima sua e il mondo; c'è chi, come la Carlottina Rocco, si abbandona alla freschezza dell'ispirazione ed esprime, con una immediatezza che non esclude l'arte, nella chiarità delle strofe, lo spontaneo fluire d'una lirica fatta di sensazioni squisite e di suggestioni sottili, sgorgante canora come alpestre acqua sorgiva.
Così accanto ad Alfredo Nicola ed Armando Mottura, appassionate anime cittadine, poeti d'amore, giovanilmente ardente il primo, e trasognato l'altro, nostalgicamente sognanti liriche evasioni verso la verde quiete della campagna od eroiche elevazioni verso le immacolate vette dei monti, un altro gruppo di poeti canta un ben diverso canto.
Figli della campagna, contadini fin nelle più profonde fibre, esiliati nella modernità vertiginosa della vita, essi esprimono nella loro poesia il canto stesso della terra, che,simile ad una linfa, sale alle loro bocche dai solchi ch'essi percorsero nella loro spensierata adolescenza.
Oreste Gallina, che, dopo essersi cercato e tormentato componendo in torinese, trova finalmente la sua strada e questa percorre superbamente quando, ritornato al suo rude dialetto delle Langhe, canta, (Canta, Pero!) e non più compone quella forte poesia della natura e dell'uomo, che gli gonfiava l'anima con repentini scoppi di niostalgia.
Luigi Olivero, che lancia i canti come l'anima attraverso la pianura della sua Villastellone, ricca d'acque specchianti e di pronube ombre, e riflette nei versi la sua vibrante anima di giovane fauno, aperta non soltanto a tutti i ritmi della natura e dell'amore, ma anche alla sperduta e morente poesia popolare echeggiante nelle fiabe, nelle leggende e nelle canzoni. Una moderna, sottile vena di ironia sottolinea e rialza la immediatezza dei suoi versi.
E Renzo Brero, che si libera finalmente da ogni maniera e da ogni influenza, per ritornare alla sua prima giovinezza, quando:
Mach che 'l sol luseissa an cel
che na rama ant le campagne
a buteissa un but novel,
egli correva libero
për i camp e le caussagne
sensa pene, 'l cheur content,
tra le fior ëd le campagne,
come 'n fòl, an brass al vent!
Da questa profonda, intima fonte egli trae una commossa e chiara poesia.
A questi poeti della terra, viene ora ad aggiungersi Nino Autelli, poeta che non scrive versi, ma ci offre in queste sue narrazioni, una schietta poesia popolare, che come il pane del contadino, 'l pan 'd coa, ricco di glutine, ha il caldo sapore della terra.
Tralascio le pagine che Pacòt dedica alla novellistica popolare e a Nino Autelli, riporto però la chiusa:
I giovani poeti piemontesi si sono riuniti in una «Companìa di Brandé».
I «Brandé», sono gli alari.
Il fuoco arde tra gli alari, ed una nuova fiamma si è accesa.
Che il vento gelido dell'invidia non la spenga con un soffio di scoraggiamento.
Il fuoco della poesia ha ricominciato ad ardere. Al nucleo originario molti altri giovani poeti si uniranno. È tempo ora di rileggere alcune delle loro poesie.
N O T A
La grafia delle poesie e dei racconti che seguiranno, rispetta (salvo eventuali errori di composizione tipografica) il testo così come pubblicato nell’opera riportata in calce ad ogni poesia e/o racconto. Si potrà così seguire l’evoluzione della grafia del Piemontese a partire dai testi precedenti il 1930, che riportano la grafia de ‘l caval ‘d brôns; poi, mano a mano, rispetterà sempre più quella proposta da Ij Brandé.
Giovanni Delfino
delfino.giovanni@virgilio.it
1895 ~ 1985
Oreste Gallina, che, dopo essersi cercato e tormentato componendo in torinese, trova finalmente la sua strada e questa percorre superbamente quando, ritornato al suo rude dialetto delle Langhe, canta, e non più compone quella forte poesia della natura e dell'uomo, che gli gonfiava l'anima con repentini scoppi di nostalgia.
Pinin Pacòt, dalla prefazione a Pan ‘d coa di Nino Autelli del 1931.
Mia tera…!
A mia mare
Parla, me cheur, ch’it bate sensa pas,
sperdù parei ‘d na ciòca ‘n found ‘d la val;
parla per ti, ma dislo lòn ch’it l’às,
ch’it ses così sciassà ch’it ëm fass mal.
Perchè ch’it bate li tut angossà ?
Seugnësto foursse, ‘nt l’oumbra ‘d tò sagrin,
‘d sente torna le stòrie ‘d lè vijà,
‘d véde le faje chiñe ‘ns ël cussin ?
Al tourno foursse i seugn viscà dal soul
e spatarà dal vent quand ch’i durmija,
cunà dal crij ‘d le siale, ai pe ‘d na roul,
i rissolin ant l’erba ch’a fiorija?
Guarda, me cheur, i seugn a soun farfale,
l’è inutil ch’i të sbate e ch’i t’arbate:
lour a svolato al soul, së striso j’ale,
a casco ‘n tera e peui, guardije, a soun gate!
Soun teile d’òr, che ant un moment së struso,
scianchije ‘sti seugn, e peui pitòst che arnesse
ant na vous ràocia, ò cheur tut quatà ‘d raso,
Nossgnour perdounme, ma l’è mei fërmesse!
Oh, sì! Pitòst che costi arbut ‘d na vita,
faita ‘d fojagi ch’a së sperdo al vent,
e faita ‘d rame voltà a snistra e a drita,
sciancà giù da le grinfe ‘d costa gent,
l’è mei n’arbut ‘d la sëpa bin piantà
su pr’ël soli: mei… meuire! E peui ch’i arviva:
i pe ‘nt la tera e j’euj drit a la pnà,
sciassand le man faità dal pugn ‘d la stiva.
Veuj sente monté su per le naris,
intré ‘nt i dii, ant j’òss, fiña ant la mioula,
l’odour ‘d la tera, ‘l gëme ‘d le radis
e le canssoun… che a mi ass dëstisso an goula!
N’ai prou ‘d profum e ‘d bouche ambërlifà,
n’ai basta d’arie dròle e d’impostura…
me cheur a seufr… a sëca ant la sità…
…i sarai quader… ma veuj d’aria pura!
I veuj l’incenss che da le preus a s’àossa
ant l’aria còtia, ant l’aria arsserenà
da le canssoun ‘d na fija che, dëscàossa,
a va cujend jë spì per la carsà.
Boun coul incenss che da ‘nt ij sourch a sfuma
su verss ël cel duvert a benedì
ël sacrifissi ‘d l’òmo ch’ass consuma
fintant ch’aj resta në sbarlum dël dì.
Là j’è la smenss ‘d la volontà d’assel,
la smenss ‘d la pas, ‘d la gòi, la smenss ‘d la fòrssa
che mi l’ài nen… perché tò arbut novel,
ti nòno, t’às vestilo ‘d n’àotra scòrssa!
E adess, per me maleur, l’ài mach ëd feuje
che ‘l vent a scianca, ël vent ëd la sità,
e i podrai nen canté, s’i peuss nen cheuje
jë spì d’òr ans le pere ‘d mia carsà!
L’ài da manca dël soul e ‘d la frescura:
l’ài mach un seugn ch’a rij mentre a s’àosiña:
…pòrtme, nòno, lassù… ‘nt coul’aria pura…
…lassù… mi veuj arnasse! Ans la coliña!
A me pare
La neuit a pòch a pòch a ven da manca ;
le steile a soun dëstisse e ‘l cel a sagna,
peui a s’anlupa ‘d lus sempre pi bianca,
e ‘l soul ch’a micia… a spunta ‘ns la montagna.
E ‘l brich a tas, e ‘nt la rosà a tramoula,
scroland le feuje ‘d j’erbo ‘nsugnochì:
a j’è ‘n bësbié per l’aria, e na vous soula
a s’àossa ardija: ‘n crij… chicchirichì…
Peui n’àotr e n’àotr ancora pi lontan:
a slargo tuti ìl bech, d’an s’ël pajè,
e giù, d’an brich an brich as dan da man
tranta galucio an brando a crijassé…
L’aqua a gargouja e j’arssigneui cantand
a formo ‘n còro e la canssoun a scours
sempre l’istessa… la canssoun, da quand
ch’a l’è slargasse al soul la prima fiour.
E a s’àossa e a passa e l’aria la compagna
souta na pieuva ‘d lus, ch’a së sbardela
an loungh e an largh per tuta la campagna…
oh, quanti cheur ch’a s’àosso për cantela!
**
- Gip! – Hep? – Va campé giù da mangé ai beu, -
a l’è la vous dl’amssé carià ‘d sermenta,
perchè Catliña a peussa visché ‘l feu
e buté su ‘l paireul per la polenta.
Peui as n’andran coun veil e sapa ‘n spala,
bele adasiòt, chè ‘l soul l’è peña dossà,
cantand an còro coun i breugh dla stala
- E la violeta ch’a la va ‘nt ël pra…
- Ma guarda mach dôva ch’it treuvô, ciaô,
me car Giandôja, o Re d’ij Bicerin,
nemis d’la dôja t’ses adess, e braô,
t’ses dventà astemio? It beive al sigilin!?
- Ma molla! – (am dis fasend biaôté ‘l côdin)
- Che ’d sagna! A l’àn butate a fè ‘l babaô?
- Babaô a sarà chiel! – It mësce ‘l vin
ch’it l’às beivù na volta!? Ma va ‘l diaô! –
- E daila!? – Mi sô sempre stait parej!
Le cose mese bianche e mese rôsse
am piasô propri nen; quand ch’i l’hai sei
i beivô o l’un o l’aôtr e… ti va a Siôsse!…
- T’salut che boria!? – E si! ‘l mônd l’è cambià!
Adess as viv da ciôla… o d’anrabià! –
Da Freidôliñe (1926)
(Pero ch’a cônta)
- No, no, no!
ô r’è pi nen côl ‘d pruma!… andôma, Po
r’è sempre Po, r’è nen d’ventò na sota…
Ma, neh, capime: nôi, ch’i sôma no’
per ra sopa, ra fômna e na pagnota,
tant e cambiôma nen ra nostra co’
per tut Tirin…
- Ma manch r’ôdôr dra crota!
E r’eu ciamoje a un: «Ma’andôa ch’i sôma?»
r’ha beicome ‘d traverss er parapieuva,
e: «dove credlo d’esser chiello? A Rôma?»
r’eti capì? ô vniva da lasù…
e r’ava ‘n bel ciamè! neh, chiel mônssù?
Da Freidôliñe (1926)
Bibliografia
Giuseppe Pacotto 1899 ~ 1964
… chi, cercando in se stesso, dopo essersi avidamente inebbriato della bellezza delle cose, lungo le strade percorse e nelle lontananze sognate, vorrebbe esprimere, nella desiderata e non mai raggiunta rara musicalità del verso, la preziosità di un pensiero in cui si fondessero le misteriose corrispondenze fra l'anima sua e il mondo
Pinin Pacòt, dalla prefazione a Pan ‘d coa di Nino Autelli del 1931.
blañbliña bliñblaña,
l’è avsiña, lôntanña
la vôs cantariña;
che ‘nt l’aria a spatara
dle note lucente,
e ‘nt l’àninma it sente
sôné côsì cara;
che drinta at dësvija
le rime pi bele,
che peuj të sbardele
‘nt la strofa fiôrija?
*
**
Blañbliña bliñblaña,
s’ël serio, per rije,
tra seugn e fôlie
ël cheur a davaña.
Cheicosa të scianca
la vita ch’a passa,
la vita, ma ‘t lassa
cheicosa pi bianca,
cheicosa ‘d pi candi
dla fioca sle sime:
na nivôla ‘d rime
ch’a stan per piè l’andi.
*
**
Viôlet e scarlata
l’è ‘l cel sla môntagna:
la fioca, cômpagna
dla nivôla mata,
a smija ch’a cheuja
ël rôss ch’a sangôña.
Ant l’aria a frissôña
sutila na feuja.
E l’ômbra che adasi
a cala ‘ns la vita,
al seugn a t’invita,
at cuña e ‘t fa tasi.
*
**
An cel a j’è ‘d voli,
ch’a passô e ‘s lôntanô:
mi i seugnô e i bliñblañô
guardand j ‘arssivoli.
Da Arssivoli 1926
Al Rev. Don Giovanni Milanuccio
J’ANGEI
Gloria, gloria al Signôr an mes al cel steilà.
e pas an tera a j’om ëd bôña vôlôntà!
IJ RE
Sôla a splenda la steila ant le neuit freide e scure,
e nôi sôma rivà guidà da so lusôr:
i l’ôma passà ij mar an furia e le pianure
ëd sabbia ‘n feu pr’avnite a venerè, Signôr,
e dnanss a ti, ch’it rije an mes an reu splendent,
a s’anginôjô ij re, ch’a veñô da l’Orient.
IJ PASTÔR
A calô giù jë strôp d’nostre bianche cômpagne,
côme nivôle bianche a calô verss ël pian,
e nôi apres a lôr, lassà nostre môntagne,
për pôdeite adôrè. Rivôma da lôntan:
e la steila, lusenta ansima ai pich giassà,
l’à môstrane la stra traverss al verd dij prà.
J’ANGEI
Gloria, gloria al Signôr an mes al cel steilà.
e pas an tera a j’om ëd bôña vôlôntà!
IJ RE
Sle sabbie dij desert le file ‘d drômedari,
prôfilandse ‘nt ël cel a l’an pôrtà ij tesor,
la mira d’Abissinia e l’incenss dij santuari
e ‘l fieul lusent dël sôl, l’amôr ëd tuti, l’or,
ch’i pôsôma ai to pè, pr’adôrè ‘nt so splendôr,
ant la masnà ch’a nass, la gloria del Signôr.
IJ PASTÔR
Nôssgnôr, nôi ch’i savôma ël freid d’la tramôntaña,
quand ch’i marciôma ‘d neuit sôta lë sgôard dij cei,
per ch’it peusse scaôdete it pôrtôma la laña,
ch’i l’ôma, mach për ti, tôsônà nostri agnei,
e për glôriete, ai pè, Nôssgnôr ëd carità,
i t’ôfrôma nost cheur e nostra pôvertà.
J’ANGEI
Gloria, gloria al Signôr an mes al cel steilà.
e pas an tera a j’om ëd bôña vôlôntà!
Da Arssivoli 1926
Primavera
Deurb la finestra, poeta, che ‘l sol së spatara ‘n toa stansa:
aj nassrà na speransa, minca un seugn ch’a t’ancanta.
E le róndole svice at diran le rijente paròle,
ch’a profumo le viòle, che la lodola a canta.
E deurb l’ànima a st’aria piena ‘d vòli ant ël cel e ‘d rijade,
e ‘d profum e ‘d cantade, e dë smens frissonante,
perché ti ‘t peusse vive le vite pi aute e profonde,
per ch’it perde e it confonde con j’osei e le piante;
per ch’it sente e ch’it cante le vive creature sorele,
le còse sempi e bele, con toa vos faita pura,
ansema a la róndola ch’a vòla per l’aria serena,
con la pianta ch’a pena, con la pera ch’a dura.
Da Crosiere 1935
Hunc lucum tibi dedico consecroque, Priape…
Catullus
Bon dé Priàp da le frev dl’istà,
tut galarù va svantajand la cova;
con lë spervëzzo ant j’òss a fa la rova
sicur dla gòi che chiel a cujirà,
e peui as cogia ai pé dla bussonà.
Mòla molzina, china su la brova,
reusa novela ch’a së slarga e a crova
lo anlupa ant na cascada profumà.
Reusa novela che ‘d piasì as dësfeuja
versand la copa piena dle soe veuje,
ch’a rubato pian pian feuja per feuja,
antant che ‘l dé, con j’euj avisch ch’aj rijo,
a pòsa i làver su ‘n bochin da cheuje.
E le bergere, ahidé, s’a scapo e a crijo!
Da Crosiere 1935
Gioventù, pòvra amija,
finìa
l’é sa giornà rijenta
ch’a l’ha fate contenta,
e cost sol ch’a tramonta
a pronta
n’autra bela giornà
për d’autri annamorà.
Ma, për noi doi, la seira
s’fa neira
e a slarga ij brass dë vlù
për cheujne, ò gioventù;
e noi ch’i soridoma
i l’oma
un cit frisson sutil
drinta lë sguard tranquil.
Da Gioventù, pòvra amija… 1951
Val ëd Tàner
Una nuvola mata
a gieuga ‘d zora a Non:
una stèila a rubata
e a s’aussa na canson.
Le stèile a son là ‘d zora
e ij giovo an mes al pra
a canto për la sgnora
una canson ch’a va,
ch’a va fin-a a le stèile!
Mi ‘m perdo ant ij tò euj,
ché ant l’ombra ‘d toe parpèile
a së s-ciariss la neuit.
Da Gioventù, pòvra amija… 1951
Da cartolina datata 15 marzo 1932, proveniente dal Fondo Olivero di Villastellone e diretta a Luigi Olivero, il settimo sonetto della raccolta “Le reuse ant j’ole” composta da sei sonetti di Pacòt ed altrettanti di Olivero:
(Sul verso della cartolina)
Daje n’andi, Vigin, che sensa pen’a,
i rivroma a ‘nterssene na dosen’a! .
Ante scriptum)
E daje ‘n sj’ole!
Settimo sonetto da “Le reuse ant j’ole”
Sèt sonèt, coma ‘n cel le galinele
ch’a picòto le stèile ch’as dëstaco
arlongh la longa e ciaira stra ‘d San Giaco
ant le neuit ch’a së smon’o le fumele.
Sèt anej d’òr, forgià ‘nt ël feu - ch’as taco
coma ‘nt l’amor le boche grame e bele -,
d’angarlandé, con j’ole, le vassele
ch’a fan beuje la glòria ‘d pare Baco.
Ma ‘n costì ch’a fa sèt, mè car Vigin,
de prufundis confesso ch’a l’é vera,
ch’a j’é scrit drinta j’ole nòst destin: :
nòst destin, ch’a l’é pen-a un pugn ëd tèra,
dova ch’aj nass na fior per na matin,
angrassà con ël sangh ëd nostra guèra!
Bibliografia
Crosiere – A l’ansëgna di Brandé – Turin – 1935
Speransa – La Piemontèisa – Turin - 1946
Gioventù pòvra amija… - Ij Brandé – Turin - 1961
Sèira – Famija Piemontèisa – Roma – 1964
1908 ~1993
…c'è chi, come la Carlottina Rocco, si abbandona alla freschezza dell'ispirazione ed esprime, con una immediatezza che non esclude l'arte, nella chiarità delle strofe, lo spontaneo fluire d'una lirica fatta di sensazioni squisite e di suggestioni sottili, sgorgante canora come alpestre acqua sorgiva.
Pinin Pacòt, dalla prefazione a Pan ‘d coa di Nino Autelli del 1931.
An sla brova dël senté
An sla brova dël senté,
chi l’é nen ch’as fërmerìa,
a l’ombrëtta ‘d na gasìa,
dòpo tanto caminé?
Un moment a sté a scoté
lì sla brova vërdolina
la vos frësca dla boschina…
Peui tornesse ancaminé…
An sla brova dël senté,
chi l’é nen ch’a cujerìa
cola fior ch’a l’é fiorìa
per podeila regalé?
An sla brova dël senté,
chi l’é nen ch’as fërmerìa,
a l’ombrëtta ‘d na gasìa,
un moment a riposé?
Da An sla brova dël senté 1933
Madamisele an vesta d’ mussolina…
anlora i deurbe con un pòch ëd neuja
vòst parasol tut fait a volanin.
I passe, e antant da sota la scufiëtta
vë scapa scarpentà quaich rissolin;
as vèd pena la ponta dla scarpëtta
ch’a seurt d’an mes le pieghe dël cotin.
Madamisele an vesta d’ mussolina,
fine, distante, con lë sguard lontan,
a còsa i pensse sota l’ombra fina
dël parasol leger fait a volan?
Tant ch’i guarde na nìvola lontana,
stërme un sospir daré dla vantajina,
e i passe smorte, con na grassia vana,
madamisele an vesta ‘d mussolina.
Da An sla brova dël senté 1933
va ciamand le monighete
e soa vos l’è così ceira,
che ti ‘t sente bsògn ‘d fërmete.
Sota i pòrti a passo a passo
doe a doe tute an fila;
drinta ‘l cheur coma ch’at lasso
una pena un po’ sutila.
As na van con le man gionte
monighete an procession,
as na van con le man gionte
monighete an orassion.
E la ciòca an verss la seira
a spatara ‘l so din din,
soa vosëtta s-clin-a e ciàira
a së slarga pian pianin.
Da An sla brova dël senté 1933
Quand ch’ai son-a mesaneuit,
ven-o sù dal fond dla bassa,
brute strije sensa deuit
a caval d’una ramassa.
‘Nt la boschin-a scura, scura,
as na van, tron-tron, tron.tron,
su e giù ch’a fan paura
a balé so rigodon.
Ma se ‘l ciàir comensa alvesse,
dòp ‘l prim chicchirichì,
chissà andoa a van stërmesse,
ch’a j’è gnun ch’a-j vëdda ‘d dì.
L’è mach pì a Stich-bërlich
sota l’ombra dle gasìe
che quaich vòlta a smija, gnich-gnich,
‘d sente ‘n po’ l’odor dle strije.
Da An sla brova dël senté 1933
dapress a na canson vorrìa andé.
- Stèila boera an cel a lus ancora -
Ma ‘l vej torototela, andoa a l’è?
Vestì ‘d seugn e vestì d’aria
va parèj ‘d na lusentela
s’na roera solitaria
an cantand, torototela.
Ombra ‘d farchèt ch’a vòla sla pianura
- arlongh ij camp, fiorì al sol d’istà -
parèj d’un vent ch’a va sensa paura,
chissà ‘l torototela andoa ch’a va?
Con le biòce ‘d n’arch-an-cel,
buta ansema tante stòrie
gropa tut con ël bindel
dle passion e dle memorie.
Le paròle anfilà parèj ‘d giajèt,
sël fil lusent ‘d na musica an sordin-a,
së sperdo ant l’aria coma ‘d cit piumèt…
Vorrìa cheuj-je ‘d cò mi, o rondanin-a.
Canta ansema a le speranse
ij magon e le ruvin-e
la rosà dle lontananse,
e le fior tacà le spin-e.
Parèj dël ciusioné dle feuje al vent,
j’è ‘n cant sospèis, për l’aria dla campagna,
e ‘l temp parèj d’un fium an sla corent,
lo pòrta da lontan e a lo compagna.
Vestì ‘d seugn e vestì d’aria
a l’è mach na lusentela,
a l’è mach n’ombra solitaria
ch’a svaniss, torototela
Da Seugn sensa pianà 1974
sël fil ëd l’onda…
J’è pen-a ‘n buf ëd vent
ch’a fà bogé le feuje
dj’erbo dla sponda.
E j’onde a van…
Rifless d’argent,
lusent.
a van
così lontan…
Ma lor lo san?
E ‘nt l’aria seren-a dël tramont
ël Monvis a l’è là,
sfumà,
a l’orisont.
E j’onde a passo sota tuti ij pont.
Da Seugn sensa pianà 1974
Bibliografia
Seugn sensa pianà – S. A. N. –Torino - 1974
ALFREDO NICOLA (ALFREDINO)
1902~1995
Così accanto ad Alfredo Nicola ed Armando Mottura, appassionate anime cittadine, poeti d'amore, giovanilmente ardente il primo, e trasognato l'altro, nostalgicamente sognanti liriche evasioni verso la verde quiete della campagna od eroiche elevazioni verso le immacolate vette dei monti, un altro gruppo di poeti canta un ben diverso canto.
Figli della campagna, contadini fin nelle più profonde fibre, esiliati nella modernità vertiginosa della vita, essi esprimono nella loro poesia il canto stesso della terra, che, simile ad una linfa, sale alle loro bocche dai solchi ch'essi percorsero nella loro spensierata adolescenza.
Pinin Pacòt, dalla prefazione a Pan ‘d coa di Nino Autelli del 1931.
‘L regal ‘d Natal
A Luigi Olivero
Savìa pà cos regaleje, epura
vôlend acôntentè me pôciôniñ,
l’avìa neñ veuja ‘d fè bruta figura
e ‘d rôbatè ‘n dôi ettô ‘d diablôtiñ…
Añlôra côn ‘na frisa d’añcalura
i l’ài gatjaie ‘l cheur un mômentiñ,
côntent se ‘na parola, anche se scura,
l’aveissa fame – ônesta – da lumin.
Ma côme ‘na côrenta campagniña
ch’a gira sensa fin, vertiginôsa,
sôa lenga l’à ciarpame ‘na rôtiña
ch’i l’ài mai vistne uña tant famôsa…
Mi quindi côn ‘na gran semplicità
‘n dôi ettô ‘d diablôtin sôñ rôbatà!
Da Penombre 1929
Il sonetto qui sopra riportato, appare la prima volta su Il Pasquino di Gec (Enrico Gianeri). Qui Alfredino manifesta tutti i suoi dubbi nella scelta di un regalo per la fidanzatina, risolvendosi infine con gli scontati e soliti due etti di diablotin (cialde ricoperte di cioccolata, allora molto alla moda). Ad Olivero, che ha letto la poesia, viene spontanea la composizione di due sonetti in cui, al posto dei due etti di diablotin, consiglia invece due etti di basin, che sicuramente sarebbero meglio accolti, in special modo dal punto di vista chemiotattico. I due sonetti, dal titolo 'L me regal, appaiono su Il più piccolo, settimanale d’attualità torinese fondato e diretto da Alberto Grappini, nel gennaio 1929. Da qui la nascita dell’amicizia tra Alfredino ed Olivero che sfocierà poi nella presentazione di quest’ultimo a Pinin Pacòt e alla sua adesione a Ij Brandé.
Penômbre
La verna s-ciassa ch’a sôrid giôjôsa
davsin a côla doira cantariña,
ch’a stërma sôta l’ômbra vapôrôsa
ël tril ‘d ‘na passarota birichiña,
l’è ‘l nì ‘d la mia esisteñssa pì grassiôsa.
Senssa l’afann ‘d la vita sitadiña,
senssa ‘l pensè d’una giôrnà scôntrôsa,
mach lì i seugnô neñ a testa chiña!
Côme la ment a và lôntan, legera,
côn l’anima côntenta e dëgôrdìa!
‘L bôgè ‘d ‘na feuja, ‘l cius d’una bialera,
‘l cant d’un ôsel o ‘l zônzônè ‘d n’avìa,
sôn côme tante stisse ‘d primavera
për ël me cheur rambà ‘d malincônia…
Da Penombre 1929
Primavere
Longh le rive
dle bialere campagnine,
tra le càone e le boschine,
l’hai cujì cole fior giàone
ch’a son prime a fesse vive.
Tanto temp i l’hai portaje
per la stra le pì lusente,
ma un bel dì l’hai spataraje
come gnente…
Da Primavere 1933
Cesiòta
As prega così bin ant sa cesiòta,
tuta silenssi e pas, tuta armonia!
L’è vera ch’a fa freid come ‘nt na cròta
e a j’è na teila ‘d ragn minca na grija,
ma cola Madonina paisanòta
l’élo nen pièna ‘d grassia e ‘d poesia?
E col ceirin, che per sté visch a lòta,
a specia nen nòstr’ànima passìa?
Ma ‘n sl’ambrunì, quand j’è col sofi pasi
ch’a va ‘nt ël cheur come l’arciam ‘d na rima,
quand j’ombre pì lontane a calo adasi
una per vòlta giù da sima a sima
quatand a pòch a pòch i frasso e i pin,
an sa cesiòta come as prega bin!
Da Primavere 1933
Nìvole
Nìvole candie, nìvole lusente,
ch’i passe ‘d zora ij tèit ëd tute ca,
e i andeve adasi, sensa feve sente,
lassand queich frisa d’ombra ant le contrà.
Nìvole ‘d fiama, nìvole violente,
- ël sol ëd feu l’è pen-a tramontà -
ch’i bruse an pressa, rosse ch’i spavente,
ant ël reu tràgich d’una gran giolà,
seve compagne ‘d l’òm e i lo tormente
mës-ciandje, andrinta ‘l cheur ancor masnà,
le veuje ciaire con le tërbolente!
E mi, guardandve con j’euj spalancà,
vëddo fesse e dësfesse come gnente
ij seugn ëd costa pòvra umanità…
Da Nìvole 1951
Martin e Martineta
A l’è festa: Martineta
l’ha sentù benedission,
e lì fòra ch’a la speta
j’è Martin con so magon.
A sorid, bela fijeta;
ël galant l’ha un tërmolon ;
ma la lenga a l’é antërdeta
e parlesse a son nen bon.
Chila a l’é un pò timideta,
lì davsin al bel garson,
ma l’ha n’aria così s-ceta
mentr a bassa ij doj eujon!
Chiel as sent come un poeta
e a l’ha ‘d rime a profusion,
ma ij ginoj fan ginojeta
e ‘l servel l’ha un lordison.
Che darmagi! Martineta
a l’ha già voltà ‘l canton,
e Martin còsa ch’a… speta
lì tut sol con so magon ?
Da Nìvole 1951
Son përzoné
Son përzoné ‘d n’afann ch’a m’ancaden-a
a la dosseur ‘d në sguard ch’i l’hai robà,
che adess, an nascondij, l’é mach na pen-a,
feria brusanta d’una lama afoà.
An vers l’avnì, scurì ‘d na nivoren-a,
van-a lusinga d’un pensé malsoà,
ël pass ë-strach a meuv a malëpen-a
gheub ‘d na fassin-a ‘d seugn dai but sëcà.
Scoto mè peis dë sparm, mè peis ëd gel,
con na pàura fòla ch’a m’angosa,
sorziera ghignonanta e sbefignosa.
J’euj, anviscà da l’ameror dl’afel,
ans la batùa spëssa dla toa pòrta,
tabusso disperà na veuja mòrta.
Da Spers 1969
Doi mandolin
Doi mandolin, na froja e na mandòla
- ël quartèt a pitaca ‘d mè papà -
lassà j’afé, ‘s dasìo la paròla
e a j’ero minca sèira a nostra ca.
Ant l’àutra stansa mi placava già
dòp ël travaj – prima mignin – dë scòla,
e sugnava ‘d patlé cole masnà
ch’am ciamavo Nicòla pansa mòla…
Da para al lum, mia mama, ch’a cusìa,
s’aussava ‘d vire, ciuto, a vërsé ‘d vin
o a ‘mbajé l’uss për vëdde s’i durmìa.
Damentre ij quatr magìster dël cantin,
desendije ‘ndrinta sensa economìa,
gratavo ‘l so «Poeta e contadin».
Da Samada 1982
Bibliografia
Penombre – Casanova & C – Turin – 1929. II ed. Ij Brandé – Turin - 1952
Primavere – Ij Brandé – Turin – 1933. II ed Ij Brandé – Turin - 1952
Nìvole – Ij Brandè – Turin – 1951
Spers – Musicalbrandé – Turin – 1969
Arcordanse – Musicalbrandé – Turin 1970
Stòrie dle valide ‘d Lans – Centro Studi Piemontesi – Torino – 1970
Samada – Ij Brandé – Turin – 1982
ARMANDO MOTTURA
1905 ~ 1976
Così accanto ad Alfredo Nicola ed Armando Mottura, appassionate anime cittadine, poeti d'amore, giovanilmente ardente il primo, e trasognato l'altro, nostalgicamente sognanti liriche evasioni verso la verde quiete della campagna od eroiche elevazioni verso le immacolate vette dei monti, un altro gruppo di poeti canta un ben diverso canto.
Figli della campagna, contadini fin nelle più profonde fibre, esiliati nella modernità vertiginosa della vita, essi esprimono nella loro poesia il canto stesso della terra, che, simile ad una linfa, sale alle loro bocche dai solchi ch'essi percorsero nella loro spensierata adolescenza.
Pinin Pacòt, dalla prefazione a Pan ‘d coa di Nino Autelli del 1931.
Reuse rosse
Nen ëd richëssa ò ‘d gloria,
ma un cantonin ëd pas,
sensa passà né stòria;
un cantonin ëd pas,
lontan da la baraca,
fait për podèi sugné,
dova la testa straca
i peussa riposé.
Una casòta bianca
ch’a guarda un tochèt d’eira;
na tòpia, un fi, na banca,
un pugn ëd tèra neira
ch’i peussa coltivé;
e tante reuse rosse,
tomàtiche, pensé,
na fila giauna ‘d cosse,
povron, e magioran-a
vsin a la trasparenta
eva d’una fontan-a
petègola e rijenta.
Avèi un bel cagnass
ch’a bàula e a mostra ij dent,
al pi leger dij pass,
a l’avsiné dla gent.
E peui una fomnin-a
ch’am ciama da la finestra,
quand ch’a l’è l’ora ‘d sin-a;
e che mangiand la mnestra,
am parla dla sartòira,
dij pois ch’i cujeroma,
dij crussi dl’arvendiòira,
dij cit ch’i compreroma…
e che setà davsin,
godendse nòst bel ni,
am parla ‘d nostra bin
ch’a finirà mai pi!
Vive la poesia,
pensala escrivla mai,
perché nòst mond a sia
lontan da tuti ij guai.
La mia casòta bianca,
col tòch ëd tèra neira,
la tòpia, ‘l fi, na banca,
la fontanin-a, l’eira,
la vos ëd mia fomnin-a,
la fila giàuna ‘d cosse,
ij përro, la galin-a…
e tante reuse rosse!
Genè 1928 – Da Reuse rosse 1947
Marcia, scarpon…
Marcia, scarpon,
su dla mulatera;
marcia, scarpon,
l’aria dla neuit l’è legera,
e tante còse dròle
a conta la stèila boera.
Ti scotje, scarpon,
e cantje ant na bela canson.
Fa le splùe precise a le stèile dël cel,
fërvaje ‘d sol sperdùe
ant la neuit fonda.
La facion-a rotonda dla lun-a,
regin-a dla festa,
s’ambarda ‘d na vesta
lusenta ‘d pajëtte d’argent.
Marcia, marcia, scarpon,
guarnì ‘d ciò d’assel,
toa ànima fòrta
a viv dl’ilusion
‘d podèi un bel dì tochè ‘l ciel.
Marcia, scarpon…
Stèmber 1931 – Da Reuse rosse 1947
Pòvra umanità
Vorrïa avèi brass grand coma ‘l mond
për ambrassete, pòvra umanità;
dëscheurve ‘l tò gran cheur giù fin-a an fond,
për pié su le mie spale ij tò pecà.
Dolor dla tèra, coma ‘t ses profond !
Vorrïa avèite tut an sla mia stra,
vëdde content na vòlta an sima al mond
sta banda ‘d pòvra gent tant tribulà.
Umanità, carià ‘d sagrin e ‘d pen-e,
t’l’has tròpe spin-e ch’at fan doloranta;
vorrïa vëdte, soridenta e santa,
gòde ‘l tò tòch ëd sol coma la pianta,
coma l’osel che a nass e vòla e a canta,
sensa tribulassion, sensa caden-e.
Gené 1930 – Da Reuse rosse 1947
Cit camp al sol
Cit camp ëd sèj al sol, d’un verd lusent,
pentnà dal vent squasi caviera ‘d fija,
ant sa stagion tant dossa e tant fiorìa
a guardete a s’arpòsa la mia ment.
Mi saro j’eui e sento ch’a bësbija
la feuja con jë spi cunà dal vent,
l’è squasi un bate d’ale col ch’as sent
ant sa gran pas ch’an corma ‘d maravija.
Ij pin ch’it l’has d’antorn at fan pa d’ombra,
ch’a l’é mesdì e ‘l sol l’é aut an cel.
Mach na nebia ‘d calor a stende un vel
sui mè sagrin. Là giù la val l’è sombra,
ma sì j’è tanta blëssa ‘d verd lusent,
cit camp ëd sèj novel cunà dal vent.
Oulx, giugn 1947 – Da Paisagi ‘ d Val Susa 1949
Château-Beaulard
Vsin a na cesa bianca e a un pòrti ombros
j’è un cioché gris. La cupola pontùa
së spòrz vers la montagna patanùa
dzora dij cop, ch’a son na macia ‘d ross.
E antorn j’è ‘l giaun dorà dle sèil madure
e j’ombre scure dij gran bòsch ëd pin,
e l’aqua ‘d rì Sopir ch’aj passa vsin
e a bagna ‘l verd ëd j’òrt e dle pasture.
Ant sa valëtta riparà dal vent
tut l’è rijent, e ste casòte cite,
ch’a l’han vist ël destin ëd tante vite,
l’han ‘d face oneste come la soa gent.
Sì, ‘t sente mach na mùsica ‘d fontan-e
e ‘l zonzoné dla vita e dël travaj;
sì, a sudo ansema j’òmo e j’animai;
e le vos dël gran mond son tant lontan-e.
Come të staghe bin pogià ‘n sël fond
ëd sa gran copa corma ‘d blëssa eterna,
con toa montagna ch’at dà vita e at guerna,
Château-Beaulard, ò cit canton dël mond !
Da Paisagi ‘ d Val Susa 1949
Invern
La tèra a deurm sota un pesant fardel,
dòp ij dì fatigos dij meis d’istà.
A l’ha fiocà sta neuit e a fiocherà
forse ‘d cò ancheui, tant a l’è gris ël cel.
Ël Chaberton a l’ha butà un mantel
da rè dla faula; ‘l bòsch e l’è anbrilantà,
ma ij cit busson smìo d’ òche quacionà,
sesì dal freid sota la fiòca e ‘l gel.
L’è coatà ‘l fòss e as vèd pi nen la stra,
né ‘l verzolin dël gran che già a nassìa,
e ‘d cò la Dòira a smija pi smairìa
tra ‘l bianch dle rive. Su, ant ij borgh sotrà,
arpòso j’òmo ansema a j’animai,
unì ant la stala coma an sël travaj.
Da Paisagi ‘ d Val Susa 1949
II
Se ‘t sènte di « la fam »
pens-je
a j’euj grand e stupì
d’ij cit ëd le « favelas » brasilian-e,
a le pupe dle mare sensa lait
d’ij cit d’ij tanti Biafra
ëd l’Africa neira e tormentà,
a le masnà strassà
che a gieugo an mes dle mnis
d’ij « cortili » ‘d Palermo
‘d je « slums » ëd Londra,
ai milion ëd man tèise
che a j’é ‘nt ël mond,
e peuj
se at vèn nen na gran sei
ëd giustissia
ò pi nèn veuja ‘d vive
an cost mond mal fait
ti
ciam-te pi nèn òmo.
Ti ‘t ses na bestia
VI
Dansé, giovo, dansé
vostra bela corenta ‘d primavera,
l’è bel vëd-ve dansé
al sol cha a scaoda ancora
l’amor che a l’è mai mòrt.
Dansé
riènd, cantand, për man,
e con ij brass duvert fé na cadèn-a
tant longa da ‘mbrassé l’umanità
e le fòrse dël mal a podran pa
tocheve.
Vojaotri iv pòrte adòss na gran fortun-a:
la gòi ëd vive
e ‘n cheur bin generos
se av lassa chërde ancora
a l’ideal
che av dev porté ‘l boneur
a coi che a seufro.
A j’aotri che an passà
corend-je apress ai vostri stessi seugn
l’han vist
tante stagion ‘d maleur
la vostra dansa
a porterà
ël sofi ‘d primavera dla speransa.
Da E adess pòvr òm…? 1969
Bibliografia
Paisagi ‘d Val Susa – A l’anssëgna dij Brandé – Turin – 1949
La patria cita – Ij Brandé – Turin – 1959
E adess pòvr òm…? – Ij Brandé – Turin – 1969
1891 ~ 1964
Così, accanto a chi, come Teresio Rovere, dalla meditazione raccolta e dalla contemplazione trasfigurante, sa trarre ritmi larghi e sereni, percorsi da un intimo tremito di commozione e illuminati da un pensiero nobile e grave…
Pinin Pacòt, dalla prefazione a Pan ‘d coa di Nino Autelli del 1931.
Autoritràt
Ne'l pericol, né 'l malheur
a l'àn mai cambiame 'l cheur.
ANGELO BROFFERIO
Na facia smòrta che mes secol 'd vita
e ij magon e le lòte a l'han scavà;
un seugn che gnun malheur l'ha cancelà,
gnanca ij luv ò ij pajasso ampastà 'd nita.
I l'hai sempre marcià 'n sla stra pi drita,
pòver e silenssios, e l'hai studià
për conòsse pì a fond l'umanità,
për nen sgairé 'l regal divin dla vita.
Anche adess che 'l tramont ormai s'avsin-a
e a pòch a pòch svanisso ij desideri,
carësso 'l seugn d'amor, 'd fraternità...
e l'ilusion che, quandi seur Catlin-a
am porterà dë 'd là 'nt ël gran misteri,
na fiama 'd poesia am survivrà.
8~14 febbraio 1946
Da Ël Tòr N° 14 del 27 aprile 1946
Montagne
A la memòria d'Ercole Dogliani
Ò bele e candie an vers al cel, montagne,
seure d' pera di seugn dl'anacoreta,
canson eterne che n'etern poeta
a canta an sla dësteisa dle campagne.
Solitarie ant la neuit, pure montagne,
regn dj'àquile e di vent, ùnica meta
d' chi ch'a veul andé d' sora dla sospeta
vita dla bassa e d' tute le magagne.
Coma n'inmensa catedral tajà
'nt la pera, con j'autar fait ëd giassé
e con i rag dla luna për candèile;
mi v'adòro ant le neuit ciaire d'istà,
quand che dj'òmini a tas ël bustiché,
e ansema a mi i ciaciare con le stèile.
8 d'agost dël 1930 – Aosta
Da A Mistral 1931
Invern
Son le giornà d'invern piovose e scure
che a riciamo a la ment le veje stòrie,
e le faule dle streghe e le memòrie
pì bele dël passà, lontane e pure.
As sente travers a l'aria ùmida e trista
come un përfum sperdù d' violëtte e d' reuse...
Le fòsse, sot la fiòca, as smio pi creuse,
e 'n cel ël gris a massa l'ametista.
J'erbo a fan pena. A l'han pi nen na feuja;
a strenz ël cheur a vëddje patanù
ant l'aria freida, con i brass stendù
parèj d' n'invocassion. La tèra speuja
a l'è la mama bona che a prepara
ant sò segret ël pan, regal etern,
mentre, a la sosta 'nt lë sciopé dl'invern,
sentoma 'l bòsch che d' sora al feu ciaciara.
Fòra, an campagna, a smìa ch'a piora 'l rol;
con chiel, tute le piante dëspujà
a ciamo, a crijo, a prego disperà
ant sò linguagi: dene un rag ëd sol.
Da Armanach piemontèis 1931
Aniversari
1900~21~IX~1931
A Ninin e Maria
Trista memoria, Stember dël neuvsent,
prim dì d'autunn pien ë côlôr ëd fruta,
ancôra dop tant temp a seufr e a sent
me cheur côla giôrnà për mi tant bruta.
Mama, vôrrïa scrivte una canssôn
côla che a viv an mi, che l'hai mai scrit,
dite la sempre pura mia afessiôn,
parlete ancôra côma fussa un cit;
parlete pian, côntete i me tôrment
che ti sôla 't pôdrïe cônfôrté,
carëssa 'd mama a pasia i sentiment,
parola 'd mama anvita a perdôné.
Pochi dì... poche neuit...Una carëssa
ùltima, côn 'd man caôde 'd frev e 'd mal...
«Ciaô gioia», ùltim salut côn tenerëssa...
peui ël deliri e l'agônìa fatal...
Povre sôrele trasôrmà 'n mamiñe,
pover papà, 'n mes al dôlôr tant fort,
oh, l'hai prôvaje prest, mi, le ruviñe,
la tragedia 'd l'assenssa e 'l freid 'd la mort.
A j'è pi nen tôa tômba, o povra mama,
ma j'è 'nt l'aria ël lament d'un arsigneul,
ma an mi l'è sempre viva la tôa fiama,
la tômba 'd mama a l'è 'nt ël cheur dël fieul.
E ti 't vive, memoria 'd le memorie,
spirit e sangh, amôr e devôssiôn,
dzôra 'd le crôs ëd marmô, inutii borie,
aôta dë dlà d'i dubi e dle passiôn.
Quand pi la vita am grôpa, e a massa an mi
côla veña 'd canssôn che ti 't l'has dame,
o mama, o mama, i tôrnô sempre a ti,
e 'l to pensè am desvïa 'd neuve fiame.
Quand le tempeste e i crussi am piegô e a smija
che a sïa neir ël cel e veuid ël cheur,
l'è ancôr la tôa memoria, o mama mia
che am dà la forssa a cômbate ogni maleur.
E seugnô che t'ëm teñe ancôr për man
ant le crôsiere për pareme ël mal,
e seugnô che t'ëm taje ancôra ël pan
ant la scudela un lôntan dì 'd Natal...
O mama, che 't l'has nen cônssù mia spôsa,
o mama, che vorrïa avei davsin,
côsì sentrïa menô fatigôsa
la bataja 'd la vita e dël destin;
côme anlôra ogni seira mi 't salutô
«o mama, ciaô, deurm bin», e lôngh la neuit
quand che tut a l'è pasi, tut l'è ciutô,
côme côl dì mi sentô ancôra ël veuid...
Ogn'ann, a Stèmber, sôta tôa figura,
j'ùltime reuse at pôrto me tribut,
côl dì l'anima mïa as sent pi pura,
e la parola am seurt côme un sangiut.
La Magna d'or, la môstra che at piasìa,
l'ha batù l'ôra trista 'd la tôa mort,
jë vnirà un dì che a batrà 'd co la mïa,
fa, mama, che côl dì mi sïa fort.
am sarerà 'nt i ripôsant so brass,
o mama bela, o mïa mama santa,
mi lô sentô, lô sentô, it tôrnerass.
27 settembre 1931 Da Armanach piemontèis 1932
A tòta Stella G.
It ciame còsa i son? E mi t’lo dijo:
tuti quanti che a marcio sor la lun-a
për arrivé a la cassia dòp la cun-a,
e s’arabato për formësse un « Io »
con dij titoj pompos mai pì finì,
‘d qualifiche che soens fan rije i givo,
purtròp a fan quaich vòlta ‘l sol ò ‘l nivo
për peui rivé ‘ndova ch’a rivo i pi.
Leaders, duces, caudillos, cardinaj,
deputati, ministr ò senator,
papàver dla finanssa ò imperator,
sovran e president e quanti mai
cap d’assiende ò dë stat l’han l’ilusion
d’esse « quaidun » an mess la massa grisa,
che s-ciav d’un distintiv ò d’una divisa
a dësmentio ‘l torment dla creassion;
am lasso indifferent, ò, tut’al pi,
‘m fan medité sui buratin uman
për i quai rason ‘d vita a l’è ‘l can-can
e ‘l parlé dël pi fòrt. Fan nen për mi.
Mi son gnente ‘d tut lon. ‘M sento fratel
anche al nemis e ‘d sora ‘d tut ai pòver,
a quanti serco ‘l pan ò ‘n po’ ‘d ricòver
an mes ai luv, a la tormenta, al gel.
Ant un mond dova tuti a son « montà »
l’è ‘n soliev esse gnente e savei seufre
an silenssi, e an silenssi podei eufre
un po’ ‘d confòrt e ‘n po’ ‘d serenità.
It ciame còsa i son? T’lo diso mi:
an mess al gran miracol ‘d la natura
i son semplicement ‘na creatura
ch’a seufr, lòta e travaja, e gnente ‘d pi.
13 Maggio 1948
Da Quand ël cheur a parla 1961
Mila, son sì, a la Gardanin-a,
an brass a le memorie, e arcòrdo ti;
ij Castej son doi pass anfacia a mi
pien ëd misteri ant l’onda smeraldin-a.
Stajà ‘nt ël cel, ant l’aria cristalin-a,
le borgà da lontan a smijo ‘d nì,
e mi arpòso guardand ant l’infinì…
pensso a Mila d’na vòlta, birichin-a.
Ven, ven al tò paijs, artorna si
sota al Sasfrà, davant al Melgoné,
e viv serenament guardand l’avnì.
T’lo sass che ti t’ sess l’ùnich me pensé,
ël Lagh a parla… ven davsin a mi,
piora pi nen… e lasste consolé.
Cànnero Riviera, 22 Settembre 1950
Da Quand ël cheur a parla 1961
Bibliografia
Quand ël cheur a parla - L’Impronta – Torino – 1961
LUIGI OLIVERO
1909 ~ 1996
Luigi Olivero, che lancia i canti come l'anima attraverso la pianura della sua Villastellone, ricca d'acque specchianti e di pronube ombre, e riflette nei versi la sua vibrante anima di giovane fauno, aperta non soltanto a tutti i ritmi della natura e dell'amore, ma anche alla sperduta e morente poesia popolare echeggiante nelle fiabe, nelle leggende e nelle canzoni. Una moderna, sottile vena di ironia sottolinea e rialza la immediatezza dei suoi versi.
Pinin Pacòt, dalla prefazione a Pan ‘d coa di Nino Autelli del 1931.
Legenda dla stèila alpin-a
«Se còla stèila a l’ha guidà ij Re Mage
a la cabana dël Gesù Bambin, ,
l’oma mach da seguì ij sò ragg divin
e troveroma ‘l Cit. Alèrte, an viage!»
dontrè guerier d’Eròd son disse anfin. .
E a l’han spronà ij cavaj, sanglan dë strage. .
Ma la stèila filanta sul paisage
l’ha sentuje e piorà sul sò destin: :
«Nosgnor, se tut mè ragg a l’è na ponta
dë spà ‘n sla testa ‘d toa Creaturin-a,
fa che i më sfriza ‘d nans che l’alba a sponta…»
Në s-ciòp immens. E mila e na stèilin-a,
cascand sui mont, l’han fàit una traponta
‘d fior càndie… A l’era nà la stèila alpin-a. .
Da ‘l caval ‘d brôns Anno XXXIX 1 gennaio 1961
Larga, da ‘n slë stradon, l’è la dësteisa
dla campagna cha slòira ‘d gnun laoror
da setssent agn l’ha pi nen faje onor.
Babi e moschin respiro l’aria peisa.
Dal Brich a Borgo, an là fina ai neivor,
nen una baucia ‘d gran, na fèrla drita,
ma ‘d tampe piene d’eva e ‘d lësche an fior,
dont la sanssùa a regna an mes dla nita. .
D’istà në strop ëd fèje a va broté
dontrè fij d’erba nisra dël rivass
e, ‘n pòch pi leugn, un cavalin pia ‘l giass.
Ma ‘l Mento – vej! – tut l’ann l’ha sò da fé:
baston e tasca, an giù fina ai polpass,
l’è la gòi dle sanssùe di paciass! !
Da Armanach piemontèis 1933
Al poeta Aldo Daverio
T’ij sente le vos ëd le ciòche roman-e
ch’a prego, ch’a pioro, ch’a rijo,
ch’a taso e a s’arpijo
pi s-clin-e
davsin-e
pi pian-e
lontan-e?
Ant l’ora
‘d mesdì ch’as colora
dël nimb andorà ch’a circonda la testa
‘d j’àngei nossent
e tuta una festa
‘d bianche colombe as na vòla
ant ël cel macià ‘d viòla
su j’ale dël vent,
su tute le pòrte
a bato nonsiand ël mesdì come ‘d man
ch’a spòrzo, giunzùe, la reusa dël pan.
Ant l’ora sèiran-a
quand che tuta la pian-a
immensa dl’immensa sità
a l’é un mar pontinà
dë stèilin-e
ch’a bruso ant la conca vlutà
dle tërsent mila cà
sprofondà
(parej ëd cuchije marin-e)
ai pé dle sèt bleuve colin-e,
le vos ëd le ciòche a frisson-o
a zonzon-o
a bësbijo
a s’anlijo
come ‘d tòrtole garve an amor
‘d zora ij bòrd d’una vasca
ant un òrt corm ëd fior.
Ma a la matin,
ant la primalba,
quand che ‘l sol a l’é un sèrcc ëd rubin
ch’a bërlus an sla valba
nen deserta
ma viva e duverta
ma ciaira e seren-a
(parej d’un gran lagh an pien-a
ch’a res na parada
‘d tërsent mila nav ancorà
con pont, siminiere, erbo, oblò ‘mbandierà)
dla sità,
anlora le vos ëd le ciòche roman-e
a son càude, a son tante,
a son sante.
E ti, cheur, i t’ancante
a scoteje.
E ti, ànima, it piore
a tocheje.
Përchè ant tut le ore
le vos ëd le ciòche roman-e
at carësso ‘d bontà
ma, a l’alba, a të stiro an sle rùpie dla front
ël Sign luminos
ëd la Cros
fàit ant l’aria da un vòle
ancrosià
d’ parpajòle
argentà
ch’a ven-o a portete, bësbiand, ël messagi d’amor
ëd le reuse d’ Nosgnor:
ëd le reuse dël cel ch’a fiorisso a milion
- dë ‘d la da le pian-e, dal mar e dal mont -
ant ij giardin profumà dl’orizont.
E le vos dle campan-e
roman-e
at visco un miraco ant ël cheur
ch’at dà la speransa, la fiusa, ‘l boneur.
T’ij sente le vos ëd le ciòche roman-e
ch’a prego, ch’a pioro, ch’a rijo,
ch’a taso e a s’arpijo
pi s-clin-e
davsin-e
pi pian-e
lontan-e?
Scotije, ò fratel piemontèis.
E prega e canta con mi
- con ij doi brass dëstèis
vèrs l’azur infinì -
për ch’a riva
a Nosgnor
la fiama ‘d tò cheur
ch’a brusa d’amor
për cost paìs ëd boneur
che ti ‘t veule ch’a viva:
che ti ‘t veule ch’a viva
përchè l’é fieul dla toa fòrza,
përchè l’é miola ed toa scòrza,
përchè l’é sangh
dël tò sangh,
përchè l’é la fior
benedìa
dël tò dolor.
Ò piemontèis,
crija
crija
crija
fòrt ël tò amor
sle vos matinere dle ciòche d’ Nosgnor.
Pasqua, 1942
Da Roma andalusa 1947
«Shéhérazade»
Nicolai Romsky Korsakoff:
Op. 35, I, Largo e maestoso
Ven. Ven con mi. Ven con mi. .
Ven con mi ant l’infinì!
La mia vela
sai slarghela,
sai guidela
vèrs ël pòrt ëd l’amor
ant un’isola an fior!
Quand ël mar a l’é un paradis dë stèile
ch’a sbërluzo ant le preus dj’onde argentà,
seugno ‘l vel ch’at sotlìnia j’euj vlutà
con ij frisson ch’am d’an le toe parpèile. .
E s-ciàiro toa caviera seulié ‘l mar
e ij tò sen, liri corm ëd tò respir,
ò Shéhérazade, sospir dij mè sospir,
lun-a reusa ‘d Sindbàd ël marinar.
Ven. Ven con mi. Ven con mi.
Ven con mi ant l’infinì!
La mia vela
sai slarghela,
sai guidela
vèrs ël pòrt ëd l’amor
ant un’isola an fior!
E quand che un vent ëd bùria a m’uca antorn
e ‘d dragh, tra ‘d lòzne ‘d sangh, a scumo an sl’eva,
sento toe man ‘d zora a mie man fé leva
sul timon che a fa ‘l sorch ëd mè ritorn.
Tornerai, Shéhérazade, ai tò giardin,
a j’arpe dle fontan-e dij tò seugn:
ij seugn d’amor che ‘t farai vive leugn
doa onda e azur së sposo ant un basin.
Ven. Ven con mi. Ven con mi.
Ven con mi ant l’infinì!
La mia vela
sai slarghela,
sai guidela
vèrs ël pòrt ëd l’amor
ant un’isola an fior!
Isfahan (Iran) Pasqua, 1939
Da Musicalbrandè marzo 1983
A Max Jacob
Beat ij cit ch’a son nen nà
e coj ch’a nassran mai
su costa tèra d’òmini sarvaj
ch’a giuro sul vangel dla crudeltà.
Beati j’euj ch’a son restà
- lontan da tut ësgiaj
dla sempiterna rabia dij mortaj -
ant un mond ideal sensa pecà.
Beate tute le masnà,
j’angelèt celestiaj,
che ‘l batésim dël sangh a l’avran mai:
përchè a vivo ant ij seugn dj’annamorà
dont gnun Eròd alman dominerà.
Paris, Natal 1940
Da Musicalbrandè dicembre 1980
«Venus citerea»
Podèime cogé al sol aranda a ti
ant la sàbia ch’as taca a toa pel bionda
e quand che t’àusse una cheusëtta arionda
at lassa ‘d sign che gnun peul nen capì. .
Përchè mach mi sai dësgifré la ronda
dij geroglìf e ‘d j’arabèsch soasì
ch’a s-ciuplisso a la vampa dël mezdì
sla toa carn rionda e slissa come n’onda. .
Un’onda orlà ‘d paròle ‘d sàbia… Òh, glòrie
‘d nòstre Mila e una Neuit vische d’amor!
Sle toe forme, òh, le stèile ‘d mie memòrie!
La sàbia a scriv an granin d’òr ij pior
dle toe guère e ij basin dle mie vitòrie
an sël tò còrp: nu an tut ël sò splendor. .
1966
Da ‘l caval ‘d brôns agosto 1967
Càssie ‘d mòrt musicant, grande chitare
sotrà ‘nt ij simiteri messican
doa ij mòrt a fan s-ciuplì j’òss ëd le man
sle rèis dij càctus come su ‘d rosare.
Fòra, al ciairdlun-a, ‘d fust d’eufòrbie a stan
parèj ëd candlé ‘d giada solitare
tra ij bazalt ëscurpì ‘d Dé milenare
seulià da j’onde bionde-e-òr dij gran.
Ma, andrinta ai simiteri, ai seurt na testa
su da ògni tomba: e ògni mòrt l’ha un capel
a neu ‘d serpent bordà ‘d piume d’osel.
Rij, Xochipilli, ‘l cit Dé Aztech an festa,
dij mòrt cristian ch’anton-o ‘d làude al Cel.
E ’d palme a stisso ‘d làcrime d’amel.
CIUDAD DE MÈXICO, 2 novèmber 1966
Da Musicalbrandè N° 103 settembre 1984
Après lor avoir demandé s’ils était condamné à faire des vers ou à étre pendus,
il leur disait, qu’à moin que cela, ils n’en devait point faire.
Racan (Lettera XI, a Chapelain)
E adess a basta con la poesia
A dis na veja sentenza
che a quarant’ani la vita a comensa.
Comensa a vëde l’ombra d’na faussìa.
Così sia.
Da Ij faunèt 1955
Róndola
Quand che ij sarai pi nen
s’arcorzeran che j’era.
Róndola ’d primavera,
flécia ant ël cel seren,
mi sarai sot na pera,
ti ant na fior sul teren:
ma vëdroma pi nen
ni ‘l mond, ni ij sò velen…
Ànima mia, legera
róndola ‘d primavera!
Da Ij faunèt 1955
Bibliografia
Roma Andalusa – Calandri – Moretta di Cuneo – 1947
Ij faunèt – Il Delfino – Roma – 1955
Epicedion sij mè dodes gat mòrt – Casa Editrice Liguria – 1956
Rondò dle masche – L’Alcyone – Roma – 1971
Romanzìe – Centro Studi Piemontesi – Torino – 1983
RENZO BRERO (Renso dla Tor)
1905 ~ 1957
E Renzo Brero, che si libera finalmente da ogni maniera e da ogni influenza, per ritornare alla sua prima giovinezza, quando:
Mach che 'l sol luseissa an cel
che na rama ant le campagne
a buteissa un but novel,
egli correva libero
për i camp e le caussagne
sensa pene, 'l cheur content,
tra le fior ëd le campagne,
come 'n fòl, an brass al vent!
Da questa profonda, intima fonte egli trae una commossa e chiara poesia.
Pinin Pacòt, dalla prefazione a Pan ‘d coa di Nino Autelli del 1931.
La strà
La stra l’è solitaria, dura e frosa,
l’è piena d’ronze an mes le rive e i ròch…
La stra l’è longa, grama e faticosa
ch’a smòrsa l’esistensa a pòch a pòch.
Nìvole gròsse ‘nt la matin pi bela
a campo d’ombre neire an sla colina,
ël vent a sbat le feuje e jë sbardela,
j’è an aria na tempesta ch’a s’avsina…
Tut sol ant la strà sombra, con soe pene,
un pelegrin a marcia a testa bassa,
a slonga ‘l pass già strach, a l’è per svene,
e ‘l sudor ëd soa front l’è come giassa…
Ma aj canta drinta al cheur una speransa
e aj lus alegra ant ël sò sguard seren;
l’è mach pi ‘n seugn l’ùltim tesòr ch’aj vansa,
ma l’è ‘l seugn ch’a lo ‘ncanta e lo sosten.
Da A Mistral 1930
An cel j’è dë stèile…
An cel j’é dë stèile ch’a luso
ch’a gieugo ch’a rijo lassù;
la neuit l’é tranquila, as descuso
i seugn ch’an regalo le faje dë vlù.
Mi sol im cimento… Òh pudèi
pasié cost mè cheur angossà;
su ‘l let ch’a më smija ‘n rovèi
im giro, i m’arvòlto da sì e da là.
…a piora mè cheur angossà…
…dal cel silensios aj ven giù la rosà…
Da A Mistral 1930
Còsa ch’it pense?
China su tò travaj mentre ch’it cuse,
còsa ch’it pense, ò bela mia gognina,
còsa ch’it l’has, ch’it vëddo j’euj a luse
e ‘l facin anfiamesse na frisina?
Forse d’ ricòrd tròp viv as dàn da man,
forse na vos it sente an ti ch’at veul:
d’ nuvole scure a passo e van lontan,
ricòrd ch’a scianco e at bato ‘l cheur an deul?
I tò dilin a coro, as dàn da fé
tacà a na vesta bianca da sposina,
a coro e as dàn d’apres i tò pensé,
testina bela, bionda e rissolina.
Còsa chit l’has, ch’it vëddo j’euj a luse,
china su tò travaj mentre ch’it cuse?
Da A Mistral 1930
Feuje giaune
Le feuje l’han finì soa vita bela,
la vita curta d’na stagion fiorìa;
legere ‘l vent dl’otogn a jë sbardela
për la campagna straca e sparlufrìa.
Scura la seira freida a j’acarëssa
e ant la rosà dla neuit ch’aj dëscolora,
le feuje giaune a marso ant la tristëssa,
le feuje giaune, sota ‘l cel ch’a piora.
Da Armanach piemonteis 1931
Mal dël pais
Ò paisan, che mai ‘t lamente
dël travaj ëd toa campagna,
e ch’it sude e ch’it contente,
riposandte an s’na caussagna,
‘d mangé siole e sòme d’aj,
dame man, soma compagn!
Soma nà ‘nt l’istessa tèra,
l’oma bu ‘nt l’istess filagn,
rinfrëscasse a la bialera
le man rosse dël travaj.
Dame man, son torna sì,
tò compagn parèi d’anlora!
Mi son giovo, ancora ardì,
e ti vej ‘t travaje ancora
sempre an piòta, sempre al tir.
Dame man, e men-me den-a
për ij camp ëd tò travaj;
dame man, e ‘nsun-a pen-a:
ti tëm guide, e mi ‘t restai
fin ch’i l’abio fait ël gir.
Veuj arvëdde tuti ij leu
ch’a l’han vistme a randa a ti,
volté ‘l fen, dë ‘d nans ai beu,
an pastura andé për lì
longh le rive ‘d na bialera.
Peui setà su na caussagna,
mentre ‘l sol pian as ritira,
ant la pas ëd la campagna
canteroma ancor na vira
la canson ëd nostra tèra.
Da Parnas piemontèis 1943
Nostre ciòche
Nostre ciòche dla borgà
là postà an sël campanin,
son j’argin-e ‘d nòstra ca,
son j’argin-e ‘d nostra bin.
Son pa sgnore, e quand ch’a son-o
spàntio mila sentiment,
e ‘l din dan che lor anton-o
l’è ‘l din dan ëd nòstra gent,
che da ‘nt l’eira dle cassin-e
e dai camp, an sël travaj,
a na cheuj le vos pi sclin-e,
tute vos ch’a vario mai!
Bin bonora, matinere,
lor a pòrto sò bondì
con ëd vos ch’a van legere
su le ca e ‘l pian solì.
E la seira, pen-a scur,
dnans che tut s’andeurma e a tasa,
mentre ij cit, con sò cheur pur,
diso ‘l bin, e mare aj basa,
e le stèile aj fan ghërlanda,
lor a son-o n’orassion
che su an cel a raccomanda
nòstri fen e nostre amson.
Sempre alegre, sempre ardìe,
e dì ‘d festa e dì ‘d lavor,
nòstre ciòche benedìe
buto an cheur ël bonimor;
e s’aj riva ant nostra ca
na disgrassia ò na partensa,
tute ‘l ciòche dla borgà
pioro nòstra soferensa,
e ciamandne antorn a lor,
pòvre ciòche da paisan,
mës-cio ansema ai nòstri pior
sò din dan e dindalan!
Da Parnas piemontèis 1943
La vijà
La neuit a l’è bela, l’è bela la fija,
al ciair ëd lun-a, là mentre ch’a fila…
Lë spos l’è partisse da chila, ch’a vija
con j’euj ch’aj bërluso e ‘l ricòrd ch’as dësfila.
E ‘d fus n’a j’è tanti, n’à j’è ‘d gròss baron:
son tuti da èmpi ‘nt la vià doloranta.
Le lerme aj dan ande a lë sfogh dël magon,
la man as dësgagia sul fus, tërmolanta.
La neuit l’è pi ancreusa, e ‘nt ij brass ëd la fija
la roca l’è veuida… a smija una cros!
Ij fus a son pien… la rocà l’è finìa…
Lë spos a tornaralo… a tornaralo lë spos?…
Ò lun-a, ch’it luse ant ël cel pien dë stèile,
ch’it marce e ch’it vade lontan-a, lontan-a,
j’è un cheur ch’a sangiuta, ch’a gionz le parpèile
‘nt ël seugn ch’a j’anvlupa la ment ch’a davan-a…
Da Parnas piemontèis 1943
Bibliografia
Non ha pubblicato raccolte di poesie. Sue opere sono apparse in:
A Mistral Omagi di poeta piemontesi - S. E. L. P. - Torino - 1930
Parnas piemontesi - Il Verdone - Torino – 1943
‘l caval d’ brons – Giornale della Famija Turineisa - Torino
Armanach piemonteis – Ij Brandé – Turin – 1931 ~ 1938
NINO AUTELLI
1903 ~ 1945
A questi poeti della terra, viene ora ad aggiungersi Nino Autelli, poeta che non scrive versi, ma ci offre in queste sue narrazioni, una schietta poesia popolare, che come il pane del contadino, 'l pan 'd coa, ricco di glutine, ha il caldo sapore della terra.
Pinin Pacòt, dalla prefazione a Pan ‘d coa di Nino Autelli del 1931.
I tré fratei
Për fene conté le stòrie, tute le seire, dòp sina, ventava ciapé nòna për la vesta e peui, tira da sì, tira da là, fela seté a randa dël fornel. Ma chila, per lo pì, a fasìa d’ mostra ch’a trovava nen ‘l cavion dla stòria ch’a vorìa contene, për fene avnì ‘l lechèt. « Donca… con singh ass as fa na conca ». E peui, s’a vëdìa ch’a në scapava la passiensa, chila as rangiava bin sò faudal, e dasìa dontré colp ëd toss, l’istess come se ancamineissa a contî na stòria longa, longa, e ‘nvece a studiava la manera pì bela d’ mincionene.
Na vòlta j’éra un òm,
ch’andasìa giù da Pò;
l’ha trovà na pera uissa,
l’ha mangiala për sautissa.
Ma a la fin, për nen fé crussié, as butava a conté për da bon.
*
* *
Al temp che i giari a portavo le pantofole, j’éra un pare ch’a l’avìa tre fieui: un as ciamava Tomé, un Minòt, e l’autr Cichin, e a l’ero tanto an miseria, ch’a l’avìo gnanca da catesse la sal.
El pare anlora l’ha dije a Tomé, ch’a l’éra ‘l prim:
- Mi son vej e peuss pì nen andé a travajé; ti Tomé ch’it ses ël prim, preuva andé a serché fortuna.
Tomé l’ha nen dit che d’ nò, përchè l’òn ch’a dis un pare vanta scoté. Ma prima d’andé via, l’è piasse lë siass dla farina.
Gira, gira, la fortuna, as capiss, as treuva nen d’ bòta volà. Ma a fòrsa d’andé, l’è capità ant un pais, andova che le fomne, setà da para l’uss, anfilavo con n’agucia, una për una, le frise d’ bren ch’a trovavo ant la farina e a l’ero forsà d’ frustasse j’eui. Chiel l’ha ciamaje a una d’ coste dòne-sì:
- Brava dòna, còsa ch’i feve?
- L’hai da serne tuta sta farina e aj veul pròpi la passiensa di sant; pura venta sopirtela, se d’ nò, pòvra mi, se mè òmo a troveissa na frisa d’ bren ant la polenta!
- Anlora deme sì ‘l sachèt e vëdreve, - e con lë siass zichin zichèt, l’ha siassaje tuta la farina.
Tute j’autre fomne, ch’a l’avìo mai vist në siass, përchè da quand ch’a j’ero al mond a l’avìo sempre sernù ‘l bren con l’agucia, l’han tirà fòra an pressa ‘l borsòt djë scù da deje a Tomé, basta che chiel aj dessa lë siass da siassé.
E così Tomé l’è tornà a ca, content come ‘n pruss, con tuti coi borsòt ch’a sonavo, din din… din din… a tuti i pass ch’a fasìa.
Ël pare anlora a l’ha dije a Minòt: - Adess at toca a ti andé per ël mond a serché fortuna. – E Minòt, prima d’andé via, l’è piasse ‘l gat, l’ha butalo ant un sach, e via.
Va che ti va, l’ha dovù andé për brich e për val, prima d’ trové la fortuna. Ma a la fin l’è rivà ant un pais lontan lontan, che chiel l’ha cherdù ch’a fussa ‘l pais di rat.
Pròpi parèj, për tute le stra, j’era d’ rat ch’a fasìo robaté tome e tomin e ch’a possavo d’ barlèt pien d’ vin; peui na partìa d’ raton ansima dj’uss a ciapé ‘l sol e a bërlichesse i barbis, e daspërtut na rafataja d’ ratin ch’a giucavo a core e a sauté: rat da sì, rat da là.E gnun ch’a l’aveissa paura dla gent, as capiss, ma j’ero tuti fier coma d’Artaban.
Minòt l’ha ciamaje a n’òm: - Brav òm, scoteme na minuta, coma ch’a l’è che sì i rat a son pien d’ baldansa parèj?
- Lo seve nen? Chi ch’a comanda, a son lor. E j’è pa gnun ch’aj peussa dominé e noi-autri venta ch’i stago sota për fòrsa.
- Anvece – l’ha dit Minòt – aj veul pa tant a feje bassé ‘l cachèt. Veule vëdde ? – E sensa gnanca speté la rispòsta, l’ha dësgropà ‘l sach e ‘l gat l’è sautà fòra parèj d’un balon.
Maginé ‘n poch che batibeuj !
Pena spantiasse la neuva, tuti i rat, ciuto ciuto, - è-lo da sì ch’as passa? – l’han piantà lì baraca e buratin.
Così ‘l pais l’è restà, d’ bòt an blan, bele liberà da la prepotensa d’ coi rat, e a Minòt l’han daje na sòma carià d’òr e d’argent.
Minòt l’è stait ancora pi fortunà che Tomé.
Anlora, l’ùltim, ch’as ciamava Cichin, l’ha dije a sò pare:
- Pare, veuj andé d’ cò mì a serché fortuna.
- Ti nò Cichin, përchè it ses ancora tròp giovo pë andé da sol për ël mond - Ma chiel daje, bat e martela, fintant che sò pare l’ha dije che d’ sì për contentelo.
E chiel l’è partì, alégher come ‘n rè, con un bel galucio sota ‘l brass.
Camina, camina, ma a trovava mai gnente ch’aj porteissa fortuna.
- Epura – a disìa daspërchiel – s’a l’han fai fortuna Tomé e Minòt, a fòrsa d’andé i veuj fela d’ cò mi, e fin ch’i l’abia nen trovala, vad nen a ca. – E l’è rivà ant un pais, andava ch’a l’era sempre neuit, përchè ‘l sol a nassìa mai, e bele là le lanterne a l’ero sempre avische.
Chissà lòn ch’avrìa pagà cola gent, për ch’aj nasseissa d’cò lì ‘l sol, come an tuti j’autri leu!
- Veule vëdde – l’ha dit Cichin – che mi son bon a fé nasse ‘l sol?
La gent l’ha pialo për mat, e lo piava an gir.
Ma tut ant un moment ël galèt d’ Cichin l’ha sventajà trè vòlte j’ale, l’ha slongà ‘l còl e l’ha mandà un chicchirichì di pì long e pì aut.
Al prim chicchirichì a son smortasse le stèile e ecco an fond al cel, come ‘n lusor spali, spali. Tuta la gent a guardava an aut bele ‘mbajà, sensa fiatì.
A lë scond chicchirichì ‘l cel l’è dventà pì ross che na fiama.
Al ters chicchirichì l’è surtije fòra ‘l sol ch’a l’ha spatarà soa lus an tuti i canton.
La gent a s’ambrassava e a sautava da la gòi e antratant ël sol na vòlta pì bel e splendent, a montava su adasi adasi an mes al cel.
E a Cichin?
A Cichin l’han daje un chèr, neuv neuvent, tirà da na cobia d’ cavai, bardà da bin con i fiòch e le ciochinere, pien d’ tute sòrt di pì bei regai. E chiel l’è partì tut content, an sciopatand ël foet : cich e cich ciòch, cic e cich ciòch!
Da Armanach piemonteis 1931
Tòni toblan
Doi fratei, mòrtje ‘l pare e la mare, a son restà sòi. Un ‘d costi doi, ch’a lo ciamavo Tòni toblan, përchè ch’a l’era toch ant le gambe, a na fasìa mai una da bin. Un dì, sò fratel ch’a l’avìa pì giudissi, a l’ha dije: - Guarda, mi vad a travajé, e ti ‘ntant prepara ‘l feuj për fé le lasagne.
Chiel-sì l’ha bagnà doe pugnà d’ farina d’ gran e a l’è butasse a baciassé. Ma sicoma la pasta l’era restà pitòst mòla, l’ha dit: - It chërde, eva, chi l’abia pì d’ farina? – e n’ha giontane dl’autra. Però a l’ha butane così fòra d’ misura, che la pasta l’è dventà tanto gnëcca ch’as pudìa pì nen ampasté.
- It chërde, ò farina, ch’i l’abia pì nen d’eva? – l’ha dit; e l’ha torna butaje d’eva, andova che la pasta l’è dventà moto ben pì mòla d’ prima.
A la fin di cont l’è scapaje la passiensa e l’ha versà tuta l’eva ch’a j’era ant la sija e tuta la farina ch’a j’era ancora ‘nt ël sach e così gionta eva, gionta farina, l’è andaje tuta la scorta dl’anada.
Rivand a cà sò fratel, a la dije: - Sì ch’it l’has fala oita, me car! Adess, andova ch’i andoma a mangé? Ma, sciao; ven con mi ch’i andoma a serché fortuna.
E così, zichin zichèt a son butasse an camin. Longh la stra Tòni toblan l’è vnuje an ment a l’improvis ch’a l’era dësmentiasse d’ saré la pòrta dla cà.
- Eben - l’ha dije sò fratel – basta mach ch’it fasse an pressa a torné ‘ndaré, bada ben; it tire d’apress l’uss dla cà e mi të speto bele sì. -
E Tòni toblan andviné ‘n pò’ lòn ch’a l’ha fait? L’è tornà ‘ndaré e da lì nen tant l’è rivà bele là con l’uss dla cà a spala.
Ma tutun, sicome a l’avìo pressa, l’han seguità la stra per nen perde temp.
Va che ti va, l’è fasse scur e son trovasse an mes d’un bòsch, fros fros, andova ch’a j’era nen na cà, e lor, per stè pì tranquìi, l’han pensà parèj d’andé a deurme ‘nsima na pianta; ma per buté gnun sospet a gnun, l’han tirà su d’ cò l’uss.
Ant la neuit, l’è fermasse là sota na banda d’ brigant. Costi-sì l’han ben mangià, ben beivù; dòp l’han tacà a dëscore d’ còse ch’a fasìo drissé i cavej e a son butasse a conté i sòld ch’a l’avìo robà.
- Doi a mi, doi a ti, doi a mi…
E coi ch’a j’ero ‘nsima la pianta? Quac, quac! Fina a tant però che Tòni toblan l’è butasse a dì:
- Òmmi, òmmi che l’uss a va per tera!
- Tenlo, Tòni, tenlo pì ch’it peule!
- Doi a mi, doi a ti, doi a mi, doi a ti…
- Òmmi, òmmi che l’uss peuss pì nen tnilo!
- Tenlo, Tòni, tenlo ‘ncora ‘n pòch!
- Doi a mi, doi a ti, doi a mi, doi a ti…
- Ciaplo ch’a va… a va… a va… l’è ‘ndait! – e l’uss l’è robatà fasend un rabadan dla malora.
I brigant l’han chërdù che Nosgnor a voreissa feje paghé stavòlta tute le malfaite e son scapà che ‘l diavo aj portava. I doi fratei l’han spetà ’ncora un pòch ‘nsima a la pianta, e peui dòp, vist ch’a j’era pà ànima an tut ‘l bòsch, son calà giù e l’han trovà ai pé dla pianta un baron d’ monede d’òr, ch’a s’arzigavo squasi gnanca d’ tocheje.
Ma Tòni toblan, ch’a l’era stait bon a fé scapé i brigant, l’è butasse a dritura a cheuje, përchè, con ben ch’a fussa ‘n falabrach, le giaunëtte l’ha sùbit conossuje ant un moment.
L’autr peui l’è butasse a fé l’istess e così l’han empì tute le sacòcie, i capei e le bisache e son tornà a cà, che la fortuna a l’avìo già trovala sensa andé pì lontan.
Da Armanach piemonteis 1931
Cabanòt
Al temp dl’uva madura, una dle gòi pi bele, per nojautre maraje dla cassina, l’era costa-sì d’andé ant la vigna a fé la guardia ansima al cabanòt e da là ‘d sora peui feje la cabra a coi ch’a passavo longh la stra.
O cola bela fija-a-a,
i crijavo auta ganassa.
Ch’im ròbe tuta l’uva malvasia-a-a!
O còla dòna dla cavagna-a-a,
ch’im ròbe tuta l’uva dla taragna-a-a!
e i sonavo tuti a gran fòrssa ansima a na massa da slòira.
D’ant la valada e d’an s’i brich d’antorn, dle vòlte, a tacavo a rësponde, a tut andé, ‘d cò j’autri cabanòt e anlora, peule capì, traverss a la colina, che rassa ‘d batajera.
Forssa ‘d crijé parèj tuta la matin, con l’uva ch’a në sgurava da ‘n drinta e ch’an fasìa beuje ‘l panssòt parèj ëd botalin, aj sonava mesdì ch’i l’avìo na fam da luv. E aj rivava quaidun dla cassina a portene da mangé: na tupina dë mnestra – squasi sempre tajarin e faseui – e na bela ghërssa ‘d pan neir.
Is butavo dlonch a setesse per tèra e peui i mangiavo bele parèj ant la tupina, con nòstri cuciar dë stagn.
L’odor ëd cola mnestra paisana as mës’ciava antant anssema a l’odor dle vis e dla tèra brusà dal sol.
* * *
Na vita d’òr ch’a l’era cola-là!
Nòst cabanòt, postà ansima na nosera, a në smijava un ni; e nojautri tal e qual i l’ero coma j’osei ch’a bësbijavo daspertut trames al verd dle vis e ant ël fujagi di bòsch.
Sempre an camin a raviolesse per tèra, bei e dëscauss, a scoraté su e giù per cole rampe. L’aria del brich e ‘l sol an fasìo dventé neir coma i vasass.
Quand che peui i l’ero bei e strach, e che la sèi an sëcava la gola, l’avìo mach da setesse a l’ombra ‘d na taragna e picotesse na bela rapa moscatela color dl’òr e dossa coma l’amel.
* * *
Dòp davèi mangià d’uva tut ël dì, squasi ch’a në vnisìa fina a stracheur, tant ch’i ciuciavo mach pi j’asinei e la barëtta i podìo pi nen travondla.
A bastava però ch’aj passeissa la neuit, ch’an tornava sùbit l’anvìa come prima.
E la prima rapa ch’i cujìo a la matin, frësca ‘d rosà, a l’avìa tut sò gust pien ëd fragranssa.
* * *
An sl’ambrunì, pena ch’aj rivava Vigin, con sò dobièt an spala, a fe la guardia ‘d neuit, nojautri is na tornavo a la cassina. Però na vòlta, per contentene, l’han lassane deurme ‘d cò noi ansima la paja dël cabanòt.
Pena sota ‘l sol, l’ha tacà alvesse n’ariëtta frësca e frissanta e ant un gnente l’è fasse scur. L’ombra a l’ha ampinì tuta la valada e i brich d’antorn a son dventà ‘d mace neire, pena pontinà da quaich ciairin lontan. I brombo dle vis, davsin al cabanòt, bogià da col’ariëtta, a fasìo d’ombre dròle e d’armor da fene arssauté tuti i moment.
Fait a l’è ch’i soma restà bei e sesì da la paura. Soma strensusse adòss a Vigin e i l’oma dije:
- Neh, ch’it ij masse i làder, s’a veno sì?
- Cribbio, ch’ij masso!
* * *
Na vòlta - Vigin a l’ha contane - im trovava ansima al cabanòt ch’a l’era dì. D’bòt an blan i sento frojé ant le cane dla bussonà e i vëddo doi ferlingòt ch’a l’ero intrà ant la vigna e ch’a s’avsinavo quac quac a na taragna.
Mi sùbit l’hai fait gnente. L’hai spetà ch’a s’avsineisso ‘d pi e pena ch’a l’han slongà le man ansima a le rape – patatrach – l’hai sparà doi colp ant l’aria, un daré dl’autr, ch’a l’han fait arbombé tuta la colina.
Si l’aveisse vëduje pié ‘l plòt! Andasìo che i garèt aj tocavo la schina !
Rivà ant la giravòlta dla stra, da l’autra banda dla vigna, l’han alarmà un pòch ël pass, e i l’hai sentuje dì parèj:
- L’ha-lo massate?
- Mi nò, e ti?
- Mi gnanca.
* * *
Antramentre l’era aussasse la luna.
La neuit l’era fasse ciaira squasi coma ‘l dì, e a pudìo fina s’ciairesse, su per la còsta dla colina, le cassinòte bianche anssugnochìe an mes a le vis.
Ant un bòt a l’è passane la paura, e an cambi i soma lassasse ancanté da la neuit.
Traverss a cole vigne as sentìa franch gnente, fòra che le rane d’an fond a jë rian, ch’a cantavo a tut andé, e i grij ëd cò – gris, gris, gris – ch’a cantavo daspertut, senssa fin, per che l’uva a madureissa.
E l’aria l’era così piena ‘d cost arciam di grij, ch’a në smijava dabon che tut ël mond a canteissa parèj, sota ler stèile, ch’a bërlusìo a milion.
Da Armanach piemonteis 1933
Bibliografia
Pan d’ coa Leggende e racconti popolari piemontesi – S. E. L. P. – Torino – 1931 (Ristampa Viglongo – Torino – 1985)
Masnà – A l’ansegna di Brandé – Torino – 1937 ( Ristampa Ca dë Studi “Pinin Pacòt” Colan-a «Ël mej dij mej» N° 1 – Torino – 1985 ~ Ca dë Studi “Pinin Pacòt” Colan-a «Ël mej dij mej» N° 9 – Turin – 1994 )
L’Araldo del Piemonte e Valle d’Aosta Anno II N° 5 Primo trimestre 2015
LUIGI ARMANDO OLIVERO
2 novembre 1909 - 31 luglio 1996
Il 2 novembre 1909, nasce in Villastellone (TO) Luigi Armando Olivero.Terminata la frequenza delle Scuole Tecniche a Torino, Olivero inizia giovanissimo a scrivere poesie. Le prime in lingua, come dirà lui stesso carduccianeggiando, rapisardeggiando, dannunzianeggiando. Queste appaiono a stampa già dal 1926 sulla rivista letteraria orobica Il pensiero, sulla milanese Giovinezza d’Italia – Pagine quindicinali di letteratura ed arte, su La farfalla dell'editore Nerbini di Firenze. Quindi sulla torinese rivista teatrale dell’Opera Nazionale Dopolavoro Rassegna filodrammatica. Sempre del 1926 è il suo primo articolo letterario sulla già citata rivista bergamasca Mario Rapisardi, un poeta dimenticato.
Diciottenne inizia a viaggiare per il mondo e ad intessere conoscenze le più svariate. Quattro continenti. Diciotto nazioni. I suoi primi scritti sono pezzi di colore dalla Tunisia, dall’Algeria, dal Sahara per La Stampa, Stampa sera, La gazzetta del popolo. Nella sua lunga vita arriverà a collaborare con più di 200 testate italiane e straniere.
Giunge alla poesia dialettale verso la fine degli anni venti grazie all’amicizia con il poeta Alfredo Nicola (Alfredino) che lo presenterà poi a Giuseppe Pacotto (Pinin Pacòt) che con altri amici poeti stava dando vita alla Compania dij Brandé con lo scopo di ravvivare, riaccendere, rivitalizzare la poesia piemontese che si riteneva allora sul punto di spegnersi se non già del tutto spenta.
Comporrà nel dialetto piemontese oltre 1000 poesie e non solamente sonetti di 14 versi, ma componimenti che spesso superano, e ampiamente, i 100 versi. Sperimenterà ogni possibile forma metrica anche con lunghi componimenti in monostici, splendide poesie queste ultime con ogni singolo verso compiuto terminante con il punto, i cui versi possono tranquillamente essere intercambiati. Il suo canto abbraccerà quasi ogni campo dello scibile umano e la sua poesia sarà universale: dall’aereopoesia futurista de L’aeropoema dell’elica piemontèisa, alla poesia dell’eros, a quella religiosa per giungere persino a poetare su discipline dello sport.
Infiniti sono i temi che ha poi trattato nei suoi scritti, sia in piemontese che in lingua: letteratura, pittura, scultura, musica nelle sue più variegate accezioni. Ho rintracciato suoi articoli sullo sport, sull’arte dei pupi siciliani, sugli UFO, sui capelloni…
Nel 1941 esce per i tipi dell’editore Ceschina di Milano Babilonia stellata, un saggio sulla gioventù americana d’anteguerra. In particolare sui suoi vizi e difetti. Ebbe in breve tempo tre edizioni. In una quarta del giugno 1943 aggiunge numerosi capitoli di feroce denuncia in particolare della politica economica americana. A questi capitoli collaborò attivamente con suggerimenti e lettere il più grande dei poeti americani e caro amico di Olivero, Ezra Pound. Babilonia stellata fu anche edita in tedesco ed in altre lingue.
Nel 1945, per i tipi dell’Editore romano Donatello De Luigi, frutto di una lunga permanenza in loco, esce Turchia senza harem che ancora oggi è un ottimo libro sulla storia, usi e costumi di un paese che Kemal Ataturk stava portando verso la modernità. Anche questo saggio ebbe traduzione in inglese ed altre lingue.
Del 1946 è il suo unico romanzo Adamo ed Eva in America alla vigilia del secondo diluvio universale. Ai tempi dell’edizione inglese in Italia aveva già tirato più di 650.000 copie. L’edizione tedesca viene stampata a puntate a Düsseldorf sul settimanale Herz Dame.
Dedicherà poi brevi saggi a Giovanni Papini, a Carlo Maria Franzero, a Clemente Fusero e Gabriele d’Annunzio. Curerà per l’Editore Viglongo di Torino la raccolta delle poesie di Padre Ignazio Isler trascrivendole pazientemente dalle edizioni settecentesche.
Le sue poesie in piemontese, oltre che essere sparse in decine di pubblicazioni periodiche, sono raccolte in quattro volumi.
Roma andalusa nasce presso l’Editore Calandra di Moretta (CN) nel 1947; contiene tredici poesie tutte dedicate alla Città eterna. È introdotta da una lettera di Gabriellino d’Annunzio, figlio secondogenito dell’Ariel nazionale e contiene splendide incisioni di Giuseppe Macrì. (Olivero curerà sempre in modo particolare la veste tipografica e la perfetta simbiosi tra parola ed immagine nelle sue opere valendosi di grandi artisti)
Del 1955 sono Ij faunèt dell’Editore Il Delfino di Roma. 69 poesie precedute da una prefazione di Alex Alexis (pseudonimo di Luigi Alessio da Caramagna Piemonte, scrittore, poeta, drammaturgo, giornalista, biografo, primo traduttore italiano dell’opera di Celine oggi praticamente sconosciuto ai più, ma che rivalutazione meriterebbe) e con le poesie tradotte in italiano da Clemente Fusero il noto biografo anch’egli da Caramagna Piemonte ed in francese dal poeta corso Anton Francesco Filippini e dalla scrittrice belga Simone Blavier. Bellissima veste grafica ed iconografia di Giuseppe Macrì, Orfeo Tamburi, Gabriele Cena, Giovanni Consolazione e Gregorio Prieto.
1971: la sua opera forse più importante Rondò dle masche. 39 poesie con traduzione in italiano dello stesso autore. Prefazione intervista a cura del poeta, scrittore e giornalista romano Icilio Petrone. Incisioni di John Castberg, Eugen Dragutescu, José Escassi, Giuseppe Macrì, Orfeo Tamburi, Henri Matisse, Gregorio Prieto.
Nel 1983 esce un’antologia di sue poesie con la prefazione di Giovanni Tesio per i tipi della Ca dë Studi Piemontèis di Torino: Romanzìe. Una trentina di poesie ma soprattutto alcune versioni in piemontese da opere di autori di ogni tempo e di ogni nazione. Olivero disse di compiere con la traduzione una sorta di transfert liberandosi così dal pericolo di incorrere in più o meno evidenti plagi. Una delle sue traduzioni più memorabili è quella del Cantico dei cantici da Salomone ma non meno meritorie altre ad esempio da Catullo, da Saffo.
Per la presentazione di Romanzìe lo va ad intervistare a Roma la Dott. Albina Malerba, oggi direttrice della citata Ca dë Studi Piemontèis. La lunga intervista è pubblicata sulla rivista torinese, organo della Famija Turinèisa, ‘l caval ‘d brôns N° 5 e N° 12 del 1983. Albina Malerba se ne viene via dalla villetta di Olivero, ai piedi del Pincio, quando il sole è già calato dietro il cupolone; scendendo per via del Babbuino con negli occhi e nel cuore le parole di Olivero e le immagini della sua casa, traboccante di preziose opere d’arte degli artisti che gli furono amici e collaboratori, la poetessa porta con se una certezza:
Gli angeli saranno generosi con un poeta della tempra e della forza di questo piemontese di Roma.
Le sensazioni ed i sentimenti di Albina Malerba sono gli stessi che ho provato, e che mi permetto di condividere pienamente, il 25 di maggio del 1996 dopo aver trascorso l’intera giornata con Luigi Olivero nella sua casa romana di Vicolo del Borghetto mentre, attraversando Via Margutta e Piazza di Spagna, me ne tornavo verso Termini e la metropolitana che mi avrebbe condotto a Fiumicino e da lì a Torino. Mi permetto questa piccola modifica, alle parole di Albina:
Gli angeli sono stati generosi a farci dono di un poeta della tempra e della forza di questo piemontese.
Olivero compone poesie fino a tarda età. Ancora sul finire del 1989 (a 80 anni) compone, di ben 133 versi, la Cantada del balon mondial dedicata al Campionato Mondiale di Calcio Italia 1990!
Durante la sua lunga vita Olivero ha conosciuto molti dei personaggi più importanti della sua epoca e con tanti ha stretto amicizia. Ricordarli tutti sarebbe una vera impresa. Mi limito ad alcuni. Il poeta e scrittore americano Ezra Pound, il poeta spagnolo Federico Garcia Lorca, e poi Sibilla Aleramo, Benedetto Croce, Francesco Flora, Trilussa, Jean Cocteau, André Malraux, Filippo Tommaso Marinetti, Angelo Nizza, Orfeo Tamburi, Henri Matisse, Giovanni Cena, Gabriele Consolazione…e naturalmente i poeti e scrittori piemontesi Nino Costa, Giuseppe Pacotto, Alfredo Nicola, Oreste Gallina, Armando Mottura, Nino Autelli…
Luigi Armando Olivero muore il 31 luglio del 1996 nella sua casa romana solo e dimenticato quasi da tutti. Solo pochi amici lo ricorderanno: Camillo Brero sul suo Piemontèis ancheuj, Franca Spagarino e Giovanna Viglongo sull’Almanacco fondato dal marito e padre Andrea Viglongo e Beppe Burzio sulla sua Assion piemontèisa. Da quest’ultima rivista riporto la poesia che il poeta e caro amico Giovanni Magnani ha dedicato ad Olivero. (Burzio e Magnani entrambi deceduti in anni recenti.)
It j’ere nen sol quand’an sël frèid dla pera
Tò cheur a gëmmia pian l’ultim frisson:
dobià e an pior ant l’ultima preghiera,
j’amis pì s-cet a ciosioné ‘n perdon.
Përdon për coj omnèt che ‘nt la mnisera
dle fausserìe, dl’angann ë dël ghignon,
a l’han sercà ‘d sotré Toa vos sincera
che an tut ël mond a l’ha otnù ‘l blason.
Nò. It l’has mai avù n’ombra ‘d boneur,
nen n’agiut o ‘l consens për Tò travaj
dai borenfi savant ëd nòstr Piemont
e se cheivira a l’è vnù dur Tò cheur
ant le bataje ‘n sij libèr e ij giornaj,
adess la Glòria at baserà la front.
In conclusione due poesie di Olivero entrambe manoscritte autografe che provengono dal Fondo Olivero presso l’AssOlivero di Villastellone, Associazione quest’ultima nata con lo scopo di valorizzare l’opera del suo grande concittadino. La grafia è quella originale di Luigi Olivero senza modifica alcuna. Entrambe le poesie risalgono all’incirca alla metà degli anni ’30. Ad oggi sono state pubblicate solamente nell'ottobre del 2009 dalla rivista Gioventura piemontèisa.
Ël giarighin
Ti ìt ses un giarighin
candi, inossent
che t’amgrumlisse davsin
a me cheur
e ‘t tramole ‘d sentiment.
Mi l’hai fate una nicia con mia bin,
l’hai ambotila ‘d gòi për tò boneur
e i rijo
e i son content
s’i scoto ch’a dësgrun- i tò dentin
le mandòle salà di me basin.
E quand ch’it raspe j’onge
reusa
e it l’has paura
përchè na pen-a ancreusa
smìa ch’at tortura;
ò giarighin d’ mia vita e d’ me boneur,
mi sento un grop an gola e un tonf al cheur.
Ant la conca ‘d mie man,
për consolete
ël tò facin uman
preuvo a cunette
e am ven ant j’eui n’azur ëd paradis
se tò museto a fa bogé ‘n soris;
e i rijo torna dël mè rije s-clin
se i tò dentin
arpijo a dësgruné
- crocand, sensa pensé -
le mandòle salà di me basin.
Ò cit ferfoi ëd carn, ò maravia
viva d’amor,
che con i tò sospir ëd gelosia
e lë vlu ‘d tò calor
t’has ansopì ‘l dolor
dl’anima mia;
it porterai con mi
për tuta grama strà dla vita mia:
e it lasserai mai pì
né neuit né dì
fin che ‘nt ël mond ai sia
una carëssa e un sofe ‘d poesia.
…Perché
ti ‘t ses un giarighin
candi, inossent,
che t’amgrumlisse davsin
a me cheur
e të më scaudi i seugn dël sentiment.
Oh fé’l dësdeuit su na bochin-a bela…
ch’at fa na gòi… (l’è un rapolin ‘d cerese!)
e pura tant sovens at fa ‘l disperse
‘d neglesse, con n’arietta barivela!
‘Mbrancheje a l’improvis la soa facin-a,
dësverseila andaré ‘n mes ai tò brass.
Tenla reide a la vita, s-ciass ë-s-ciass,
anche s’a sfeudra j’onge – la gatin-a!
Sente, sota i tò làver, coi dentin
ch’a s-cianco, ch’a rifuso ‘l tò basin…
E un cheur! Un cheur ch’a bat precipitos
come ‘d na rondolin-a spaventà:
ël cheur – an fin di cont – dla toa morfela.
Oh fé’l dësdeuit su na bochin-a bela…
(Altro titolo dato da Olivero alla poesia: Vigliacucio)
Come scrittore ce lo presenta Pinin Pacòt in una lettera indirizzata a Luigi Olivero il 29 luglio del 1930: I l’hai trovà n’apassionà d’ nòst folclòr, ch’a l’ha cujì e ch’a l’ha contà ant na manera delissiosa le stòrie, le faule, le legende d’soa region alessandrina, ant un bel piemonteis pien ëd saiva e pien ëd calor. Questi racconti, favole e leggende saranno il corpo di Pan ëd coa pubblicato nel 1931 dalle Edizioni S.E.L.P. (Studio Editoriale Librario Piemontese di Andrea Viglongo). Appena il tempo di dare alle stampe il suo Masnà nel 1937 che parte volontario per l’Africa e la campagna d’Etiopia.
Olivero aveva dedicato a Nino Autelli un articolo sull’Armanach piemontèis del 1937 dove tra l’altro scrive:
…Per un ghiribiss dla natura, lë scritor Nino Autelli – l’ùnich autentich scritor piemonteis d’ancheuj – a ‘s presenta al mond con un cheur a double face. Da na part a l’é un cheur còti e vlutà coma ‘l pontaguce d’una fiëtta da marié: e cola a l’é la part ëd l’artista sensibilissim ëd MASNÀ. Da l’autra part a l’é un cheur dru e sislà ‘d corage coma na medaja al valor militar. A l’é che Nino Autelli a l’ha vorsù esse volontare an A. O. e an cost moment a ‘s treuva ancora an tèra d’Africa a protege i sorch signà dal destin imperial dla nòstra rassa paisan-a e gueriera. …
Dicembre 1948, dopo una lunga sosta durata due anni, Olivero pubblica l’ultimo numero doppio, 31/32, della sua rivista Ël Tòr. Un accorato articolo è dedicato alla memoria di Nino Autelli, barbaramente ucciso a Spinetta Marengo il 18 maggio 1945 avanti la figlioletta Paola di quattro anni, la moglie Maria e l’adorata Mamma. Giovani con foulard e berretti rossi gli sparano una raffica di mitra alle ore 1.15. Muore, confortato dai famigliari, da un sacerdote e da un medico, alle 4.15. Assassinio mai punito, in nome di una giustizia sommaria e di un popolo lacerato da una guerra perduta. Olivero ci dà il primo, e a quella data, unico, vivido ricordo dell’autore di Pan d’coa e di Masnà. Ecco alcuni brani del commosso ricordo di Olivero per il suo amico Nino Autelli:
L’ultimo suo anélito fu un pensiero soffuso della luce purissima del perdóno per i giovani sconosciuti che ostentavano berretti e foulards rossi e i quali, alle ore 1 di quella stessa notte, eran balzati giù da un’automobile che s’era improvvisamente arrestata di fronte a casa sua, avevano fatto irruzione, con i mitra spianati, nella sua stanza da letto, e, insensibili alle grida d’angoscia e di terrore della sua creaturina e delle sue donne, gli avevano intimato di uscire nella contrada, nera di silenzio, dove, proprio sulla soglia della sua abitazione, gli avevano sparato addosso una sventagliata di proiettili, lasciandolo disteso in un lago di sangue (ore 1.15). In un quarto d’ora avevano strozzato per sempre la più alta voce della prosa fiabesca in piemontese di tutti i tempi.
…Povero Nino! Hanno voluto ravvisare in lui nient’altro che un uomo d’un colore politico cancellato dalla spugna infocata degli avvenimenti bellici. Hanno voluto scorgere, sotto la sua bella fronte, un’idea politica ormai bruciata dalle fòlgori della tempesta: un’idea nella quale egli aveva creduto fino all’ultimo istante, con tutta la sincera onestà della sua anima limpida, perché in quell’idea – giusta o sbagliata che fosse – per lui s’identificavano la legalità, l’onore, la difesa della Patria. …la malvagità umana è grande, ma la vigliaccheria è immensa. Nino Autelli ebbe tanti amici, da vivo, che lodarono le sue virtù etiche ed artistiche. Post mortem, su di lui, sulla sua opera letteraria, non si è più udita né letta una parola.
Quanta tristezza! Se certa malintesa politica può pervenire a tanta accanita violenza demolitrice da eliminare persino il sentimento spontaneo e congenito del ricordo d’un compagno estinto, da parte degli amici della propria giovinezza, quanto ribrezzo, anche nelle marmoree statue cimiteriali, può suscitare talvolta la politica! Tuttavia noi sentiamo di poter superare, in tutta calma spirituale, anche la paura della politica degenere e degli uomini che se ne fanno strumento di offesa per legittimare i loro crimini. E offriamo serenamente questo omaggio a Nino Autelli: l’unico che gli sia stato pubblicamente tributato dalla data della sua morte (18 maggio 1945) ad oggi (15 novembre 1948), alla sua santa memoria, alla sua anima pura, coraggiosa e delicata, che sentiamo sorella della nostra e viva: più viva che mai, in noi, situati ancora al di qua del regno delle ombre livide della Morte nel cui grembo il suo corpo ha trovato finalmente la pace. La pace eterna dopo un’esistenza inquieta, come la nostra, figlia onesta dell’avventura e dell’azzardo, genitori di virilità e di energetica poesia. …
Nino Autelli fu un eroe disarmato (stavo per scrivere armato del gambo di un giglio):
Fu un còndor con occhi e cuore di colomba.
Come Federico Garcìa Lorca. (1)
Come Robert Brasillach. (2)
Così fu Nino Autelli.
E tale amo supporre che rimanga per la posterità, quest’ormai leggendario mio inobliabile amico.
La descrizione della fine di Nino Autelli, praticamente identica a quella fornita da Olivero, si trova anche nel saggio di Giampaolo Pansa Sconosciuto 1945, Sperling & Kupfer Milano 2005. Nella parte quarta del volume, un intero capitolo La fiaba di Nino è dedicato a Nino Autelli e al ricordo del suo assassinio raccontato dalla di lui figlia Paola. È citato pure il giudizio di Luigi Olivero su Masnà di Autelli: la più alta voce della prosa fiabesca in piemontese di tutti i tempi.
Da Sconosciuto 1945 estraggo alcuni brani del ricordo del padre da parte della figlia Paola.
Una cartolina spedita da Verona da Nino alla figlia il 16 aprile 1942: «Mia cara Paola, nel mio continuo andare per le strade del mondo, sei tu il mio pensiero più bello e la mia gioia più pura. Tuo babbo».
Il racconto di Paola:
Dopo la maturità, nel novembre del 1922, a 19 anni, si è iscritto alla facoltà di Medicina, all’Università di Torino. Poi si è accorto che il sangue gli faceva impressione e ha deciso di abbandonare. Ha preso il diploma magistrale e ha cominciato a insegnare come maestro elementare.
Ha fatto il servizio militare da soldato semplice. Nel marzo 1936 è andato volontario in Africa Orientale, come soldato della Sussistenza, il servizio che distribuiva i viveri ai militari. Aveva 33 anni e non era ancora sposato. È rimasto in Africa sino al gennaio 1937. Alla guerra di Spagna no, per quella non è partito.
Papà e mamma si sono sposati nel novembre del 1940, qui a Spinetta. E pochi mesi dopo, lui è stato richiamato alle armi. Dal momento che aveva frequentato Medicina, l’hanno messo nella Sanità, ancora da soldato semplice. Faceva la spola tra il fronte russo e l’Italia, sui treni ospedale che riportavano in Patria i nostri militari feriti.
Quando sono nata io, il 4 ottobre 1941, lui era a Kolozsvar, in Transilvania, una tappa di quei convogli. Scriveva alla mamma: «Sono stato assegnato alla vettura dei feriti gravi, tutti barellati. Sono contento di questo incarico perché avrò modo di essere più vicino a coloro che hanno vissuto la guerra e di esercitare verso di essi tutta la mia umana simpatia e il mio spirito di carità». Dopo due anni di servizio duro sui treni ospedale, papà si è ammalato ed è stato messo in congedo.
Quando è nata la Repubblica sociale, lui si è iscritto al Partito fascista repubblicano. Anche qui non ha avuto cariche, mansioni speciali, gradi. Poi nel luglio 1944, il segretario del Pfr, Alessandro Pavolini, ha deciso di militarizzare il partito: tutti gli iscritti maschi, dai 18 ai 60 anni, dovevano arruolarsi in una formazione militare, le Brigate nere. In questo modo, anche papà ha vestito di nuovo la divisa. Da semplice milite della Brigata nera «Attilio Prato», senza partecipare a rastrellamenti o a operazioni contro i partigiani. Frequentava la sede della federazione, ad Alessandria. Penso che facesse lo scritturale, addetto a qualche ufficio. E nient’altro. Il 25 aprile la mamma è andata a prenderlo in bicicletta, portandogli un abito civile. Papà è ritornato a casa, in questa villetta. Non ha mai pensato di scappare. Stava qui, allora il cortile era aperto, non esisteva la recinzione che lei avrà notato (Paola racconta a Giampaolo Pansa n.d.r.). Lavorava nel giardino, si faceva vedere.
Giampaolo Pansa conclude così il capitolo La fiaba di Nino:
Nel sessantesimo anniversario (dell'assassinio di Autelli, il libro di Pansa esce nel 2005) la figlia ricorda quel padre grande e buono che Dio le ha dato e gli uomini le hanno tolto.
Ho aggiunto questi ricordi di Nino da parte della figlia Paola in quanto permettono di meglio comprendere la figura, l'umanità. la coerenza di questo, permettetemelo, grande piemontese che, a distanza di 70 anni dal suo vile assassinio, meriterebbe di essere maggiormente conosciuto in particolare dalle nuove generazioni.
******
Eccomi ora all'opera, troppo breve, purtroppo, stante gli eventi, di Nino Autelli autor ëd coi doi diamant leterare, batesà Pan d' coa (4) e Masnà (5), ch'as romperan mai con ël passé dël temp përché a son doe ciadeuvre faite pi con ëd sangh lìrich cristalisà che nen con d'inciòstr e pi ancastrà 'nt la pera che nen tramandà 'n sël papé.
Pinin Pacòt ha scoperto Nino Autelli, chi meglio di lui per un'escursus sui racconti, sulle favole di Pan 'd coa? Alcuni brani dalla prefazione Nino Autelli e la giovane poesia piemontese:
Nino Autelli non ha fatto opera di scienza, ha fatto di meglio; si è piegato con fraterna simpatia sul cuore del popolo, ne ha ascoltato la voce, ne ha raccolto gli sparsi frammenti di poesia e questa ha rivissuto in se stesso ed ha espresso come poesia sua.
Queste fiabe, queste leggende, questi proverbi, che egli ci narra richiamano alla nostra coscienza di razza intimidita dalla snobistica superficialità del cosmopolitismo stracittadino, tutto un passato, ormai quasi scomparso, che di questa secolare poesia s'infiorava.
Lunghe veglie invernali ormai così lontane nel tempo, trascorse in una vaga atmosfera di fiaba e di leggenda, chi potrà descriverci senza ricorrere ad una stantia rettorica del sentimento?
Di tutto un mondo fantastico, che allietò, commosse, nutrì l'anima di generazioni susseguentisi immutate nello spirito, non restano più che poche reliquie affidate alla tenace memoria di qualche vecchio.
Questo libro è formato di questi frammenti del passato, che Nino Autelli ha raccolto nelle campagne dell'Alessandrino e del Monferrato, pellegrinando modernamente in bicicletta da paese a paese, in cerca dei pochi vecchi, inconsci custodi delle belle tradizioni, in grado di narrargli le storie d'una volta.
Non è certo possibile valutare, ora al suo apparire, l'importanza di questo libriccino; è però reale la sorpresa gradita e nuova che esso produce.
Nino Costa per due volte, sugli Armanach piemontèis, si occupa di Pan 'd coa. In quello del 1933:
La pròsa piemontèisa, dop i bossèt del tròp dësmentià Giovanin Casalegno, a l'ha mai butà fòra 'n volum ch'a valeissa col ëd Nino Autelli: Pan 'd coa. L'intenssion dl'autor a l'é modesta. Chiel a veul mach raduné, cheuje, e buté 'n vista tradission, storiëtte, manere 'd dì, e proverbi dla gent paisana ant la provincia d'Alessandria. Ma le ròbe a valo tant per lòn ch'a son, come per la manera ch'a son dite. E Nino Autelli l'ha tut un fé sò per conté na stòria ò riporté un proverbi. A fòrssa 'd fatighe e dë studi a l'é rivà a deje a sò discorss na tornura popolar, ciaira e fresca come l'acqua - e per chiel as podrìa ripet-se lòn che a sò temp l'han dije a Daudet: Quelle jolie façon as-tu de dire les choses! Senssa conté che 'l lìber d'Autelli, foravìa dla forma, l'ha un valor particolar per le ròbe ch'a presenta e ch'a son tanti citi bijoux sernù con gust d'artista e con passion ëd folklorista piemontèis. Chi a l'ha lesù sto prim volum ëd Pan 'd coa a na speta n'aotr con desideri e con simpatia.
Nell'Armanach per il 1935 Nino Costa ribadisce:
Nino Autelli dòp Gioanin Casalegno, a l'é un d'i pòchi (ma pòchi dabon) ch'a veujo, ch'a peusso, e ch'a sapio scrive 'd bona pròsa piemontèisa. Sò dialèt a mëscia ansema, con n'armonia sclina e polida, la freschëssa dle sorgiss paisane e la sernia medità dlë studi e dla riflession. S'i l'aveisso 'd cò noi ël permess ëd fé certi paragon, i podrìo dì che i sò racont e i sò bosset a ricòrdo, gnanca tròp da lontan, le pròse toscane dël tersent.
Fin adess Autelli a l'ha mach publicà 'n volum: Pan 'd coa, ch'a l'é 'ncora nen apressià e conossù com'as mérita; però a l'han dine ch'a l'ha nt'sò tirol, bel e pront, n'autr volum ëd pròse ch'a saran na galuparia.
Noi i soma sicur che Autelli, ò prest ò tard, a farà soa strà, e quand ch'a sarà rivà a la mira dla popolarità, noi i saroma fier d'esse stait fra i primi ch'a l'han sentù e proclamà sò valor.
A pag. 1 queste parole di Luigi Olivero:
Le bele faule dle virtù paisan-e e 'l "pan ëd coa" d'una candeur ëd lait a l'ero al mond toe sole gòj uman-e. (Dalla sua poesia A Nino Autelli rilesend «Masnà» N. d. A.)
L'edizione è preceduta da una introduzione di Andrea Viglongo dalla quale riporto alcuni brani:
Nino Autelli è nato a Spinetta Marengo ed è morto stroncato a tradimento da sconosciuti che hanno disonorato il nome di partigiani.
La mia appassionata attività di editore studioso di cultura piemontese non poteva iniziare meglio che col felice incontro anche con Nino Autelli, e Pan d' coa resterà sempre tra le mie pubblicazioni più vissute e più care.
I bruti che stroncarono la giovane esistenza di Nino Autelli non sapranno mai di avere insieme stroncato colle loro mani una grande possibilità d'avvenire degli studi piemontesi.
Autelli era appena all'inizio del suo impegno culturale. Lo dimostra il fatto che, al momento della pubblicazione di Pan d' coa egli suggeriva di presentare il libro «come un primo risultato di ricerche folcloristiche dell'autore».
***
Mentre nel 1931 Pan 'd coa si avvalse della prefazione di Pinin Pacòt, nel 1937 Masnà è dato alle stampe preceduto solamente da questa dedica:
AI MÈ
con la gòi nossenta dle masnà
con le bin madura dl'òm
La descrizione di Masnà che Pinin Pacòt ci offre nell'Armanach per il 1938:
...Nino Autelli, tornà al paìs dòp soa bela aventura african-a, volontari an camisa neira, ch'a l'é rivà fin-a ai pé brusà dle montagne dël Semien da le ponte quatà 'd fiòca; tornà al paìs con l'ànima pien-a 'd sol, ëd calor, ëd figure, a l'ha savù chinesse su sò cheur, ant un gest ëd ripòs, dòp tanta stra e tanta fatiga, e fasend arvive coma ant un seugn soa prima vita masnà e campagnin-a, a l'ha trasfigurala an poesìa, con la dlicatëssa 'd soa arte frësca e squisìa. E cost a l'é 'l miraco 'd MASNÀ. Oh! Un cit miraco, d'acòrdi, coma tute le vòlte che un poeta, anche scrivend an pròsa, a riva, ant la forma armoniosa 'd soa paròla, a deje vita a un seugn, per la consolassionn soa e di sò letor. E ant cost sens, per noi MASNÀ a l'é un miraco.
La magìa dël poeta a l'ha savù evoché le ombre lontan-e e spërdue dij ricòrd, e a l'ha fàit, ëd cite impression ëd legere sensassion, ëd fërvaje 'd sentiment, n'ansema 'd creature vive ant un paisagi real, dova che l'aria a sofia, ël sol a scàuda, la vita a madura, e a l'é tornà, chiel, la masnà, vera sempia cita d'una vòlta, e a l'é guardasse a vive, chiel, òm con sò fardel d'esperiensee 'd fatighe, e a l'ha contà: l'ha contà, parèj, a la bon-a. ant soa pròsa da l'aparensa ùmila e pian-a, ma cadensà da n'armonìa segreta, da un contrapont an filigran-a, ch'a trasformo soa pròsa an poesìa. Certe vòlte ij sò racont a l'han n'andura da poemèt an pròsa, e dabon che soe creature, soe figure, le còse, le ore e ij color dij sò racont, sovens a son pì lìrich che narativ, quasi ch'a fusso 'd tòch ëd poesìa, gropà man man da 'd passagi d'un'elegansa musical...
Nel 1985, edito dalla Ca dë studi "Pinin Pacòt" esce la seconda edizione di Masnà, preceduta da una lettera della figlia di Nino, Paola e dalla presentazione di Camillo Brero tratta da Ij Brandé del 1978 e da un pezzo di Pacòt dall' Armanach piemontèis del 1938. Nella presentazione di Brero è una lettera di Nino datata Cracovia, 27 aprile 1942:
Tra i bambini che vengono al treno (Prego, signore, pane) c'è una bambina che non ha ancora due anni. Si chiama Janka. Abita in una baracca di legno vicina al treno ed è l'ultima di tanti bambini tutti cenciosi e scalzi. Anch'essa è vestita di cenci ma ha una testina bionda e un bel visetto tondo. Ogni giorno la vedo uscire dalla sua casa e si avvicina al treno a piccoli passi ancora incerti, recando in mano un pentolino. Janka non dice nulla, ma appena mi vede mi sorride. Ha imparato subito a riconoscermi tra gli altri soldati. Io mi privo volentieri di qualcosa per farla contenta. Io voglio bene a Janka. Ho dato a questa bambina povera e innocente un po' del mio immenso e traboccante amore per Paola...
Con lo stesso editore, nel 1994 esce la seconda ristampa introdotta da Camillo Brero e da Paola Autelli. Questa edizione presenta anche una dotta dissertazione del Prof. Sergio Maria Gilardino, già docente di letterature comparate presso la McGill University di Montreal, dal titolo Ars nova, ars rara - I poemetti in prosa di Nino Autelli.
Per concludere un racconto breve di Nino Saba Sant dall'Armanach piemontèis del 1934 (magistralmente Nino mi riporta qui a dolci ricordi della mia infanzia N.d.A.); il racconto 'L pan dël mort tratto da Armanach Piemontèis del 1932, non raccolto poi in volume; la poesia di Luigi Armando Olivero dedicata a Nino Autelli A Nino Autelli rilesend "Masnà"
SABA SANT
Pena a së spantiava l'aria dossa d'avril ël prim bòt dle ciòche ch'a sonavo baudëtta,
( e 'l sol, a l'improvisa, a surtìa fòra dle nivole)
via che ti t'corìe ant l'òrt a 'mbrassé, una per una, le piante bele fiorìe 'd perssi, 'd pom, e 'd cerese;
e peui, su, con l'ànima an festa, a lavete la facia rijenta ant l'eva bela ciaira che Mama at tirava dal poss.
E chila - it ricòrde? - at disìa parèj ëd nen suvete j'euj.
Così ch'at restava an sima le parpëile, e it la sentìe 'd cò ant ël cheur, na rosà tuta frësca coma cola ch'a lusìa an sl'erba novela.
'L pan dël mort
Quand ch'i era masnà, bôn'anima 'd me pare, sicôme, anlôra a me pais a j'era gnuñe scole, a l'ha butame 'nt le man a me barba preive, ch'a stasìa 'nt un paisot d'le Langhe piantà propi 'nsima la pônta d'un brich.
Me barba, eben, venta savej, tuti i pover ch'a j'ero d'passage 'nsima a nostr brich ai dasìa da deurme; lon che 'na seira, giusta 'nt côl temp che mi j'era l'à, a l'è rivajne un ch'a l'era pien ëd freid e ch'a tôssìa.
Tôgniña, ch'a l'era la serva, l'ha daje subit 'n pò d'roba caôda e a l'ha falô côgiè 'nsima 'na paiassa.
Ma a l'avìa di s-ciat ëd tôss ch'a fasìa franch peña; e mincatant as butava a parlè tut da sôl.
Mi, ch'i j'era curiôs, sôn andait pianin, pianin tacà la porta e l'hai sentù ch'a disìa parei: «T'l'has propi nen 'na frisa d'cômapassiôn! Lassme chieté 'na minuta!».
E peui ai piava tôrna la tôss ch'a tacava a bôlversselô côme prima.
Bin, veule savei côn chi ch'a parlava côl pôvr'om? A parlava côn sôa tôss, a parlava.
Mi côla neuit, fè cônt, l'hai nen durmì gnanca 'na stissa. I fasìa 'd tut për nen sente, ma côi côlp ëd tôss arbômbavô côsì fort për tuta la cà, che fiña le muraje a smijava ch'arsaôtessô.
A la matin però l'è smijà ch'a steissa 'na frisa mej.
Peui, s'ël pì tard, me barba a l'ha dime a mi: «Va 'n pò a vëdde se côl povr'om a l'ha dë bsogn quaicos».
Mi l'hai tôcalô s'na spala e l'hai faje: «L'ha dit me barba s'i l'eve dë bsogn quaicos»; ma, sicome a l'ha nen dame risposta, sôn andait tacà la fnestra, ch'a guardava 'n s'la valada. Côl dì là a fiôcava largh 'na man. Tuta la val l'era un turbij 'd valosche e as vëdìa pì gnente, fora che côl girè 'd valosche 'nt l'aria.
Mi i sercava 'd fissene uña 'n mes a tute j'aôtre, côsì për fé, e peui 'd seguitela fiña 'n tera; ma a forssa 'd ancantame, côsì che l'hai gnanca sentù me barba ch'a l'era entrà 'nt la stanssa.
«T'l'has nen vëdù ch'a l'è mort?»
Anlôra mi i sôn vôltame dlônch, fasend un tërmôlôn, e i sôn scapà, dël côlp côme la losna.
***
La giornà apress, côme i veui dive, Tôgniña a l'ha fait 'l pan dël mort.
Tuti i pais, as sa ben, j'è sôa côstuma.
Bele là, quand ch'ai meurìa quaidun, a fasìô 'l pan, ch'as ciamava precisament 'l pan dël mort e peui ai na dasìo 'na ghërssa a tuti côi
ch'andasìô a cômpagnelô.
Côsì a l'han damla d'cò a mi.
Ma mi, peña ch'i sôn stait a ca, sôn andait, dë scôndiôn, a stërmela 'n pressa dapara 'n roch, sôta la fioca.
Peui dop, m'arcordô d'cò ch'i sôn mai pi passà davsin a côl roch, l'istess côma ch'ai fussa sôtrà bele là, côl povr'om.
Nino Autelli
d'la Cômpanìa d'ij Brandè (3)
A NINO AUTELLI
rilesend "Masnà"
Voici le temps des ASSASSINS
RIMBAUD
Con le doe man unije a leturil
reso tò lìber, Nino, dle «Masnà»
parèj d'un missalin anluminà.
E an tuti ij nerv l'hai un frisson sutil.
A l'alba dla toa vita 't l'has cantà
j'ànime sempie come smens d'avril
ch'a viro ant l'aria, e, con un vòl gentil,
calo an tèra a visché 'd fior profumà.
Le bele fàule dle virtù paisan-e
e 'l «pan ëd coa» d'una candeur ëd lait
a l'ero al mond toe sole gòj uman-e.
Dë vlu 'd reusa tò cheur a l'era fait.
E a l'han strompatlo, 'd neuit, ëd man nostran-e
con na bala 'd fusil tirà a l'avait.
Sla seuja dla toa cà j'era l'invit
dla canson dla toa sposa ch'a spartìa
sla tàula 'l pan ëd la toa poesìa...
E 't ses mòrt sensa un crij parèj d'un cit.
N'ombra a lassava 'nt l'ombra sò delit
ëd fassion da la guèra anvelenìa.
Na stèila visca an cel. L'ombra a sparìa...
E 't ses mòrt sensa un crij parèj d'un cit.
Le feuje rosse d'un garòfo scrit
j'ero le màcie 'd sangh dla toa ferìa...
E 't ses mòrt sensa un crij parèj d'un cit.
Con ij brass largh, con lë sguard fiss e drit
t'has vist në slussi su n'areà fiorìa...
E 't ses mòrt sensa un crij parèj d'un cit.
T'avie chërdù 'nt la Patria e 'nt la bontà
dla toa gent ëd campagna, ànima pura.
Da j'ambe giàune a j'isbe 'd tèra scura
ël sign ross dla toa cros t'avìe portà.
An front al lìber, con la toa scritura
còtia come j'ariss ëd le masnà,
t'avìe scritme l'ofèrta: «A ti, ancërmà
'd n'anciarm midem ëd seugn e d'aventura».
Për nòst seugn d'aventura it ses cascà...
E mi leso tò lìber inossent
travèrs un vel ëd làcrime d'argent.
Tant che, 'nt la neuit, doe man ansangonà
- Nino, 'd tò sangh! - am calo 'd nans a j'euj
e as saro al còl d'na Mare sensa fieuj.
Roma, 2 agost 1947
NOTE
(1) Federico Garcia Lorca poeta andaluso nato a Fuente Vaqueros, vicino a Granada, il 5 giugno 1898. Fucilato dai franchisti ed il suo corpo per sempre disperso nei barrancos di Viznar, sulle alture retrostanti Granada, il 17 agosto del 1936.
(2) Robert Brassilach scrittore, giornalista e critico cinematografico francese nato a Perpignan, nei Pirenei orientali, il 31 marzo 1909. Collaborazionista e quindi imputato di tradimento ed intelligenza con il nemico. Condannato a morte. Gli fu rifiutata la grazia da parte del Generale De Gaulle. Fucilato nel forte di Montrouge il 6 febbraio 1945.
(3) Come avrete potuto notare la grafia, riportata nel racconto di Autelli, non è quella già utilizzata nel precedente Armanach Piemontèis del 1931. Per mancanza di fondi, Pinin Pacòt era dovuto ricorrere all'aiuto della Famija Turineisa che, oltre a pretendere l'inserimento dei suoi collaboratori ha voluto il ritorno alla grafia utilizzata dagli scrittori che collaboravano al suo giornale 'l caval 'd brôns. Da qui l'utilizzo di ô, ñ che, per correttezza, ho voluto conservare. Gli scrittori e poeti della cerchia di Pacòt, orgogliosamente, si firmarono tutti d'la Cômpanìa d'ij Brandè. Dall'anno successivo Pacòt ritornerà alla grafia cosidetta Pacòt - Viglongo alla formazione della quale avevano collaborato anche, in numerose riunioni nel 1930, Luigi Olivero, Nino Costa, Alfredo Formica, Leo Torrero ed altri ancora.
(4) Nino Autelli. Pan d' coa Leggende e racconti popolari piemontesi Edizioni S. E. L. P. Studio Editoriale Librario Piemontese 1931. Torino. Introduzione di Giuseppe Pacotto - Xilografie originali di Pino Stampini. Pag. 152.
(5) Nino Autelli. Masnà Turin. A l'ansëgna di Brandé 1937 - Con la tradussion italian-a dl'Autor e con i disegn ëd Felice Vellan - Pag. 141.
Piemontèis ancheuj Ann XXXVII N° 12 dzèmber 2019 ~ Ann XXXVIII N° 12 dzèmber 2020.
La bela companìa dij Brandé
Nuovi arrivi tra il 1931 ed il 1938
Negli scorsi numeri della rivista ho tracciato brevemente la storia della nascita de La bela companìa dij Brandé. Pinin Pacòt, dopo la prematura fine del giornale Ij Brandé uscito per 5 numeri nel 1926 con la collaborazione di Alfredo Formica e Oreste Gallina, inizia alla fine del 1930 la pubblicazione di quella serie di almanacchi, il primo per il 1931, l’ultimo per il 1938, Armanach ëd poesia piemontèisa. nei quali, oltre i poeti di cui già mi sono occupato, mano a mano ne appariranno altri, e non solo poeti, ma anche prosatori, musicisti, pittori.
Nell’Armanach per il 1932 ecco Aldo Daverio 1906~1966, Renato Bertolotto 1902~1982 e Carlo Baretti 1888 ~ 1946.
In quello per il 1934 Arnaldo Soddanino 1880 ~ 1963 e Elisa Vanoni Castagneri 1878 ~ 1965 (i due già apparsi nell’Armanach per il 1932 ma ancora non dichiaratisi appartenenti alla Companìa come invece fecero gli altri), e ancora la poetessa aostana Eugenia Martinet 1896 ~ 1983.
Il 1935 è l’anno in cui si presenta infine Mario Albano 1880~1963.
Di questi poeti mi occuperò in questa ulteriore presentazione de La bela companìa dij Brandé.
Per completezza di informazione, qui di seguito alcuni poeti, pervenuti posteriormente nel gruppo, al quale hanno dato ulteriore lustro ma, soprattutto, assicurato la sopravvivenza per gli anni a venire.
Camillo Brero 1926 ~ 2018
Dopo la morte di Pinin Pacòt (1964) sarà lui a raccoglierne l’eredità continuando la pubblicazione de Ij Brandé Antologia ‘d poesia e prosa piemontèisa, nati come seguito annuale alla cessata edizione della seconda serie del quindicinale Ij Brandé Giornal ëd poesìa piemonteisa.
«… la esorto a continuare, perché la poesia è la grande consolatrice. In lei c’è sentimento e sensibilità, il resto verrà col tempo…»
Nino Costa da una lettera a Brero del 24 luglio 1945.
Piemont è la prima poesia di Brero pubblicata da Luigi Olivero il primo ottobre del 1946 nel N° 24 della sua rivista romana Ël tòr
Piemont
Ant sle ponte pi àute dij tò mont,
trames al verd campì dle toe pinere,
an cò dle toe rochere,
mi guardo e leso ‘l tò gran nòm, Piemont.
«Piemont, Piemont|…»
e ai passa un gran frisson
an tuti i cheur, dësviand una canson.
Ël vent ch’a passa ardì sla toa pianura,
ch’as pàsia a ciusioné sle toe colin-e;
le nìvole ch’a van ant l’aria pura
e as fërmo càndie sle sime alpin-e
ripeto ai quatr canton ëd l’orizont
la làuda dle toe glòrie, ò Sant Piemont.
«Piemont, Piemont|…»
e ai passa un gran frisson
an tuti i cheur, dësviand una canson
Brero seminarista prima a Pinerolo, poi ad Orvieto. Proprio a Pinerolo da alle stampe (intorno al 1949) la sua prima raccolta di liriche in piemontese Spluve. Il libretto viene pubblicato dalla da poco nata Stamparla dij PP. Giusepin a Pinareul A l’ansegna dij Brandé. In copertina questi versi:
Arlong le stra dla vita as seta,
sugnand con la natura ël poeta!..
Dalla prefazione a Spluve di Pinin Pacòt:
Una nuova, primaverile voce si aggiunge al coro dei poeti nostrani; voce un po’ acerba ancora, ma limpida e intonata. Certo si affermerà nell’avvenire, diventerà più esperta, più ricca e più forte; ma già essa si distingue tra le altre per la musicale freschezza del timbro giovanile.
È questa la voce di Camillo Brero, poeta – possiamo fin d’ora usare la parola impegnativa – che non deluderà l’attesa di quanti in queste Spluve, in queste sue prime faville presentano il prossimo accendersi della fiamma.
E queste prime Slpuve sono come le prime note, i primi accordi di un’elevata e armoniosa opera di poesia, vera e grande, che io auguro all’amico poeta di poter pienamente realizzare, per suo e per nostro conforto.
Da Spluve
Invern
An cel: i nebion
combato co’l vent,
as saro, a së s-cianco,
al sofi potent,
së squarso… e ìl pòr sol
a guarda, a saluta
për l’ultima vòlta,
da ‘n mes dla gran vòlta
dël cel… e peui sol
darera ai nebion !
Sui mont: na tormenta
sgiafela rabiosa,
‘nt la pas misteriosa
dij brich e valon,
le rampe ambiancà
dla fiòca calà!
Sla pian-a geilà:
a sofia insistenta,
na bisa potenta
ch’a taja la facia
e a smija contenta
‘d fé seufre la gent…
Dal cel, con ël vent
na nebia a sfrisin-a
sutila, sutila…
për tera, la brin-a!
Nel numero di giugno 1962 del Musicalbrandé, Luigi Olivero pubblica questo sonetto dedicato a Camillo Brero:
Mè car Camillo Brero, stamatin
l’hai arseivù tò volumet dë Spluve
ch’a son sùbit viscasse arbicioluve
come dal feu d’un pèilo campagnin.
Ant cost invern che le giornà a son cruve
con un cel niss lustrà da ‘n vent barbin,
a scàudo pi che stanta brinde ‘d vin
toe stanta paginëtte galaruve.
Mè cheur gorègn davsin a tò cheur tënner
s-ciupliss ëd gòi ant na midema fiama
ch’as drissa al cel sensa guardé la sënner.
La nostra fiama a guarda mach le stèile
color dìj’euj dla toa mama e dla mia mama
e nostre spluve ai baso an sle parpèile.
Roma, 4 mars 1949
Verrà poi la raccolta Stèile… Steìlin-e… del 1957 e di seguito una numerosissima serie di altre pubblicazioni poetiche. Nel 1982 inizierà l’avventura di questa rivista, Piemontèis ancheuj, che prosegue ormai, non senza difficoltà, da ben 37 anni.
Con la sua poesia della campagna, Camillo Brero ha trovato espressioni di trasognata musicalità pascoliana, che sta ora maturando in un canto più pacato e umano, in cui si trasfigura il dolore sofferto, ma virilmente vinto. Poeta di stati d’animo, è anche pittore di paesaggi filtrati attraverso la sua sensibilità inquieta.
Alessio Alvazzi Del Frate (Alex) 1890 ~ 1982
Con lo pseudonimo di Alex inizia a collaborare con Pacòt nel 1950 e, da allora, numerosissime sue poesie appariranno sul giornale Ij Brandè.
Di professione giudice, inizia a poetare in piemontese molto giovane, nel 1930 pubblica un opuscolo di poesie in piemontese dal titolo Dop quindes ani… Vers in memoria del Grand President Massimo Coppa a coula dj compagn ch’ai son pi nen. E anche per omagg a me car tir a segn ch’a la sempre vorsome bin.
Postumo uscirà nel 1983 Veij such dël Piemont Poesie in dialetto piemontese pubblicato dal Gruppo Editoriale Forma.
La poesia di Alex, materiata di osservazione acuta e di meditazione solitaria, coglie con la sua ironia le contraddizioni dell’uomo e le sue delusioni, illuminandole di un breve sorriso che spesso è di compassione e di simpatia; non di rado però la sua ispirazione si libera da questo mondo di contingenze per librarsi in una serena contemplazione della natura e dei destini dell’uomo. E ne nasce allora un canto sottile, sospeso tra il sogno e la vita, come in certe sue brevi poesie trepidanti di segreta passione
La poesia di Alex materiata di osservazione acuta e di meditazione solitaria, coglie con pacata ironia, le contraddizioni dell’uomo e le sue delusioni, illuminandole di un breve sorriso. Poesia bonariamente didattica, trepidante di umanità, espressa talvolta con potenza epigrammatica, talvolta con la felicità del frammento lirico moderno. Renzo Gandolfo
La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri Centro Studi Piemontesi 1972
Nota. Volutamente ho riprodotto questi due giudizi su Alex. A volte gli autori non si peritano di copiare riflessioni altrui!
Da Ij Brandé giornal ëd poesia piemonteisa Ann II N° 11 15 fërvé 1947
Mi am basta…
Mi am basta na nìvola bianca
che an cel ël prim sofi la s-cianca.
Am basta na reusa cujìa
travers a dle piante d’urtija.
Am basta na vos che la seira
as leva tut sola d’ant l’eira.
Am basta na steila, na splua,
n’oslèt che për l’aria già crua
frisson-a davsin a mia fnestra.
Am basta un tòch ‘d pan e na mnestra.
Am basta anche gnente, për mi…
Ma ‘l mond i pretendo, për ti.
Un poeta monfrin che a vnisìa fòra ant un moment che la poesia piemontèisa a l’avìa ancor frësca ant j’orìe la lessino squisìa ‘d Pacòt e ‘d Daverio, cola cosmopolita d’Olivè, cola musical (an tut ij sens) d’Alfredo Nicola, cola ‘d bel deuit turinèis ëd Motura. Un poeta monfrin che a vnis’a fòra quand che ‘l boom a l’avìa rancà ij brass pì fòrt da coj brich, quand che le cassinòte a ancaminavo a cingesse ant jë sconde e tërse ca dij turinèis e dj’astèsan, quand che la giusta arvira contra ij mit campagnard a butava an boca a Gipo ‘d paròle mère tan ‘ma cole ‘d «Campagna»: «J’è chi a seugna na vigna / l’aria pura dij camp / ma sti quatr fàlabrach / sta campagna ampestà / lor la vèddo an cartolin-a, / ai la gòdo për na sman-a / ma peui lor a torno a ca, / as na torno a la sità, / con la vita assicurà.»
Un poeta monfrin… com a l’ha fait a seurte, a seurte parèj a Turin peui?
E no! Badalin non è soltanto un poeta dialettale, cioè di quelli che esprimono in dialetto i concetti e i sentimenti come li sentono in italiano. Badalin non potrebbe mai tradurre le sue poesie in italiano. Le sue non sono poesie dialettali, sono paesane, sono «listeurji» che hanno il caldo della stalla, le lacrime silenziose della vite, l’eco ronzante delle cicale, il pigolio dei pulcini al fondo del cortile e d’un tratto s’alzano come il canto del merlo che ha una melodia inconfondibile.
Davide Lajolo dalla prefazione a Listeurji dij Varèi.
Badalin Dumini appartiene alla seconda generazione de Ij Brandé di cui è stato esponente significativo. Ha vinto nel 1968 il concorso di poesia dedicato a Nino Costa promosso dal Cenacolo di Torino.
Da ‘L Bochèt dël Disdeutesim Concors ‘d Poesie Piemontèise «Nino Costa 1968» la poesia
Pas
Dialetto monferrino
Ra vogti ra me ca? ’Nsuma der brich.
Da banda‚ d vì, da t’sori der boschett.
Re ‘na casòta vegia pei d’Bosticch
Ca’ r’avo redità i mei doi vegett
con beni squasi a serb a ‘ddo giornà
da ‘n barba o da ‘na magna. ‘M’na vis nen.
E là re propri vanda mi son nà.
Adess a j’eu ficiala. Ia sta ‘nden
‘na cobbia ‘d carabreis, con in matett.
Travajo der cò lor. ‘N po’ dasient,
ma seu che ra botegad’ Carianet
a pago, sensa fè parlè ra gent.
Ti t’seisi què ca’ preuv beichè la t’sori!
Jeu tanc ‘d coi ricòrd, tucc sbardà
tacà cor’ rivi, ‘n’ti ronzè der mori,
‘n tra sabbia do rivass, drè da ra cà,
der temp lontan co j’era ‘n rabuchett.
T’sii sdatna. Son sta via da qui bomben,
ma mi jeu mai smentiaro ‘r me dialett,
pirchè son i ricòrd ca smentii nen.
Vagh mai a voghi vanda je ra cà.
Ma ‘n frem qui bass e beich ‘r me corin-i
‘r vì sa merii, ‘r pian-i sa laorà,
i prà lisent, ra tera der cassin-i,
‘na tera fòrta pei di so paisan,
ra tera di me vegg, ra tera mia!
Mi ven sa peuss ‘n para ‘d voti ‘r ‘an
ma què cà, veg ‘ncoeu ‘ll’eu sempri qui.
Lo vogti da co r’arbri ‘r Camposanto?
Voeui che da mòrt a vago stremi lì,
per reumi 0n pas ‘nsema i grì ca’ canto.
Da banda ‘i vegg, j’è ‘ncora ‘post per mi!
Nel 1978 l’Editris «il Punto» ha pubblicato la raccolta Listeurji dij Varej Poesie paisan-e dle tère pòvre dël Monfrà.
Nel 1979 la stessa casa editrice pubblica Doe minute për ti Paròle d’amour sitadin-e e paisan-e për tute j’età.
Nel 2006 ancora l’Editris «il Punto» pubblica la raccolta Ij varèj ëd Dumini Badalin cudì da Giusep Goria
Poesia sèmpia e gentila cola ‘d Concetta Prioli Zutta, nà a Turin, ëd rassa astesan-a. Poesia ch’a ven dal cheur, sensa paròle dròle e pressiose, che a parla a nostra gent ant la manera giusta për fesse capì. Poesia ‘d dosseur e d’amor, ch’an fa sentì brav.
Dumini Badalin da Sorch ëd na vita.
E noi, oggi, generazione un po’ scettica e un po’ disillusa che, pur condannando l’oppressione e il male non abbiamo la forza per opporvisi e ci rifugiamo nell’ardente, ma solitaria e inattiva contemplazione di una felicità ideale, in cui continuamente speriamo, ringraziamo Concetta Prioli e con lei ci ritroviamo a cercare, in una notte d’estate
La lusentela dlicà
magica spluva
ant ël so vòl ëd passion
ed auguriamo al volume «Sorch ëd na vita», con fraterno affetto: Buona fortuna.
Celestina Costa dalla prefazione alla raccolta.
Ed ancora la poesia di Luigi Olivero, dedicata a Concetta Prioli, che apre il volume:
dontrè cit granin ëd blëssa ans la facin-a
për avèj ël ritrat d’una damin-a
dël Setsent con un plagi ‘d ciclamin.
L’ha un bel deuit, un acsàn, na vos molzin-a
che quand a parla a fërma ‘l vòl d’j’oslin.
E ‘l vent j’anfila an man d’Aguce ‘d pin
për vëdla a brodé ‘d vèrs fior e feujìn-e.
‘D brodarìe ‘d farfale, ale ‘d carësse
d’una mama che an pèrle ‘d poesia
càngia soe lacrime ‘d malinconia.
Una malinconia con le fatësse
‘d na reusa tea nüansà ‘d dosseur:
ch’a sorid an vlutand ij baticheur.
Per i tipi della Stamparla 3C nel 1979 pubblica la sua raccolta di poesie Sorch ëd na vita Poesie an piemontèis con version italian-a.
Per gli stessi tipi pubblica nel 1989 Titteri Poesie an piemontèis.
Segnalata dal Dodicesim Concors ‘d Poesia Piemontèisa «Nino Costa1962», apparsa ne ‘L Bochèt 1962 e ripresa in Sorch ëd na vita:
Viandant
Na giojera t’anciarma: ògni canton
na tentassion.
Ma a ti, viandant,
ch’it peule gòde gnente ‘d col incant
dël mond, përchè quajdun a l’ha ciamate
e peui smentiate,
ël véder frèid
të sghija sot ij dij ch’at ven-o rèid
për ël possé incontra na bariera
ch’a l’é legera,
ma l’è sbefiarda
përchè a taja fòra chi ch’a varda.
‘T ses ribelate, sì, ma ti ‘t ses nà
për sté dë ‘d sà.
Për ti, në s-ciav,
ël mond a stà ‘n giojera a gir ëd ciav.
Ël tò imploré mai gnun a l’ha scotalo;
‘t l’has mach sugnalo
col pò‚ d calor
për ël tò cheur ch’a l’è ‘n brasé d’amor.
Crasà, batù, sburdì e sensa pas,
viandant, it vas.
Chi për ti a piora?
La fin dij tò maleur l’è mach là dzora.
1962
Aldo Daverio, raffinatamente moderno, sensibile alla pena ed al dolore delle cose e delle creature tutte, dagli uomini alle piante, come è sensibile alla bellezza del mondo sia nella sua naturale apparenza, sia nella luce della storia che illumina le architetture ed i paesaggi.
… un dij tropié dla Companìa: Aldo Daverio, un dij prim ch’a l’abio capì e arseivù ‘l message ‘d Pacòt, un dij pì brav ëd col sercc nen tant grand d’amis ch’a son nen limitasse a deje rason al magìster, ma ch’a l’han savù e vorsù butessje da për da fianch e marcé con chiel.
Daverio a l’è stait un brandé dla prima generassion e, coma për quasi tuti lor e coma cò për Pacòt, për chiel a l’ha contà pì che tut la Poesia (franch da scrivse con la maiuscola), na Poesia da serchesse an silensi e an umiltà, da comunichjla mach a pòchi amis, na Poesia – an fond an fond – sensa grande pretèise e sicurament sensa superbia. A costa passion, che për cheicadun a debordava ant la naività, Daverio a-j portava na preparassion coltural tut àutr che ordinaria e un sens istintiv dla msura giusta ch’as ëspecia sempre ant ij so vers, fin-a an coj sensa boneur.
Gianrenzo Clivio dalla prefazione alla raccolta di Daverio Róndole A l’ansegna dij Brandé Turin 1971
Aldo Daverio, collaboratore assiduo e sensibile de Ij Brandé, appassionato studioso di lingue romanze, cultore di letteratura francese e provenzale, ha espresso nei suoi versi, raffinati e filtrati, il tormento dell’uomo e della natura. Sensibile alla bellezza del mondo, è come costantemente incantato dalla luce che emana dal paesaggio che lo circonda.
Renzo Gandolfo La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri Centro Studi Piemontesi 1972
È lo stesso spirito che, con cura scrupolosa, impone a se stesso Aldo Daverio nel quale l’ispirazione viene troppo rigorosamente plasmata e, pertanto, distratta. Pur tra questo rigore formale Aldo Daverio sa esprimere la ricchezza originale della sua poesia nella quale l’uomo appare come il sofferente protagonista e della quale è conforto la solidarietà dell’uomo per l’uomo e la fede in Dio, ultima soluzione.
Camillo Brero Storia della letteratura piemontese Vol. III Piemonte in bancarella Torino 1983.
Le poesie che seguiranno rispettano scrupolosamente la grafia licenziata dai rispettivi autori nella edizione che viene indicata in calce ad ogni lirica.
La grafia unificata cosiddetta Pacòt-Viglongo inizia ad essere utilizzata da Ij Brandé con il volume del 1930 A Mistral. L’editore Viglongo pretenderà poi, che per la pubblicazione dalla sua casa editrice, allora S.E.L.P. Studio Librario Editoriale Piemontese, nei testi inviati venga utilizzata questa nuova grafia, pena la non accettazione.
Quindi l’Armanach piemontèis per il 1931 si presenterà integralmente secondo la grafia Pacòt-Viglongo. Differente la questione per il 1932. Mancano i fondi. Pacòt si rivolge per aiuto alla Famija Turinèisa da cui otterrà il finanziamento necessario. Dovrà però accettare il ritorno alla grafia cosiddetta de ‘l caval ‘d brôns (giornale della Famija; ritorneranno tra l’altro la ô e la ñ) e la partecipazione all’Armanach dei poeti facenti parte il gruppo della Famija Turinèisa.
Dal 1933 Pacòt riprende il controllo totale del suo Armanach che ritorna quindi alla grafia originale.
Seguendo i testi che appaiono in anni successivi si potranno valutare i piccoli interventi che verranno, mano a mano, introdotti.
sôta ‘n cel gris d’ôtôgn ch’a veul piôrè
e ‘ntorn un gran silenssi prôfumà
che ‘nt l’ànima ij ricord a fa cantè.
La stagiôn generôsa a l’è passà:
sôla ‘na feuja aj resta a tramôlè
s’la sima d’n’erbô; côntra le ventà
ch’ai crijô so destin: meuire e sëcchè.
Fôrsse me cheur ai canta a la natura
môribônda d’ôtôgn ij so dôlor:
piaghe duverte ch’a lô fan patì.
E as sent manchè dôssman ant côla pura
mort ch’a na ven senssa regret nè piôr
fôrsse perchè ch’a peul pi nen guarì.
Da Armanach piemontèis per il 1932 (Testo ancora con la grafia de ‘l caval ‘d brôns)
d’zora n’onda ‘d tempesta ch’at mulin-a,
j’è na scuma ëd dolor su toa ruin-a,
ma ‘n fond al mar j’è na speransa cita.
Na lus lontan-a sota j’eve scure;
na tomba ciaira e bleuva da masnà,
dova che ij seugn, con le soe man dlicà,
a t’andeurmo ij magon e le paure.
Pì nen sente l’arbeuj ëd le passion
ch’a l’àn viscate un feu ross ëd maleur
e ij pior ch’a l’an bagnà tute le pen-e:
a sprofonda l’azur drinta le ven-e
e ant col ciairin, parèj d’un’orassion,
a vija lontan l’autàr ëd tò boneur.
Da Ël Tòr N° 9/10 ~ 22/12/1945 (Ripresa in Róndole)
ant sò viagi pien ‘d mùsiche e ‘d frisson !
Fërvé, j’è ant l’aria già un presentiment
ëd violëtte stërmà sota ij busson.
J’è ant ël prim sol ‘d fërvé na maravija
ëd profum che la tèra a manda sù ;
profum asèrb ëd j’erbo patanù
ant ël profond dla vita ch’as dësvija.
A ciama i sò color, la tèra spalìa
dòp le bise tajente dl’invern cru,
color dla viòla, dël narsiss, dla dàlia…
Ij vent a canto travèrs j’erbo dru;
e ant l’aria vërdolin-a ‘d prime feuje
la tèra a seugna cole smenss da cheuje.
Da Ël Tòr N° 9/10 ~ 22/12/1945 (Ripresa in Róndole)
I
j’è ‘l bate d’ala ‘d na róndola an pen-a.
L’è ‘l prim vòl azardos pien dë speransa
chè, là ‘nt so nì, la speta na fiolansa.
J’ale a bato a le pòrte dla matin
e ‘l sol ch’a la s-ciaris a l’è davsin;
e chila a tornerà drinta so nì
portandje ‘d pan e ‘l prim calor dël dì.
Rondolin-a ch’it seurte a la ventura
con ant ël cheur una speransa pura!
Ànima cita an festa, ànima an pen-a
ant l’ora prima dla matin seren-a,
ant ël sercc ëd tò vòl, tra ‘l sol e ‘l nì,
la matin as dësvìa al tò «bondì!».
ch’a së specia ant la pëschera,
na tribù ‘d ran-e, ciadlera,
a bacaja a gola pien-a…
Ma su, an àut, con la soa pen-a,
bin lontan da cola fera,
n’arssigneul a l’ancaden-a
con soa mùsica legera.
Rìe dle ran-e a gola pien-a,
pior ëd mùsica legera.
ant la neuit chieta e seren-a
ch’a së specia ant la pëschera.
EUJ DËL BEU, nòssent e pasi,
sguard coatà coma d’un vel:
una lerma a ven giù adasi
doa së specie tut ël cel.
Casca giù ‘nt ël sorch, mineuja
cola lerma dla toa pen-a,
meuir ant la giornà seren-a
la campagna ch’as dëspeuja…
E ant la pas ëd la toa stala,
dòp avèi tant fatigà,
a svanis dasianta e uguala
la strachëssa ‘d toa giornà.
Euj dël beu nòssent e pasi,
sguard coatà coma d’un vel:
le parpèile a calo adasi
an sël meuir dl’ultim cel.
drinta ìl cheur na drolarìa:
sia ch’it piore ò sia ch’it rije
an tò sguard l’ànima a nija.
Mi sai nen còsa ch’a sia,
na speransa ch’i t’ëm dije,
sia ch’it piore ò sia ch’it rije,
ò na delusion patija…
A l’è coma un vòl d’avije
sla campagna già fiorija:
s’i t’ëm guarde, t’ëm desvije
drinta ‘l cheur na drolaria…
Da Ël Tòr N° 14 ~ 27/4/1946 (Ripresa in Róndole)
Simiteri ‘d montagna con quat cros,
ant ël silensi ancreus ëd le pinere,
quand che le nebie a calo giù legere
a perdse ant l’aria freida e sensa vos,
e as deurvo dosse drinta ‘l cheur pietos
për tuti ij vòstri mòrt le mie preghiere,
vorrìa ‘d cò mi, sota le vostre pere,
deurme ant un seugn ëd pas maravijos.
Sota la tèra freida ch’a madura
le smens portà dal vent ëd tramontan-a,
ch’a saran fior ëd menta e fior ‘d giansian-a,
sente l’ombra ‘d na cros drita e sicura,
coma n’oferta ‘d fede al cel slargà,
mentre ch’i deurmo sol e dësmentià.
Da Parnas piemontèis Edizioni Il Verdone Torino 1943 (Ripresa in Róndole)
Róndole Poesie piemontesi (Opera postuma) A l’ansegna dij Brandé Torino 1971
Poesie sparse sulle riviste e giornali piemontesi: Ël Tòr, Il Garibaldi, Ij Brandé, Armanach piemontèis, Musicalbrandé.
Una poesia di Armando Mottura del 27 novembre 1931 dedicata all’amico Bertolotto:
Amis, ‘t i-i pense ?!… Vive a cole autësse
‘ndove gnanca j’osej fan nen ël ni
‘ndove ij colp ëd tormenta a son carësse
e giù ‘nt la pian-a ritorné mai pì!
Posé su cole fiòche bërlusente
lë sguard ch’a sà pì nen lòn ch’a veul dì
‘l tràfich dla gran sità e le lamente
dj’òmini trafigon e mal nutrì.
Vive për la canson d’una sorgiss
për ij rifless cangiant dël gran giassé
për ël rifugio ch’a l’è sempre amis.
Peudej guardé lontan, peudej sugné
‘t lo sas dcò ti lòn ch’a veul dì, amis,
come ‘n mes cole ponte as peul canté!
…a l’è stàit un dij pì ativ fondator… (della Companìa dij Brandé) Dòp un dësbut brilant, rimarchévol e rimarcà, ant ël camp ëd la poesia piemontèisa… a l’ha preferì posé soa piuma…
Pinin Pacòt Ij Brandé N° 153 15/1/1953
Renato Bertolotto, pensoso e misurato, raramente affida al verso i suoi sogni ed i suoi fantasmi.
Renato Bertolotto ha svelato in poche composizioni il suo animo. Il suo amore genuino e vivo per la tradizione e la poesia piemontese ne ha fatto e ne fa uno dei più validi sostenitori del movimento de Ij Brandé. Renzo Gandolfo La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri Centro Studi Piemontesi 1972
Na manera particolar ëd vive l’impegn «Brandé» a l’è cola realisà an tuta soa vita da Renato Bertolotto:«Brandé» che, da la prima ora e fin-a a quand ch’a l’ha podù, a l’è stàit a servissi dla càusa e dj’amis.
Soa disponibilità a l’è stàita pari a soa modestia e soa umiltà, parèj coma la blëssa ‘d soa ànima. E polida, trasparenta, dlicà e squasi genà, coma soa ànima, a l’era soa poesìa.
Soa poesìa – un cit bochèt – che Chiel a l’ha vorsù eufre a So Piemont, squasi ciamand ëscusa.
Soa euvra poética, che a passa nen ij vint o tranta componiment an tut, an dà manera d’apressié la dlicatëssa ‘d soa ànima e ‘l candor genit ëd soa ispirassion. Soa poesìa a condivid lë spìrit «squisì» che a l’ha caraterisà l’espression poètica dj’amis ëd la «Companìa».
Camillo Brero dalla prefazione a Come un vòl ëd rondolin-e Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1992
Le seire ‘d San Lôrens, che maravija!
Un fort ôdôr ‘d fen a ven dai prà
e ‘nt l’aria cotia a j’è ‘n perfum ‘d gasija
ch’a së spàntia dal cheur dle bussônà.
Lusent ël cel l’è tut ‘na steila sôla:
ël gril ant l’erba sensa fin a canta
mentre le rañe a crijô a squarssagôla
côacià ‘n sël bord ‘d ‘na gôia tramôlanta.
Le fiôr d’i camp, le frasche d’i bussôn
ant ‘na carëssa d’aria, legerment
a bësbijo ‘nt un sôfi ‘na canssôn
ch’a va perdendsse leugn ansema al vent.
‘Na steila a casca giù dal firmament:
j’è n’anima ch’a vola ‘n Paradis.
An cel së smorta ‘n lum, e ‘n cost môment
an tera i to bei euj l’han un sôris.
A s’anluminô i cheur ch’as veulô bin :
an mes dla neuit nostr’anime sôrele
a tramôlô ans le bôche ant un basin.
Le seire ‘d San Lôrens, côm’a sôn bele.
Da Armanach piemontèis per il 1932, (ripresa in Come un vòl ëd rondolin-e Poesie e prose in lenga piemontèisa Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1992 N° 6/7 Colan-a «Ël mej dij mej») (Testo ancora con la grafia de ‘l caval ‘d brôns).
Feu ‘n sla montagna
Feu lontan, ant la neuit frësca d’istà,
su për ij fianch ëd la montagna ardìa;
segnal ‘d vita lassù ‘nt l’oscurità,
speranssa al caminant, ò lus amìa!
Mi son sol ant ël cheur dl’ombra vlutà,
e i vad sercand na fiama ‘d poesìa,
ch’a s’àossa dai me seugn. Neuit ancantà:
i seugn e ‘l feu lontan ‘s fan companìa.
Con tute le soe vos la neuit a canta,
vos misteriose ‘nt s’ij frisson dël vent…
La lus lontana, spàlia e tramolanta
a smia ch’a meuira, come i seugn dla ment,
ma ‘d colp, na lenga ‘d feu, viva e sagnanta
as drissa al cel, e la montagna a splend.
a seurt come na frësca eva ‘d sorgis,
e la toa vos apassionà e squisìa
l’è na musica ciaira ‘d Paradis,
e la toa boca, reusa dësbandìa
a spàntia so profum e so soris:
ma l’armonïa dossa a vòla via
lassandme ‘n fond al cheur un feu dëstis.
Oh ! Cantme ‘ncora n’aria d’me paìs,
na cansson veja, piena ‘d nostalgia,
vos ciaira e pura come na sorgis.
Dame na fiama neuva ‘d poesìa
adess che primavera a rifioriss.
Cantme ‘nt ël cheur, ò Musa, anima mia!
Da Armanach piemontèis per il 1933 (Ripresa in Come un vòl ëd rondolin-e Poesie e prose in lenga piemontèisa Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1992 N° 6/7 Colan-a «Ël mej dij mej».
Tramont
Ël lagh a deurm an mes a le pinere:
aute le dolomiti a l’orisont
së specio andrinta j’eve personere
ant l’ora silenziosa dël tramont.
Ma peui che ‘l sol a cala, tòst as leva
na còtia e dossa ariëtta dësmorina
ch’a gieuga misteriosa dzora dl’eva
ch’a bogia frissonand a vantajina,
e i sercc slargandse van murì sle sponde.
Le ponte as vesto dle pi bele nuanse
e i pin ciusono come annamorà.
Da le trasse dj’hôtels anluminà
na musica da jazz cuna le danse.
Le barche a riva son cunà da j’onde.
Con mila e mila steile per corona,
a splend an mes al cel la luna piena.
Da la pinera ancreusa ch’a frissona
pian pian a s’ciòd na ciaira cantilena:
l’è un sofi ‘d vent ch’a biauta a ch’a ciusona
da pin an pin parèj ‘d na vos serena,
l’é musica legera ch’apassiona,
una canson ch’ancërma e ch’ancadena.
E la canson a cor da pin a pin,
a vòla e a së spatara per l’argent
dla luminosa neuit piena d’incant.
A va e ven, con andi carëssant
la canson bela sota ‘l cel lusent,
vsina e lontana, an sij frisson dij pin.
Da Armanach piemontèis per il 1935 (Ripresa in Come un vòl ëd rondolin-e Poesie e prose in lenga piemontèisa Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1992 N° 6/7 Colan-a «Ël mej dij mej».
O pas seren-a ‘d na seira ‘d montagna,
quand, sël tramont, ël sol violent a sbat
(ùltime spluve ‘d na giolà ch’a meuir)
i so ragg d’òr lusent sle ponte aùsse,
fassandje ‘d ross, a lenghe ‘d feu! Dal fond
ëd le valade ancreuse, frësche ‘d verd
e perfumà ‘d lavanda e ‘d genepì,
da le pinere s-ciasse e sensa ghì,
nivolëtte legere a fumo come
incens e a monto su, ‘nlupand j’autar
ëd le montagne faite ‘d giassa e ‘d pera.
O incant dël dì ch’a meuir! Adasi j’ombre
a calo sle campagne, adasi j’ombre
a monto su pr’i fianch ëd le montagne,
mentre che an aut ël sol a basa ancora
le sime drite an si giassé ch’a luso.
Auta ant ël cel la prima stèila spalia
a tramola. Peui n’autra a sponta… n’autra…
e n’autra ancora… e mila e mila a s-ciòdo
an fond al cel. Sle ròche drite e neire
le cascadele e j’arianòt ch’a nasso
giù dai giassé, sensa ‘l calor dël sol,
l’han chità ‘d ciusoné. Per la montagna
an tërmoland a brìlio tante splùe:
son ciar ëd granfie spatarà. Tristëssa
d’ora squisìa. Na dossa pas ancreusa
ant l’aria e ‘l gran silensi dla montagna.
Oh, coma ch’a svanisso le miserie
dla gent, le gran-e ‘d tuti i dì, le còse
veuide e sëcche. E coma a torno a vive
le còse bele e sante ch’a fiorisso
an tuti i cheur, le còse bele e sante
ch’a meuiro drinta i cheur, brusà da un sofi
‘d passion uman-e! Che dosseur aj cala
ant l’ànima, che gòi an col moment
dëdnans a le montagne. A canta anlora
l’ànima e an tuta la soa gòi a piora,
a s’àussa vers ël cel e ambrassa ‘l mond,
a tèra e mar e stèile e viv e mòrt.
Ai mòrt ai ciama lòn ch’a j’è dë dlà,
la gòi d’un cheur ch’a bat sot la carëssa
d’un sol ch’a lo riscauda, ai dis la fòrsa
d’un’esistensa che ‘l maleur a tempra.
Ma auta d’zora tut, an mes dël cel
tut anfiorà dë stèile, na paròla
pi dossa che l’amel, pi che na stòla
candia, pi fòrta che l’assel, a splend:
Speransa!
Da Armanach piemontèis per il 1937 (Ripresa in Come un vòl ëd rondolin-e Poesie e prose in lenga piemontèisa Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1992 N° 6/7 Colan-a «Ël mej dij mej».
Come un vol ëd rondolin-e Poesie e prose in lenga piemontèisa Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1992 N° 6/7 Colan-a «Ël mej dij mej»
Poesie sparse sulle riviste e giornali piemontesi: Ij Brandé, Armanach piemontèis, Musicalbrandé.
… poesia che sensa tëmma i podoma dì che a resterà viva e pura, comoventa e anciarmanta, fin che a-i sarà un piemontèis che a parlerà piemontèis.
Pinin Pacòt Ij Brandé N° 216 ~ 1/1/1957.
Carlo Baretti era figlio di Eraldo Baretti, poeta lui pure e uomo di teatro, autore dei «Fastidi d’un grand òm». Nato a Roma ma cresciuto ed educato nella paterna Mondovì, trasse dalla natura le note più nobili e pensose della sua poesia. Poesia sincera, semplice e limpida, che pur nel tono popolareggiante scopre delicate intuizioni di lirica bellezza.
Carlo Baretti rimane il più limpido ed estroso chansonnier piemontese della nostra epoca e con “La Carmagnola” egli attinge il vertice della satira d’attualità politica e umana, armonizzata secondo i canoni stilistici della più schietta e brofferiana tradizione piemontese. Ma il suo canto aveva altre corde vocali delicatissime: quella della Musa monregalese che racchiudeva in quadretti agresti, di una semplicità toccante, tutti gli aspetti di un mondo rurale bonario, filosofico, umoristico che egli sapeva animare fino all’evidenza concreta, sia nel verso sempre duttile e caldo, sia nella sua arguta, coloratatissima recitazione; quella della Patria che egli cantava senza retorica, raffigurandola nella famiglia, nei bimbi, negli umili fanti, nelle espressioni quotidiane e spontanee di questo grande amore per il proprio Paese. Salutme ‘l Moro, Piuma bianca, Campagna sono i volumi che lascia Carlo Baretti, poeta, avvocato, industriale, giornalista in gioventù, uomo di animo gentile e di singolare humor gradevolmente comunicativo.
Luigi Olivero da La mòrt d’un “chansonnier” Carlo Baretti Ël Tòr N° 29/30 ~ 15 Dsèmber 1946 ~ 1 Gené 1947
Dal numero di marzo 1986 del Musicalbrandé la poesia di Luigi Olivero:
Cantada ‘d primavera për Carlo Baretti
ant ël quarantésim anniversari ‘d soa mòrt
Son passà quarantani e a smija mach ier
che toa vos càuda – angiolivà ‘d carësse
‘d j’ale ‘d mila colombe ‘d toa Campagna –
cantava ij tò paisan rùid e sincer,
laudava toe matòte archincà ‘d blësse,
j’èrbo da fruta e j’èrbo dla cocagna…
Son quarantani che t’ëj pi nen,
ma ‘l mond t’lo s-ciàire ancor dal cel seren.
Përchè ij tò euj son j’euj ëd tuti ij mòrt
e ‘d tuti ij viv ëd la toa gent onesta.
Son d’euj che, ai ragg dël sol d’istà, s’andòro.
luzo, ‘d neuit, dla rozà ch’angëmma j’òrt.
E a spècio, ant ij lumin, le gale ‘d festa
dël tò prim cansonié Salutme ‘l Mòro !
Ò poeta che ‘t l’has eufrì ai quatr vent
la toa vos pura, e, al cel, j’euj trasparent.
Ti ‘t ses rëstà con noi, mej che da viv.
Ant ël rije dij rì ‘t sentoma a rije.
‘D ciaucin pëpijo an toa parlada franca.
Drinta un pom ross cëziss tò cheur gioliv.
Toe rime a son dë spluve d’òr d’avije.
Sui giassé ‘d j’Alp vòla toa Piuma bianca…
Ò cantor dël travaj e dël soris,
tò sangh a beuj ant ij garzeuj dle vis.
T’l’has consolà ij maleur, vantà ‘l boneur
d’avèj le ven-e anradizà ‘nt la tèra
doa che ij tò seugn masnà j’ero fiorì.
Sla bëdra ‘d j’iscariòt e dij bruteur,
che a l’han vendù la Patria an pas e an guèra,
con toa sàtira adreta it l’has colpì.
Sfèrsa ‘d Brofferio an pugn, ti, ‘d bòt an blan,
t’l’has ëdcò strivassà ‘d gheube ‘d rufian.
Ant ël cheur dël Piemont vivrà tò nòm
lijà con l’armonios nòm ëd tò pare
arald ëd nostra sena proletaria.
Le toe strofe ‘d poeta galantòm,
sclin-e parèj ëd mùsiche ‘d fanfare,
arson-o e arsoneran për sempre ant l’ària.
L’ària dij brich profumà ‘d pèrsi an fior
che a l’ha viscà ‘l tò prim basin d’amor.
*
Carlin Barèt, amis d’mia gioventù,
magìster ëd fuzëtte d’alegria,
arcòrdme, come mi t’arcordo ancora.
E con la gòj che un temp l’avîo godù,
da menestrej fedej ‘d Santa Folìa,
fa che t’arvëda quand sonerà mia ora.
fa che peussa basete ij neu dle man
come un fratel ch’a torna da lontan.
Un tò fratel pi giovo. Un vagabond
an tèra, mar e cel. Un barabòt
dl’età d’òr dij poeta òmo d’onor…
I seve andavne tuti ant ël profond
dël misteri dla mòrt: Costa, Pacòt.
Alban, Frusta, Daverio… e ti con lor.
Speme, Barèt. Veuj che, ambrassandte, un di,
canto a doe vos le glorie ‘d tò Mondvì.
Pasieve…! Pasieve…!
Mach l’atra seira mentre ‘ndava a spass
Mentre mi ‘ndava…
J’eu vist dapé dai porti ambarônà
Tanta ‘d sa gent e tuti sarà s-ciass,
Che a tuta prima, per da bôn, ô smiava
La piassa granda quand ch’is fa ‘l mercà…
‘N mes j’eva ne strôp ëd farinei
Tuti rangià ‘nt un reu
Côn ‘na maseta ‘d piume sui capei
Ch’i vardavô ‘n padrôn tut vestì ‘d bleu
Ch’ô stava drit ansima a ‘na bancheta
E ôi fava ‘d segn a tucc con ‘na bacheta…
Basta là che rassa ‘d gieu da fè!…
‘N j’elô pì gnuñe laude da ‘nventè?
Un ô sôfiava drinta a n’ambôssôr,
Un ciucciava ‘na pipa sberlusenta
Come ‘l fônd d’una brônssa dla pôlenta,
N’atr ô fumava un bastôn fat a tôirôr…
E ‘nt un cantôn, côn n’aria d’impôrtanssa
Un fôlatôn côn un batocc an man
Ô ‘s dava di patôn su ‘na gran panssa,
Dapé da n’atr labran
Che côn dôe querce larghe côme ‘n val
Piantava pì rabel che ‘n tempôral.
Chèl là ‘n mes, côn quat righe sul capel
Quand ch’ô sentiva a fé ‘n pò trop bôrdel
Ôi fava ‘d segn, côm ô voreissa dì:
- Pasieve, fieui…! Pasieve…! -
Bônom d’un bônômass !…
Côm ô pôdavlô mai fesse capì,
S’ô l’ava ‘dmà da fè côn d’ii rascass
Ma senssa educassion e dissipliña…?
Propi parei, j’eu vistlô fiña mì…!
Bastava ch’ô vireissa un po’ la schiña
Che j’acc da l’atra i stavô lì a vardesse;
I favô tucc ël mort.
E quand ch’ô capitava peu a viresse
Smiava l’istess côm ô parleissa ai can,
Côm ô parleissa…
Côn pì ch’ôi fava ‘d segn côn le dôi man
- Pasieve, fieui!… Pasieve…! –
Côn pì che gnun ô smiava se sfôrseissa
Mach per desdéssi, mach per feie tort,
A fè sarabanda ‘ncô pì fort…
(Andôa a descriv an dialet d’Môndvì la prima volta ch’a l’à vist una banda musical.)
Da Armanach piemontèis per il 1932. Ripresa in Salutme ‘l Mòro A l’anssëgna di brandé Turin 1935.
Bona educassion
Chi élo ch’o l’ha dit che ‘nt le caossagne
‘S peu nen trovasse ‘d bona educassion.
E che ‘l paisan ch’o viva ‘nt le campagne
S’o veu traté polid o l’è nen bon?
O venta nen parlé senssa savèi:
O l’è manch vèi na frisa, o l’è manch vèi!…
Tajà coma ch’os disa a la carlona
Soma nen fat per fé na gentilëssa
Ma, e con lò?… Nostra mare élo nen bona
A solié ‘d cavèi biond con na carëssa ?
Mare a l’è sempre mare, a tuti uguai,
Anche se le soe man son piene ‘d quai…
L’educassion ch’i j’è ‘nt ël gran sità
A l’é come ‘l formagg ëd gorgonsòla,
Ch’os buta ‘nt ël gioiere anvlupatà
Drinta na bela carta dë stagnòla.
A veghlo, nen da dì, os presenta ben
E s’it lo nufi avsin o spussa nen.
Ma s’it lo grati ‘n pò, tente da ment,
Soma sicur come un e n’at fan doi
Che fòra da l’anvlup dël feuj d’argent
O spussa pèi dël bross ch’i foma noi.
Da Armanach piemontèis per il 1933. Ripresa in Salutme ‘l Mòro A l’anssëgna di brandé Turin 1935.
La ferovìa neuva
(28 Otòber 1933)
A la memoria
‘d DELFINO ORSI
Quand j’eu vist ël prim treno a traversé
La ‘nssima al pont… òh fieui!… penssé che festa!
I son sentilo tut a termolé
E ‘l cheur o smiava ch’am sauteissa ‘n testa.
Son butame a bramé ch’i smiava ‘n fòl
Fin quand che ‘n grop, ma streit come na mòrsa
O l’ha ciapame pròpi sì, ‘nt ël còl
E o l’ha fame ste cito con la fòrssa.
Pensava ai nòstri mòrt: a coi ‘d Mondvì
Che tant j’han travajà e sufert da soi,
E prima dël moment i son partì
Senssa podei fé festa ‘nssema a noi.
Da Armanach piemontèis per il 1934. Ripresa in Salutme ‘l Mòro A l’anssëgna di brandé Turin 1935.
Galileo Ferraris
(Dëdnans al monument)
Chi o l’è-lo chèl-lì con sa fracanda
ch’os no sta drit an pé, con j’euj sarà,
e o l’ha sa fìa patacia da na banda
con n’aria tanto smòrta e sbaruvà…?
Sta chet, borich, e fate nen sentì…
L’é Ferraris, nen un basta ch’o sia,
ma col che con la dinamo, ‘n bel dì
o l’ha gavane fòra l’energìa.
- E chi sa che ‘d milion ch’o sarà fasse…
-Ma che milion ‘d mia nòna… Speta ‘npess!
Chèl-lì, sto brav òm, o l’é artirasse
e o l’ha fane ‘n regal per ël Progress.
Ma sto Progress, ch’o marcia sempre drit
o l’ha piassà ‘n comersi sto boneur
pensand a ricavene ‘n quaich profit,
e dòp d’alora o l’ha ‘nventà ‘l conteur.
Da Armanach piemontèis per il 1936.
La Carmagnòla
CARI AMIS, se la memoria
Sèrv ancora a fé dij cont
Veuj arvëde un po’ la stòria
Dël mè vei e bel Piemont.
I veuj deje n’arpassada
Ai bej temp ch’a pòrto impress
Tra le date d’un’anada
Tanti seugn dël nòstr progress
E tornemne a col dì là
Ch’i l’eu fait n’eredità.
Fèrm an mes a la bataja
Soridend sota ai barbis
Tra la sfida e la mitraja
Dij potent e dij nemis,
Ij mè vej l’han fame erede
D’un vestì republican
Con l’esempi d’una fede
Ant l’Italia e j’Italian
E a l’han dime: ten-lo lì
Ch’a l’è sempre un bel vestì.
E così ant na cassia ‘d tòla
L’è restame tra le man
La mia bela carmagnòla
D’un pann fin color safran.
Fàita un pòch a la goliarda
Da ‘n sartor ëd coi an piòta
La bordura e la cocarda
Atacà su la matlòta
E la vita un po’ sancrà,
L’è una vera rarità.
I mè vej a l’avìo piala
Da la mòda dij Fransèis
Ma purtròp a l’han portala
Mach adòss për pòchi mèis.
E l’è stait un gran darmage
Per coi cari mè parent
Che an partend për ël gran viage
L’han scrivù sul testament:
Ten-la ben e vendla mai…
Vnirà un dì ch’at ven a tai.
Mi, d’anlora, con giudissi
L’eu guernà tra i mé tesòr
Col ricòrd con ‘d sacrifissi,
Com a fussa n’oget d’òr.
Ma ij bandì con prepotenza
Una neuit, mentre i deurmia,
L’han forsame la chërdensa:
Son riuscì a portemla via
E poi dòp, costi balòss,
Son-ne pà butassla adòss?
Nen savend come ch’a fassa
A tratela con bel deuit,
L’han portala su la piassa
Spassëgiand ël dì e la neuit.
Sensa msura né criteri,
Arvisandse ant ël pautass,
A l’han fane un diavoleri
Com a fussa un tòch dë strass.
L’han mandà quasi a rabel
Un ricòrd polid e bel.
Mi, a bon cont, l’eu la manera
D’artrovela, ma pitost
Chi sarà la lavandera
Ch’a peudrà butemla a pòst?
Deje torna l’elegansa
La virtù dël portament
La fiducia e la speransa
Për l’avnì dla nostra gent?
Come fé a portela istess
Su la stra dël nostr progress?
Ventrà fé na lavatura
Con le frange e con ij fiòch
E arsentela ant l’aqua pura
Për dle sman-e e ancora un pòch.
Sèrti odor ch’a fan vnì mal
E ‘l ricòrd dle brute fàcie
D’coi ch’a l’ha butale an bal,
J’andarà d’ij bej fërton
E na spòrta ‘d bon savon…
Da Ël Tòr N° 15 ~ 11 Magg 1946
Salutme ‘l moro Al’ansegna dij Brandé Turin 1935
Piuma Bianca Rime piemontesi Bonis Torino 1942
Campagna Poesie piemontèise Ij Brandé Turin 1949
Poesie sparse sulle riviste e giornali piemontesi: Ël Tòr, Ij Brandé, Armanach piemontèis.
Arnaldo Soddanino, un poeta dimenticato nonostante l’imponente mole di lavori pubblicati (e non solo poetici); vederne qui in calce parte della bibliografia.
Sfogliando le varie storie della letteratura in piemontese pubblicate, di rado lo si trova nominato e quasi nessuno lo cita come poeta. Un solo giudizio che ho rintracciato è quello dato da Renzo Gandolfo, non troppo lusinghiero, che si può leggere qui sotto.
Ferrero, Brero, Tesio e Malerba nei rispettivi lavori, neanche lo nominano. Questo, a mio modesto avviso, è un motivo in più per cercare di favorirne una rivalutazione.
Olivero, nella sua rivista Ël Tòr pubblica, tra il 1945 ed il 1947 parecchie sue poesie: questo mi sembra già un buon metro di giudizio. Qui sotto il poco che ho trovato scritto su di lui.
Arnaldo Soddanino è pseudonimo di Giovanni Soddano. I suoi versi hanno incontrato grande simpatie ed interesse tra i cultori della poesia in piemontese dimostrando, come scrive La Stampa, annunciandone la morte il 7 gennaio 1963, una «vena creativa fertile e popolaresca».
«Una vena di verseggiatore anche troppo facile e poco controllato» è quanto gli rimprovera Renzo Gandolfo in La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri Centro Studi Piemontesi 1972.
Adess, Soddanino, a l’ha già festeggià soe nòsse d’òr ëd poesia. I chërdoma che ij nòstri letor a saran content ëd lese ‘l bel sonèt, che Luigi Olivero a l’ha dedicaje an costa ocasion e ch’a deurb ël volum ëd «Sôta la Mole»
Al Poeta Arnaldo Soddanino
arseivend so lìber «A l’ombra ‘d mè cioché»
‘t festegie ij cinquant’ane ‘d poesia
mi son mach un galèt con la puvìa
ma a le toe nòsse d’òr i veuj canté.
Veuj canté la toa lauda a garabia
për mont e pian, për rive e për senté,
tant che le ciòche a taco a ciocaté
da tò cioché ch’a strambìa d’alegria.
O Sodanin, ardì come un cardlin
ëd piume grise ma con ël bech dur
ch’a scriv ancora «amor» sël feuj dl’azur:
tente ai branch àut e scàuda un nì ‘d basin
për toe nòsse ‘d diamant còtie ‘d boneur
con la Musa ‘d Turin ch’at rij an cheur !
Roma, 13 magg 1949
Pinin Pacòt in Leturil da Ij Brandé Giornal ëd poesìa piemontèisa N° 106 ~ 1 Fervè 1951.
Da Storia ‘d Pietro Micca
XXV
Për sentinela a jé dôi minadôr,
un, Pietro Micca, e l’aôtr, cômpagn dlà drinta,
che, vedend ël pericôl, l’han fait finta
ëd niente; a l’han pregà ‘ncôra Nôssgnôr…
Peuj, Pietro Micca, ‘l braô sôldà ‘d vlôr,
a côr tacà la porta, ai dà ‘na spinta
sarandijla ‘n sël nas d’j’assalitôr
ch’a j’erô lì a dôi pass për intré drinta.
E peuj as volta ‘mpressa a ‘l so côlega
e ai crija ‘d visché subit uña miña
për fe saôté la galerïa ‘ntrega.
Ma l’aôtr, che ‘n po’ dubiôs, a së ‘ncamiña,
capiss che deje feu veul dì la plassa…
a resta lì paurôs ch’mé ‘n toch ëd giassa.
XXVI
…
E vist che so cômpagn a tramôlava,
ch’a l’era lì splufrì, la mort a ‘l cheur,
penssôs për coul môment carià ‘d maleur…
Lô ciapa për un brass, lô pôssa via.
La porta a ced, e Pietro Micca a crija:
“Viva ‘l Piemônt!” Mentre ‘l nemis intrava.
XXVII
…
‘L nemis a l’è intrà e già a s’avanssa
sbefiand côn prepôtenssa senssa fin;
ma Micca, d’uña, bin decis, së slanssa,
côn coul côrage ch’a rend l’om tranquil,
sicur che côn la mort salv-rà Turin…
a slônga ‘l brass e a visca ‘l prim baril!
Da Storia ‘d Pietro Micca ~ Sonèt piemonteis Editore Negro Torino 1906. (Grafia ‘l caval ‘d brôns)
La mia canssôn
l’è nen côla ch’i cantô tuti ij dì;
la mia canssôn l’è ‘l sôfi dl’infinì
che mach ‘l cheur, mach chiel a sa cantela!
La mia canssôn, la mia canssôn pì bela
l’è ‘l but ‘d ‘na fiôr ch’a sta për rifiôrì,
l’è ‘nt le mie veñe, ‘nt ël me sangh, l’è ‘nt mi ;
la mia canssôn l’è l’anima sôrela.
La mia canssôn a viv ant la mia vita;
l’è senssa le parole, senssa vôs,
senssa prôfum, parei d’uña margrita.
L’è ‘n sentiment dlicà, gentil, grassiôs;
l’è pas, l’è amôr, l’è gioja, l’è armônia;
la mia canssôn l’à mach un nom: pôesia!
Da Armanach piemontèis per il 1932. (Grafia ‘l caval ‘d brôns)
Mi canto na canson!
Per ògni còsa ch’a j’è ant nostra vita,
per ogni reusa dal profum pi bon,
per na modesta viòla ò na margrita,
ò per na fior servaja di busson…
mi canto na canson!
Quand che ant ël cheur, parèj d’una dëmora,
aj passa ‘l feu terìbil ‘d na passion;
quand che la ment a rij, l’ànima a piora ;
quand che improvis im ciapo n’arbuton…
mi canto na canson!
Per tut, tut lòn ch’aj ven da la natura,
ch’a sia dolor, ch’a sia felicità,
ch’a sio belle speranse, o sia impostura,
ch’a sio ilusion d’amor ò faussità…
mi fasso na cantà!
Su ‘l sol ch’am basa e su l’ariëtta pura
ch’a passa carëssand le piante e i fior;
su ‘l dì pi bel, ò su la neuit pi scura,
su tut, tut lòn ch’aj ven dal bon Signor…
fass na cantà d’amor!
Su l’alba ch’a së slarga su la tera,
su ‘l cel seren ch’a cheuj ant i so brass
tut col bel verd ch’aj seurt an primavera
e su j’osei ch’a subio n’inno ‘d pas…
fass na canson ch’a pias!
Per ògni còsa oribil, faussa, bruta,
che peui a slarga an tuti i so canton
le lacrime, quand n’ànima a sangiuta,
e ch’a distruv tute le bone assion…
mi canto na canson!
Su tut lòn ch’a traversa la mia vita,
ògni moment, ò brut ò bel ch’a sia,
da la pi gròssa còsa a la pi pcita…
fasend una canson!
Da Armanach piemontèis per il 1935.
ij caussèt ëd seda për andé
a spass con ij giovnot a la duminica :
Vèrs la colin-a
con ij so brass, parj d’un monument,
col gran palass Madama, e, finalment,
a pass për pass, toché la prima sponda
dël Po ch’a scor tranquil e pian, con l’onda
che borbotand a va, seulià dal vent,
smorsand l’eco gentil dle vos ch’a sent
a vnì vèrs noi con na passion profonda…
L’eui a s’ancanta ‘d nans a na sorprèisa,
dë ‘d nans na maravija sensa fin:
tut a l’é vèrd, l’è tuta na dësteisa
ch’a s’àussa vèrs el cel fin ch’a lo toca.
L’é coma l’impression d’un bel basin
stampà da ‘l feu ‘d na boca ‘n s’n’àutra boca.
2
As tira anans travèrs a tut ël pont
e as ràmpia sempre su, su për ël Mont,
fintant ch’as sent a vnì la lenga spëssa.
Tut a l’é vèrd e bel, tut an carëssa :
e ij mè bej temp d’amor am torno a ment,
sot-brass a chila – al sol, fra pieuva ò vent…
L’era ‘l viagèt festiv, surtì da mëssa!
Adess, për mi, purtròp, a lé un po’ trista
costa spassgiada su për la colin-a!
An manca l’ideal ch’ai va a l’artista;
am manco coi basin, tut feu e gigèt,
ch’a butavo un giovnòt a la ruvin-a
për un’ongià… ‘nt la seda d’un caussèt!
Da Ël Tòr N° 16 ~ 25 magg 1946.
Un poeta bicerin che làuda la primavera d’invèrn
Coma l’è bel…
su l’erba còtia e tënra an fond a un prà,
sota le frasche an broa ‘d na boschin-a
che gnanca ‘l cel an vèd: pròpi stërmà
andoa ‘s sent mach la lòdna cantarin-a;
e strenze s-ciass na fiëtta ant na brassà
për filtré ant cheur la musica divin-a
dij basin dla soa boca profumà!
E, li, canté nostra canson pi bela:
cola ch’a riva, come un sofi ‘d vent
ant ël profond dle ven-e e an fa content…
Peuj quand ch’ai seurt, rijenta e barivela,
la lun-a për butesse an su l’avàit,
basela an boca e… lòn ch’l’è stait l’è stait!
Da Ël Tòr N° 29/30 ~ 15 Dsèmber 1946 –1 Gené 1947.
La leggenda di Pietro Micca 50 sônet piemônteis Tip. Monetti Torino 1906
Pagine d’or (eroi dij monti) Edizione Commerciale Torino 1917
Le stèile (eroi dël cel) Edizione Commerciale Torino 1918
Reuse ‘d mè giardin Poesie piemontèise Negro Torino 1934
Fior d’urtie 100 sônet piemônteis Negro Torino 1948
Sôta la Mole Rime piemontese Negro Torino 1951
Storie ‘d mia nona 100 sônet piemônteis Negro Torino 1953
Storia e gloria dël Valentin Rime sentimentai an piemontèis Negro Torino 1960
Poesie sparse sulle riviste e giornali piemontesi: Ël Tòr, Ij Brandé, Armanach piemontèis.
Quaicòsa coma d’un Nino Costa, trasportà su un registr ëd gentilëssa feminil.
Varia è la sua ispirazione: paesaggi naturali risolventesi spesso in paesaggi dell’anima; visioni commosse dell’umana sofferenza, accanto ad allegre interpretazioni della vita. Sentimento ed “humour” alternatisi, a volte allacciatisi in un sorriso, che non si sa se più triste o giocondo. Non di rado una poesia forte e serena, quasi virile.
Pinin Pacòt Antologia piemontese Il Popolo Nuovo Torino 1954
…nome di donna che onora la poesia piemontese è quello di Elisa Vanoni Castagneri, professoressa di lettere, costantemente presente sui periodici specializzati dell’epoca fu assidua collaboratrice de «Ij Brandé» dal 1946 in poi e del «Musicalbrandé» fino all’anno della sua morte che avvenne nel 1965. (Il nome di Elisa appare precedentemente con la poesia Ël bal dle stèile sulla rivista di Luigi Olivero Ël Tòr N° 9/ 10 del 22 Dsèmber 1945 e ancora sulla stessa rivista con Fnestra duvèrta nel N° 12 del 30 Mars 1946; Ij Brandé inizierà la sua lunga e meritoria strada solo il 16 settembre dello stesso anno. Nota dell’autore) La sua voce ha un vago sapore crepuscolareggiante.
Camillo Brero Storia della letteratura piemontese Vol. III Piemonte in bancarella Torino 1983.
A NINO COSTA
Da la finestra duverta ‘nt la stanssa,
ai ven l’eco ‘d sent mila rumôr,
la vôs rauca d’le trômbe a së slanssa,
sôñô i claxon, a urlô i môtôr.
Côn na musica dura e viôlenta
ch’a sbardiss, a t’esalta, a t’invita,
as fan largo, ‘nt la strà turbôlenta,
ste vôs neuve ch’a inegiô a la vita.
………………………………………
Ma a j’è d’le vôs, ch’a l’àn n’aôtra armônìa,
che senssa che it n’ancorsi, at rivô al cheur;
che a sôn gnente… e a sôn tut: sôn la pôesìa,
che a t’incanta, e at cônssôla ‘n t’ii maleur.
…A l’è ‘l gëmmi dël vent ch’a porta via
le feuje morte, quand ch’a ven l’ôtônn…,
a l’è ‘l pichè d’la pieuva, ch’a në smìa
un sôspir, un lament, una canssôn…
A l’è la vôs dël mar ch’a meuir s’la spônda
e at cuña adasi, adasi, e at fa sugnè;
l’è ‘l ciusiônè d’un nì, sôta ‘na grônda,
l’è ‘l rìe ‘d ‘na sôrgiss, sôta a ‘n rochè.
A l’è la vôs d’na cioca ch’a dindaña
për l’aria lila d’un tramônt dôrà,
l’è ‘na canssôn ch’as perd là giù ‘n t’la piaña,
l’è ‘l gargôiè grassiôs d’uña masnà…
A j’è d’le vôs ch’a sôn pieñe ‘d malìa:
sôn vôs eterne che a t’arivô al cheur
ch’a fan fiôrì ‘n s’ii laver la pôesìa
ch’a t’incanta, e at cônssôla ‘n t’ii maleur.
Da Armanach piemontèis per il 1932. (Grafia de ‘l caval ‘d brôns).
ch’a rijìa,
ch’as perdìa
tra l’erbëtta e tra la giaira,
l’à pì nen ‘na stissa d’acqua!
L’è finìa,
l’è sparìa,
l’è mancaie la sôrgiss,
mai pì gnun a la desvìa!…
La speranssa ciaira, ciaira
ch’a fiôrìa,
ch’a lusìa
côme perla propri raira,
drinta al cheur e a lô scaôdava,
l’è finìa,
l’è svanìa…
Senssa chila, ‘l cheur a manca
mai pì gnente a lô desvìa!…
Da Armanach piemontèis per il 1932. (Grafia de ‘l caval ‘d brôns).
L’arssigneul ant la boschina
tacà al ni, canta d’amor:
la vos frësca, dossa, sclina
a dësvìa tute le fior.
L’è cascaje na steilina
tra le reuse tute an fior,
per scoté da la boschina
l’arssigneul canté d’amor.
E ant la neuit tëbbìa, azurina,
piena ‘d calma e dë splendor,
dël sò cheur a dìs l’amor,
l’arssigneul da la boschina.
Da Armanach piemontèis per il 1933.
ch’as dëstaca e ch’a së s’cianca.
N’ann ëd vita ch’a spariss,
quaich speranssa ch’a svaniss,
e it ancòrse quasi gnanca.
Da Armanach piemontèis per il 1934.
ch’as dëstaca e ch’a së s’cianca.
N’autr anèt ch’a s’ancamina,
quaich speranssa ch’a s’avsina,
e it n’ancòrse quasi gnanca.
Come sempre… come prima…
Da Armanach piemontèis per il 1934.
Na pèndola cita
dësgrana, dësgrana
le ore dla vita.
A va la lansëtta,
tich, tach, pian pianin.
A passa la vita:
soris e sagrin.
Fantàsine ‘d glòria
s’anvisco, as dëstisso:
së smorto man man
i seugn ch’a fiorisso.
Le ore dla vita
na pèndola cita
dësgrana, dësgrana
mai sempre così!
Da Armanach piemontèis per il 1936.
QUAND CHE la neuit s’avsin-a,
quand che le ombre a calo,
là ‘d zora dla colin-a
tute le stèile a balo.
Balo con deuit,
con mila inchin:
quand ch’a l’è neuit
quanti ciairin !
mentre le stèile a giro,
le stèile a sò passagi
s’inchin-o e peui sospiro.
Sospiro pian,
balo con deuit,
ij seugn a van
quand ch’a l’é neuit.
giugand ansema al vent,
ij seugn ‘d cò lor as perdo
darera a un fil d’argent.
Lontan, lontan,
giugand a cheuit,
së sperdo e a van
quand ch’a l’è neuit.
Da Ël Tòr N° 9/10 ~ 22 Dsèmber 1945.
për fè torna San Martin
da ‘n pachèt pien dë scartari
l’é scapaje un rissolin.
Pian pianin l’hai carëssalo!
Biond e fin come òr filà,
chi sa mai, se l’hai guernalo,
quante còse a ricorderà.
E rivëdo ant la memoria
mila teste scarpentà
e rifass tuta la stòria
dle mie cite an-namorà.
… Ma Nineta a l’era brun-a
e Maria color dl’henné,
Lussìa, peuj, second la lun-a,
nèira, rossa ò platineé.
a sio vnume sti cavèj.
Ò testin-a rissolin-a,
che regret pi nen savèj!
Che regret! Drinta n’armari
j’era un seugn: chi lo savìa?
Da ‘n pachèt pien dë scartari
un soris l’é scapà via.
Un soris, forse na stòria.
Bruta ò bela, chi lo sa?
Un soris sensa memòria
ch’a së spérd ant ël passà.
Da Ël Tòr N° 25 ~ 15 otóber 1946.
Poesie sparse sulle riviste e giornali piemontesi: Ël Tòr, Ij Brandé, Armanach piemontèis, Musicalbrandé. Nessuna raccolta di liriche piemontesi in volume.
Nella non copiosa ma caratteristica e assai vigorosa letteratura valdostana, la figura di Eugenia Martinet si è precisata con un volumetto di versi intitolato La Dzonére entzarmaie (La Dora stregata). Queste 18 poesie furono per molti dialettisti una rivelazione, a cominciare da Filippo Fichera che, nella cordiale prefazione, la definì «prezioso frutto di poesia vera… che, pur con l’uso dell’infingimento e di una tecnica fine, crea un’atmosfera di rapimento, una nuova coscienza di realtà». Tecnica fine… La ragione era dovuta al fatto che la Martinet non si trovava ad un incontro occasionale con la sua poesia che già aveva manifestato precedentemente con un libro di versi italiani dal titolo Primo dono, lodato dalla critica, e, in particolare, da Giovanni Bertacchi. L’idioma valdostano, eletto successivamente ad interprete del suo mondo lirico, è stato per lei una necessità: la necessità di comunicare con maggior immediatezza con il suo fiume, le sue montagne, i suoi ghiacciai, le sue vallate. E da questo diretto colloquio della sua voce interiore con le voci del suo paesaggio è nata una singolarissima poesia: quella che ha ormai collocato questa poetessa in primissimo piano nel movimento letterario della sua regione. Donna di rara cultura e di raffinati gusti intellettuali, la Martinet non poteva esimersi dal vestire la sua ispirazione «indigena» con una forma impeccabilmente elegante: di un’eleganza vigilata e personale…
Luigi Olivero da Ël tòr N° 13 del 13 avril 1946.
bat le flan regotà
contro lo véntro deur de la montagne.
La Dòira ancërmà
Prè Saint Didier, cost ann toa dòira orgojosa / a bat sò fianch ariss /
contra lë stòmi dur ëd la montagna.
«L’est magara cit an que vout se fëre épaousa»
Lo triolet di prà
i boueisson lo diave di s-olagne.
«A l’è magara st’ann ch’a veul fesse sposa!» / Aj lo disia ‘l tërfoj di pra /
a le boschin-e dle nissòle.
Lei répondon le beuble garfoueillen pe le gnoule:
«Dei que freida et levetta
in dzaratten din la gavie de glliasse.
saoute de foura come un aouseillon, pouè poule
beuchen di s-onde, netta
tot a ran di rontzet, et passe passe…
a sauta fòra come n’osletin, peui a robata / an sbatend j’onde fòrt,/ rasent al giairon, e a passa a passa...
dei amon, eido-vo, l’est dza totta entsarmaje!»
Pe de què cetta ronfa
di viou s’arbé que la bise gateuille ?
da lassù vëdde un pò, l’é già tuta ancërmà!» / Ma perché costa stòria / di vej arbron, che la bisa a gatija?
«In saccagnen le berrio desot l’equeuma blaje
treine bà cella confla
crâma de sabla blonda, que s’apeille
i gosail tot di lon. Tzouye! La blantze étoula
s’étrache su lo bor
di grou ellapei, me llié verrie la crëta
senssa fin al rivass. Vardte! La stòla bianca / a së s-cianca an sël bòrd / dël ciaplé, ma chila a gira la crësta.
rontze i velu di roc la vieille camesoula.
Et vià pe lo dtor
de la botsaille téndre : eunna tempëta
e aj rusia a lë vlù dël ròch soa marsina frusta. / E giù per i bissa-bissòt / dla pinera tënnra: na tempesta
de voèlo pèce et blan danche eunna cörsa leina
tanque i saat di tzanté.
Lè, feit un vaoulo avouè le s-äle iverte
que lei töte lo fla, me recomènche a peina
totze i fon. Anco-më
bà pe le combe avouè le s-ombre verte
ch’aj gava ‘l fià, ma pena ch’a torna ancaminesse / a toca ‘l fond. A torna giù / per le combe con j’ombre vërde
écretten la barbute tavannaje de tarmo.
Et l’eigue de miedzor
et l’eigue de mienet pe lo vallon
sbrinciand i buatass ancantà da l’anciarm. / E l’eva ‘d mesdì / e l’eva ‘d mesaneuit per ël valon
totzor la mëma bride et lo mëmo vacarmo…»
O! Le beublo son chor,
confondon tot! Me lo tsassot di pon
sempre l’istess armor e l’istess rabel…» / Oh! J’arbron a son ciòrgn, / a confondo tut! Ma ‘l gargojé dël pont
dit: passade passade, et no passen dessu
atot le tsasse écheutte.
Ara si pà se fa me baillé lagne
A dis : passé passé, e noi ij passoma anssima / con le braje suite. / Ora sai pa s’i devo geneme
Avouè mon arrojaou coure a l’inçon di ru
di degotsane meutte
pe eivié tot mon courti de la montagne,
‘D core con me bagnor arlongh i ri / di mojiss silenssios / per seivé tut mè cit òrt ëd montagna,
que din lo clliap antecco
l’est maque un cröé planten de baselecco.
che ant ël vas antich / a l’é mach na strìsola piantina ‘d basilicò.
Dialetto valdostano; traduzione di Pinin Pacòt.
Da Armanach piemontèis per il 1934.
De tèt, de meur et de reuvèlle dreite.
Jaou reston-të cice de Martinet ?
De meur, de tèt…
Inque an porta d’eun péillo, et gneun dedeun:
quaque pinne pieuquén desot la tabla
vouëre de sabla
Sì j’é la pòrta d’un pèilo e gnun an drinta:/ quaich galina ch’a picòa sot la taula / ‘d forvaje ‘d sabia
eun pailler bien garni de bléze frëtze,
et pas bëtza,
‘D polenta e ‘d pan. A mia drita / na fnera bin guarnìa ‘d maciaron fresch, / e pa na bestia,
o Palleusieux le grand, su ton tzemeun
trové quaqueun!
e la blòda campà là ‘n sël bion… / o Palleusieux le grand, su toa stra / trové quaicadun!
Vère euna fenna a la fnétra, eun rago
su le degré, den cice mëtzo gri
avei d’ami !
Vëdde na fomna a la fnestra, un cit an / s’i scalin, an coste ca grise / avei d’amis !
Pochei senti cella parola: «Entrade»
et s’achaté eun momen su le carraie.
D’atro, modeie,
dz’i pamë fata, et lo solei meussen
trepèlle sa euna coronna d’or
pe eun atro dzor.
I l’hai pi nen dë bsògn, e’l sol ch’a cala / as tira apres una corona d’òr / per una autr dì.
Eite eun ommo que veun pe la tzarrëre,
euna épala tzardzaie di floriau ;
se catza i baou.
J’è sì un òm ch’a ven per la carzà, / con na faudalà carià s’na spala; / a intra ‘nt la stala.
«Tzeut vià? Na. Quaque vioù, lo cordagnë
au femalla malada. A reterié,
vià in tzan, eivié,
«Tuti via ? Nò. Quaich vej, ël ciavatin / na fomna malavia. A fné / pr’i camp, a seivé,
fëre le ru et trëre le trifolle.
Mè, si lo guidi vioù, më dei lon ten
eun pic reuillén».
a fé i fòss e a cheuje le patate. / Mi son la guida veja, ma da tant temp/ i son un pich rusnent».
(Dz’i tot refey l’arbro de parentà,
bettà a modo eun lavon, euna queusena,
petzouda mena
(I l’hai arfait l’erbo dla parentela, / butà a pòst un barba, na cusina, / la facina
d’eun gnaro, et totte le.s-épaouse, dz’i
souégna la place a eun frëre, a eun papagran…)
Totzo la man.
d’un gnèro, e tute le spose, i l’hai / soagnaje ‘l pòst a un fratel, a un papà-grand…) / Toco la man.
«Martinet? Si praou qui. Dzen d’en tzi nò,
më d’eun atro pay cetta fameuille:
amon, La Tsueille».
«Martinet ? Sai pro chi. Gent ëd ca nostra,/ ma l’è d’un autr paìs costa famija: / ‘d La Thuile, pi a mont».
Dialetto valdostano. Traduzione di Pinin Pacòt.
Da Armanach piemontèis per il 1936.
Voué, dze mécllio a la lettra imaginère
eun âma moqueusa et méchanta,
come lo veun quan sor cllièr de la teuna,
zecca deur a la lènga et i gorbé.
La lettera cattiva
Oggi méscolo alla lettera immaginaria / un’anima mordace e cattiva, / come il vino quando esce chiaro dal tino, / un po’ duro alla lingua ed alla gola.
Solei d’aouton, pà la force de fère,
merci lo reusen su la planta.
Le nët son frëtze et le dei de la leuna
l’an déperdu lo dzet de caressé.
Sole d’autunno, non ha la forza di fare / invaiolare l’uva sulla pianta. / Le notti sono fredde e le dita della luna / hanno dimenticato il garbo di accarezzare.
Quan l’est lo dzor de clliore et leiché tzére
l’espoèr sopendù su la ganta,
va-t-en solet, en covèn cetta épeuna,
va-t-en bossu, a force de meusé.
Quando è il giorno di chiudere, e lasciar cadere / la speranza sospesa sull’altalena, / vattene solo, covando questa spina, / vattene gobbo, a forza di pensare.
Dialetto valdostano. Traduzione di Pinin Pacòt.
Da Ël Tòr N° 13 ~ 13 Avril 1946.
Dzor d’iveur que son lon, quan l’an deut: di fourië !
Lo retouno di fon l’ëre prest a crié:
di fourië, di fourië!
Tè t’appreste la fa,
l’erba grama fâ bà.
La canzone di questa primavera
Eun que rable lo baou, l’atro rësse y paillèr;
tzeut le dò leur san praou la consegne de fèr :
di fourië, di fourië!
Remoua-te! Lè catzà
le-s-outì di sordà !
Uno che raschia la stalla, l’altro sega nel fienile; / tutti e due già san bene la consegna di ferro: / sta primavera, sta primavera! / Scostati! Lì nascosti / gli attrezzi da soldato!
Su la bèque la nei s’inmoncelle tappa;
lo travai vat arei, la pachence inmeurtìa.
Di fourië, di fourië!
Remoua-te! Lè catzà
le-s-outì di sordà !
Sulle cime la neve s’ammonticchia ben fitta; / il lavoro a rilento, la pazienza intirizzita. / Sta primavera, sta primavera! / Eppure, senti il passo / della ronda su e giù.
Caravanna de dzen que requeron la dima
et l’an tzeut su le den euna drola de grima…
Di fourië, di fourië!
Lo piolèt l’est plantà
deun lo tron reverrià.
Carovana di gente che richiedon la décima / e hanno tutti sui denti una ben strana smorfia. / Sta primavera, sta primavera! / L’ascia è piantata / nel tronco rovesciato.
L’est a nò, aprè leur, de treiné cetta via,
taconnen ousse et cœur et meison ecreilìa…
Le gran pon l’est saoutà !
Di fourië, di fourië!
Alte-là! Alte-là!
Tocca a noi, dopo il loro passaggio, di trascinare questa vita, / rabberciando ossa e cuore e casa sgretolata… / Il grande ponte è saltato. / Sta primavera, sta primavera! / Alto là! Alto là!
Montagnar! Partisan! Se rencontre euna patze,
tè e mè, tota a ran, no laven cella ratze
di fourië, di fourië!
Devetì, debottà
(Peplo) no sarèn délivrà!
(Partisan) no sarèn desarpà!
Montanari! Partigiani! Ora si incontra un patto, / tu ed io affiancati, laveremo quella macchia, / sta primavera, sta primavera! / Senza vestiti, senza scarpe / (Popolo) saremo liberati! / (Partigiani) saremo scesi dai monti!
Da Ël Tòr N° 21 ~ 15 Agost 1946.
La Dzouëre entzarmaje Poesie in dialetto valdostano Ed. Convivio Letterario Milano 1946
Meison de berrio meison de gllièse Poesie in dialetto valdostano Il Nuovo Cracas Roma 1964
Poèmes choisis Imprimerie Valdôtaine Aosta 1990
Poesie sparse sulle riviste e giornali piemontesi: Ël Tòr, Ij Brandé, Armanach piemontèis.
Mario Albano l’è rivà a la poesia passand travers al dolor, a la maladìa, a la mòrt. La sua vita e la contemplassion dla vita dj’àutri a l’han daje ispirassion e sentiment a le soe lìriche pì bele… Sostnù da na fòrta convinsion cristian-a, ël poeta a sa trové ant le miserie dla vita na spluva dë speransa che a-j fa ciàir e lo compagna da la stra bassa a la stra àuta, da l’ombra al sol.
Nino Costa Armanach Piemontèis 1941.
Mario Albano ha accenti di limpida semplicità. Egli raccoglie nel suo cuore, attraverso una sensibilità dalla freschezza quasi infantile, le disperate voci del mondo e le restituisce in versi di una fluidezza d’acqua corrente, trasparenti, ricchi di emozione e di sentimento.
«La poesìa dla semplicità» as peul definisse cola ‘d Mario Albano e ‘dcò la «semplicità dla poesìa».
Pinin Pacòt a trovava natural paragonala «a quaicòsa ‘d ciàir e polid e trasparent, come a podrìa esse n’eva corìa ant na giornà seren-a». Na definission giusta e bela che a rend bin l’arson e a pitura le nuanse che a carateriso la poesìa d’Alban, contut che a peusso soné semplicistiche o fin-a coma un bonari arconossiment ëd valor dë sconda man.
Cola ‘d Mario Albano a l’é «poesìa» con tuti i crisma purificant ëd la poesìa vera, cola che a l’é dzora a tute le mortificassion ëd le graduatorie.
Poesìa istintiva, frësca e natural, ma cudìa, sufrìa e filtrà.
A son pròpi coste qualità – so istint, soa frëschëssa e soa naturalëssa – che a peulo dé l’impression ëd debolëssa e d’ingenuità a l’òm complicà d’ancheuj, e a peulo esse considerà nen virtù ma difet.
Na poesìa che a podìa mach esse parèj përchè, coma soa poesìa, a l’era l’òm.
«…l’eterna gioventù dla poesìa!»
(Dalla poesia Le piante di Mario Albano in Canto ‘d cò mi!)
Camillo Brero in Ij Brandé – Armanach ëd Poesìa Piemontèisa – 1979.
a fà sò ravagi.
Le piante sburdìe
as piego, a trantolo;
le feuje passe
sle rame a tramolo.
Ël vent a crijassa
e, an dova ch’a passa,
a bsògna lasselo
ch’a sfòga soa flina:
pa gnun peul fërmelo,
chiel tut a ruvina !
Ant nòstr’esistensa
con furia e violensa
j’é ‘n vent ch’a dësbela,
ch’a frusta nòstr cheur:
sto vent ch’a flagela
l’é ‘l vent dël maleur!
Chiel gnente aj fa pena.
Se i seve formave,
con calma serena,
d’ bei seugn për l’avnì;
tut lòn ch’i sperave...
un sofi e j’é pì!
Le feuje sbatùe
a vòlo sperdùe;
a cròlo le rame
da j’èrbo strompà,
e as perdo le grame
speranse sugnà!
Da A Mistral ~ Omagi di poeta piemontèis S.E.L.P. Turin 1930. Ripresa in Canto ‘d cò mi! Ij Brandé Turin 1951. (Nuova edizione Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1986).
Nina – nana, giòja santa,
nina – nana l’é për tì.
L’é mamina ch’at la canta
për podèite fé durmì.
Nina – nana, an cel le stèile
son già pronte për la vjà,
son già greve le parpèile,
j’euj a veulo sté sarà.
Nina – nana mai finìa,
mach la mama a sa cantela,
l’é ‘na gossa d’ poesìa
sempre frësca, sempre bela,
Nina – nana che fortuna,
fin che al mond j’é gnun sagrìn,
fin ch’as deurm drinta na cuna,
fin che mama l’é davsin!
Da A Mistral ~ Omagi di poeta piemontèis S.E.L.P. Turin 1930. Ripresa in Canto ‘d cò mi! Ij Brandé Turin 1951. (Nuova edizione Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1986).
Stèile spatià ‘nt ël cel andova i vene,
bianche sorele
lusente e bele
e ciaire e pure për le neuit serene?
Forse ‘d fé bel i lasse ‘l Paradis,
e, tute quante,
i seve tante,
i vene a vié sto mond ch’a s’ansopis.
I sponte ‘nt l’ora che ‘l trafen a chita.
Che bela còsa!
Tut a ripòsa;
come la s’ciaire pasia nòstra vita!
Travers al vel dla neuit, con na cantada
legera e sclina,
për l’aria fina
av mando i grì sfacià la serenada.
J’aque ‘d cò lor, con la soa vos d’argent,
av canto ansema
sò gran poema
ch’a va ‘d sora dla neuit, portà dai vent,
e mi che iv guardo fiss, quasi a më smija
d’sentime ‘vsin
al vòstr ciairin,
portà su j’ale d’òr dla fantasia.
Portà su aut, e ‘ntant che ‘l mond a tas,
sola e tranquila
l’ànima chila
a viv ël sò bel seugn, d’amor e pas!
Da Armanach piemontèis per il 1935.
Sla pòrta ‘d soa casòta,
le man drinta le man,
lé fërma na vejòta,
sò sguard l’é fiss lontan.
Con tinte spàlie smòrte
da na vision lontan-a,
chissà che ‘d còse mòrte
la ment a dësdavan-a!
La prima età, l’amor,
le giòie dla famija,
peui… crussi, afann, dolor,
la mòrt, ch’a pòrta via!
Quanti parent pi vsin,
quante person-e amìe
ch’a l’han vorsuje bin
e ch’a son già sparìe!
Aj ved ch’a passo an fila
dnans a la ment e a piora
- Nossgnor - a dis fra ‘d chila -
pieme ‘d cò mi, l’è ora! -
Ma ‘nt col moment ardìa
na bela masnajin-a
aj sauta al còl e a crija:
- T’ veuj tanta bin, nonin-a! -
N’arsaut, un socrolon,
la nòna a strenz soa cita;
j’é al pòst d’una vision
la realtà dla vita.
E ades, la veja a gòd,
pensand che, an fond an fond,
per cola fior ch’a s-ciòd,
l’é ancora bel ël mond!
Da Armanach piemontèis per il 1938. Ripresa in Canto ‘d cò mi! Ij Brandé Turin 1951. (Nuova edizione Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1986).
sul brich an mes ai ròch, a l’é restaje
mach pi la baita veja, na caban-a
ch’a sa resiste ancora a soe bataje.
Pi gnun lassù!… La pòrta a l’é duverta;
l’invern l’è vnù, j’é n’aria da giassé,
la fiòca l’ha stendù la soa cuverta;
la baita a deurm, contenta ‘d riposé.
A deurm seugnand, stërmà sota la fiòca,
ël «bech» dle feje, ò na cansson bergera,
‘ntonà con grassia, al dindoné ‘d na ciòca,
e al bërboté d’un rì giù ‘d na rochera.
A deurm seugnand, cunà da la tormenta,
ël rabasté d’ij sòco e d’jë scarpon
s’ij ròch e s’ij ciaplé, e a deurm contenta,
perché a dësmentia d’esse a l’abandon.
Antant, ai tornrà prest la stagion bela,
ël seugn a torna a fesse realtà,
ël sol, pi caud, a torna a dësquatela
e chila, as n’ancòrs nen d’avei seugnà!
Da Armanach piemontèis per il 1941. Ripresa in Canto ‘d cò mi! Ij Brandé Turin 1951. (Nuova edizione Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1986).
Mama! Quanti ricòrd, quanti penssé,
a fa fiorì la ment, sta gran paròla:
i primi pass, quand che ‘ndasïo a scòla,
quand c’an tacava ‘d fela sagriné…
Anlora i l’ero cit e birichin,
chila an rusava, e peuj, quasi pentìa,
për nen guardene ‘d brutt, an soridìa
così fasïo la pas ant’un basin!
Ma s’ai ciamavo‚ ‘d noi, anlora peuj,
combin che fasso tanti barivej,
noi j’ero brav, inteligent e… bej;
i j’ero tut sò mond, j’ero i so fieuj!
Quand che da giovo ‘l sangh an fërmiolava,
e i primi amor a j’ero ‘d folairà,
la mama ant ël canton d’ij dësmentijà,
a na sufrìa tant, ma an perdonava!
Ma se, për mala sòrt, i ‘ncapitavo
n’amor falì, na quaich disilusion,
come i portavo an pressa nòstr magon
ant’ij so brass duvert ch’a në spetavo!
Parlavo nen, ma chila già savìa:
j’ero tornaje avsin, l’era contenta;
chila an guardava ant’j’euj, calma, passienta,
e për sò grand amor an compatìa!
Come che prima ancora ch’i nasseisso
chila an sentìa a vive dla soa vita,
così peuj sempre, e, fin-a a tant ch’an chita,
la mama a viv ëd noi, guaj se ai mancheisso.
Chila an proteg, combin ch’i l’abio tòrt,
chila an capiss, an les an fond dël cheur,
an lassa mai, ma ‘ntl’ora dël maleur
l’é ‘ncora pì davsin, pë dè confòrt.
Ma ven ‘dcò veja, e anlora ‘l so penssè,
l’é col ch’i peusso fesse na famija,
ch’i peusso vive tuti an armonïa,
che ij lasso i nòstri cit da poponé.
«Così, an disia, quand che mi mancrai,
sarai contenta ëd vëd-ve tuti unì;
voi aotri, con i cit, penssreve a mi,
e mi lassù pregand i vë spetrai».
A l’é për lòn, che s’an ven n’ora grama,
ò, quand che giovo ò vej, la mòrt an pïa,
anche s’a j’é pi nen, ant l’angonìa,
con l’ultim d’ij respir, ciamoma: Mama!
Da Armanach piemontèis per il 1942. Ripresa in Canto ‘d cò mi! Ij Brandé Turin 1951. (Nuova edizione Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1986).
Canto ‘d cô mi Poesie piemontesi Ij Brandé Turin 1951. (Nuova edizione Ca dë Studi «Pinin Pacòt» Turin 1986).
Poesie sparse sulle riviste e giornali piemontesi: Ij Brandé, Armanach piemontèis, Musicalbrandé.
Ed oggi?
Il primo di marzo del 1928 è nata una fiamma ad opera di Giuseppe Pacotto (Pinin Pacòt), Oreste Gallina e Alfredo Formica. La fiamma mano a mano ha preso vigore, è diventata luminosa, vivace, scintillante; sempre nuova legna si è aggiunta a renderla ardente. Il primo di marzo del 1928 è nata la rivista letteraria quindicinale Ij Brandé Arvista piemontèisa, cinque soli numeri e così finisce la prima serie. Pacòt non si da per vinto e trasforma la rivista in Armanach ëd poesia piemontèisa a cadenza annuale dal 1931 al 1938.
Incombe la guerra. L’attività culturale viene, per il momento, messa da parte o costretta a correre in ritirata.
A guerra finita, il risveglio. Per opera di Luigi Olivero, a Roma, nasce il 14 luglio del 1945 Ël Tòr Arvìsta libera dij Piemontèis, quindicinale che in 32 numeri, per un totale di 256 pagine, fino al dicembre del 1948, tanto spazio dedicherà ai poeti della Companìa; il 15 settembre del 1946 inizia con Ij Brandé Giornal ëd poesìa piemontèisa la seconda serie della pubblicazione del 1928, che Pinin Pacòt porterà indefessamente avanti quindicinalmente fino al 1957, con oltre 1.000 pagine di poesia e prosa piemontese.
Pacòt anche questa volta trasformerà il quindicinale in almanacco annuale Ij Brandé Armanach ëd poesìa piemontèisa e ne curerà la redazione fino alla morte del 1964. La pubblicazione passerà nelle mani di Camillo Brero fino al 2015, anno di uscita dell’ultimo Armanach.
Nel contempo Alfredo Nicola (Alfredino) pubblica tra il 1959 e il 1990 Musicalbrendé dove troverà anche spazio il tema musicale tanto caro al poeta. Con la morte di Alfredino l’avventura del Musicalbrandé da Torino si trasferisce ad Ivrea con La slòira che prosegue l’avventura iniziata da Nicola.
Dal 1983 Brero da vita a questa rivista che fino ad anni recenti era esclusivamente letteraria. Con il venir meno, poco alla volta, della partecipazione di Camillo Brero la rivista ha preso mano a mano un indirizzo non più esclusivamente letterario ma sempre più aperto verso nuovi contributi, forse più accattivanti per il pubblico di oggi.
Questo è quanto ha prodotto quella scintilla iniziale del 1928 ma oggi che rimane? Le due sole riviste in piemontese Piemontèis ancheuj e La slòira, con un numero limitatissimo, purtroppo, di lettori.
E le nuove leve? Nei due articoli che ho dedicato a La bela Companìa dij Brandé mi sono occupato degli arrivi fino alle presenze nell’Armanach Piemontèis del 1938 e di alcuni, Brero, Dumini, Alex, Prioli che mi sarebbe spiaciuto tralasciare. Molti altri si sono aggiunti, non voglio fare torto a nessuno e cito i primi due che mi giungono in mente: Barnaba Pecco e Bianca Dorato. Ma questi non sono i contemporanei. I nuovi aggiunti li si possono trovare negli Armanach e nella penultima pagina di questa rivista. Numericamente sono molti ma che eredità lasceranno?
Nei miei molti scritti per questa rivista ho sempre citato giudizi altrui senza mai aggiungere alcunché di mio. Per questa volta permettetemi un’eccezione.
Devo ammettere che leggendo queste poesie mai ho trovato le sensazioni, i sentimenti, le emozioni “il pathos” che mi hanno dato la lettura dei versi potenti, a volte roboanti ed arditi di un Olivero, l’incanto di essere solitario tra i monti con un sonetto di Mottura, la dolce melodia dei versi di Alfredino o la calma suadente, profonda e gioiosa di Carlottina Rocco…

Litografia di Orfeo Tamburi da Ël Tòr N° 2 del 15 luglio 1945